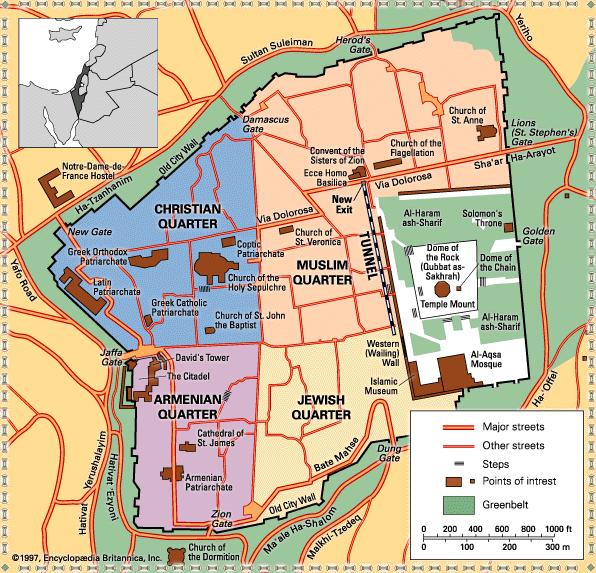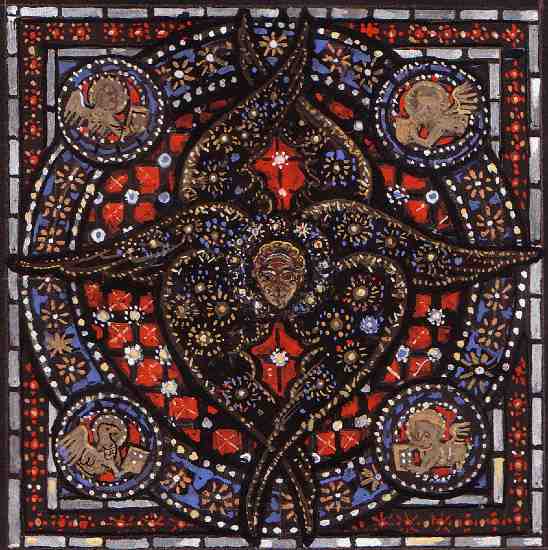I tre vocabolari della neolingua. L’associazione di sostantivo e verbo e altri sistemi per paralizzare l’intelletto. Rettifica della storia e mutabilità del passato. Guerra infinita e conflitto in Crimea. Codici giovanili, burocratici e scientifici. Materialismo dialettico e radicalismi di maniera. Politically correct, semplificazioni logiche, scorrettezze semantiche. Genitore 1 e 2 e la generazione umana. Liberazioni presunte e bioingegneria. Il latino nel mondo antico e moderno. L’esperanto tra le lingue. L’italiano lingua dotta. Manzoni e i dialetti. Il turco e l’ungherese. Opposizione letteraria: Pamuk e Altan, Mihály Babits. I bestseller, il pigdin, la dimora dell’Essere. Pacifisti, spie, industriali e punk all’ombra del Muro di Berlino. Beppe Grillo da comico serio a politico buffone. Le occasioni perdute del M5S. Le inadeguatezze nel web. Nessuna cortesia verso la “gultura”. Distinzione tra critica e polemica. “Controllo di qualità” e responsabilità personale. Attori ed eroi nei social network. Pierre Levy e il virtuale. Kenneth Goldsmith e la “scrittura non creativa”. Vikram Chandra e la “narraprogrammazione”. Bibisco, il “programma narratore”. Il congiuntivo: pensare l’irrealtà. Hugh Hopper e i paesaggi sonori dei ministeri del Socing. «Ci incontreremo nel luogo dove non c’è tenebra».
1. I rudimenti della neolingua
La neolingua è un dispositivo di semplificazione del linguaggio e manipolazione mentale che ha come sistema filosofico il bispensiero, ed è ad un tempo strumento e obiettivo del regime assolutista retto dal Grande Fratello; lo scrittore George Orwell ne considera gli aspetti teorici e le implicazioni operative, che si propongono di effettuare uno stretto controllo della realtà e sostituire completamente quanto è chiamato archeolingua in circa un secolo. Il saggio in appendice a 1984 (1949) e diversi stralci del romanzo, di cui la traduzione di Gabriele Bandini (1950) offre un adattamento attendibile, contemplano precisi studi di linguistica, analisi dettagliate degli aspetti grammaticali e sintattici attraverso i quali la neolingua si articola. Nel suo complesso, il libro affronta questioni proprie ad un orizzonte che è ancora il nostro e permette di scrutarlo anche dove non lo rispecchia.
Occorre valutare quanto nei linguaggi contemporanei possa riscontrarsi di tali caratteristiche: la questione, laddove vogliamo mantenere una capacità critica, è decisiva, ed è stata affrontata anche in La Siria, la guerra e l’informazione e Le parole del sesso taciuto. Siccome non mancano letture parziali delle tematiche che attraversano il romanzo, le precisazioni sono necessarie, così come una esposizione complessiva degli argomenti. Occorre inoltre ricordare ai maniaci delle semplificazioni a tutti i costi che non è neolingua cercare di sviluppare il discorso con gli approfondimenti tecnici opportuni, cercando però di non sciupare parole, per rispetto del proprio pensiero e chi lo leggerà; similmente, l’interpretare non è un esercizio arbitrario, ma richiede uno studio dei testi che, per quanto personale, esige sempre riscontri. Invece, laddove sia assente l’aggancio a riferimenti effettivi e si tenda a riportare il pensiero altrui esclusivamente alle proprie presupposizioni, viene impedito un confronto pertinente con le questioni di base, ed è proprio tale adulterazione a propagare una strana neolingua “dei poveri”.
La neolingua pensata da Orwell si compone di tre vocabolari, che nel contesto delineato dal romanzo sono già giunti alla loro decima edizione. Il Vocabolario A comprende le parole di uso comune, il Vocabolario B (detto delle parole composte) i termini politici, il Vocabolario C quelli di tipo tecnico.
Il Vocabolario A comprende tra le sue principali forme la riduzione dei significati dei concetti più articolati, di cui alcune espressioni si assumono la funzione di distruggerli: “giustizia”, “democrazia”, “scienza” e “religione” smettono semplicemente di esistere. Attraverso la soppressione di analogie ed etimologie tutte le sfumature di significato devono essere eliminate ed ogni sottigliezza impedita. «Parole indesiderabili» quali “libertà” diventano inconcepibili da usare rispetto a “libertà intellettuale e politica” e quindi al pensiero e alle azioni umane, e il loro impiego è limitato al senso che può avere una frase quale “il cane è libero da pulci”; così, “uguaglianza” si riduce a significare “coincidente”. La parola “pensiero” cessa di esistere grazie all’unione di verbi e sostantivi: “pensare” esprime l’uno e l’altro. I concetti opposti sono assimilati: per dire “cattivo” c’è “sbuono”, “buio” diventa “sluce”. Gli avverbi, tranne quelli che terminano in “mente”, sono aboliti: per dire “bene” si deve dire “buonamente”.
Il Vocabolario B si compone di amalgami nome-verbo che prescindono da qualsiasi preoccupazione etimologica, ed assimilano le funzioni sintattiche riducendo il più possibile ogni variazione di senso. L’ortodossia politica e intellettuale si esprime come “pensabuono”, al passato e participio passato “pensabuonato”, al participio presente “pensabuonante”, come aggettivo è “pensabenista”, come avverbio “pensabuonamente”. L’indipendenza di pensiero è un delitto definito “psicoreato”. Il Vocabolario C contiene termini d’uso specialistico purgati da ogni interesse di tipo universale e quindi dell’idea stessa di scienza. Parole come Socing (Socialismo inglese totalitario, modellato sull’esempio dello stalinismo) condensano un’intera visione del mondo.
Il linguaggio viene progressivamente impoverito in struttura e numero dei vocaboli, il parlare perde connessione con l’attività cerebrale per ridursi ad una specie di starnazzo, definito come “ocoparlare”. In meno di un secolo, le parole della neolingua avrebbero sostituito tutte le parole d’uso comune, i termini tecnici e l’intera storia della letteratura attraverso una precisa “ingegneria” intenzionata ad eliminare processi mentali complessi: già l’associazione di sostantivo e verbo fa capire a quale tipo di paralisi si vuole assoggettare l’intelletto. E infatti, «ortodossia significa non pensare».
Questi e altri accorgimenti, capaci di «rendere impossibile ogni altra forma di pensiero» rispetto a quello dominante, si collegano al controllo mentale e al dispotismo politico. Ciò è evidente dove la forma di bispensiero formulata «ricordando e dimenticando simultaneamente» permette di asserire il dogma centrale della «mutabilità del passato», favorendo una continua «rettifica» e riscrittura della storia capace di assecondare gli equilibri di potere del presente e la programmazione del futuro: e questo anche nei ricordi personali.
Tale rielaborazione del passato è oggi compiuta ad ogni livello e spesso anche inconsciamente laddove la storia assuma un particolare carattere “monumentale” di compiacenza nei confronti dei poteri costituiti e così gli si consenta di schiacciare il passato sull’immagine dell’attualità. Il caso più clamoroso offerto dagli eventi degli ultimi anni è quello dell’11 settembre, per il quale probabilmente non esisterà mai una “verità” definitiva, ma la condizione è ormai paradigmatica. Infatti, ormai luoghi, relazioni, persone, epoche intere, possono sparire come mai esistiti, mentre cose mai esistite acquisiscono certezza incrollabile. Per molti, non è mai esistito nulla a parte il proprio bisogno, e così come la crisi diventa una condizione permanente si vuol vedere abbondanza dove c’è la miseria. Tutto questo allontana da noi una storia che, invece, dovrebbe rendere giustizia alla ricostruzione di quanto possa essere stato, in modo da rispondere alle interrogazioni del presente per tentare di creare lo spazio di un futuro ancora non scritto.
Le forme del bispensiero espresse nella neolingua non rientrano nella retorica tradizionale Infatti, la capacità di dissociazione a cui induce la neolingua non esprime paradosso, ossimoro o litote, non riguarda la posizione di un’antitesi dialettica e neanche dichiara qualche assurdità constatata esistenzialmente. Tali argomenti richiedono particolari confronti con le preoccupazioni filosofiche di definire il senso dei principi di identità e non-contraddizione e del rapporto tra soggetto e predicato. Nei piani stabiliti da Orwell nel suo romanzo, neolingua e affini esprimono semplici idiozie, in senso etimologico “assenze di un qualcosa”, e si compongono di asserti formulati in modo da distruggere il significato e far implodere il contenuto informativo dei messaggi. Con le parole dello scrittore britannico: «non solo il valore dell’esperienza ma persino la stessa esistenza della realtà esterna era tacitamente negata dal loro sistema filosofico.»
Questi messaggi sono diffusi nel linguaggio dei media e nel buonsensismo quotidiano laddove formulette omnincludenti e autoassolutorie credono di risolvere una realtà complessa e permettono che il significato logico di una parola e il senso preciso dell’oggetto o dell’evento designato svaniscano a favore della sua sovraesposizione emotiva, rendendo difficile che una posizione possa essere effettivamente argomentata, discussa, indagata. Così nella comunicazione, in genere si parla troppo per non dire nulla, il “niente da dire” è radicale, e nell’interminabile moltiplicarsi delle opinioni e nell’inflazione delle posizioni diventa più che mai labile il confine tra il falso e il vero, comportando una riconsiderazione del ruolo del “verosimile”.
In questo cambiamento di rapporti funzionali tra vero e falso, il motto “la guerra è pace” descrive le condizioni della “guerra infinita”, chiamata così tanto nel mondo di Orwell quanto nel nostro, e questa indica il superamento della tradizionale divisione tra conservatori e progressisti. Infatti, con il consenso di ambedue le posizioni, il discorso sulla guerra e la sua realtà si complicano, mentre «pratiche da lungo tempo abbandonate, in taluni casi per centinaia di anni, come carcere preventivo, l’uso di prigionieri di guerra come schiavi, le esecuzioni pubbliche, le torture per sollecitare le confessioni, l’uso degli ostaggi e le deportazioni in massa d’intere popolazioni, non soltanto divennero nuovamente comuni, ma furono perfino difese e tollerate da coloro che si consideravano liberi e progressivi.» Sussiste inoltre sempre una sproporzione della considerazione delle parti in causa, che falsa la ricezione dei conflitti: ne è un’esempio anche la considerazione mediatica del conflitto in Crimea, che nega preliminarmente le ostilità subite dai filorussi.
Rispetto alle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione, 1984 avvisa che rendono “più semplice il compito di manipolare l’opinione pubblica”. Tuttavia, il controllo sociale da solo non basta: c’è da parte della popolazione un’enorme componente di compiaciuta disponibilità ad essere manipolati. Ma criticarlo non significa sostenere che il potere sia per natura corrotto, oppure, com’è nella forma più plebea, stare sempre a lamentarsi: significa essere vigili ed esercitare la capacità di distinguere.
Nel mondo di Orwell lo scrivere è quasi integralmente sostituito dal dittografo, che permette di scrivere sotto dettatura; usare carte e penna è considerato sovversivo: non propriamente illegale, perché leggi non ci sono, ma comunque punibile anche con la morte, o meglio con l’annullamento. Oggi, la scrittura per tastiera è di fatto obbligatoria: tuttavia, spesso non è “scrittura”, in quanto spesso si dimostra priva della concentrazione e della lucidità che dovrebbero caratterizzarla, e piuttosto si configura spesso come una distrazione presuntuosa, complice con il proprio stesso inganno.
Certe condizioni conducono così ad un’inibizione controllata delle proprie capacità mentali induttive e deduttive, portando, come descritto nel romanzo, a non cogliere le analogie, a non percepire gli errori logici, a equivocare gli argomenti più semplici, a provare avversione verso qualsiasi tentativo di elaborare una dialettica di pensiero capace di condurre oltre la supina accettazione dell’esistente. Siccome l’esistente viene ormai subìto molto aldilà delle capacità d’adattamento compatibili con la dignità umana, e nel confusionismo prevalente la logica diventa un optional che scavalca di molto le preoccupazioni di comprendere i limiti dei principi di identità e di non-contraddizione, la neolingua è, più che una certezza, una pratica diffusa in diversi ambiti. Eppure, non tutto è neolingua.
2. Cosa non è neolingua
L’uomo parla dove c’è una lingua. Anche una lingua parla, permettendo al pensiero di formularsi. La neolingua riduce il pensiero eliminando le parole. Ad esempio, ostinarsi a scrivere proprio mentre si svaluta la scrittura produce una neolingua involontaria. Una scrittura limitata a criteri vitalistici e di “comunicazione” propaga la riduttiva convinzione che davvero ognuno abbia una lingua a sé e ogni parlare sia un atto esclusivamente autoreferenziale, condannandosi a parlare in un mondo popolato di neolingue. In questo modo, si annulla ogni cosa possa essere stata detta, facendo comprendere che a valer poco sono le proprie stesse parole.
Per non cadere vittime della neolingua, tentiamo di ricordare sapendo di ricordare, e impegniamoci nel diffondere riferimenti fondati, senza appiccicarli alle nostre preferenze prima di averli compresi. Per non incorrere in supponenze fuorvianti su cosa sia o non sia neolingua, occorre individuare gli elementi distintivi, contenuti nei testi. Orwell espone nel romanzo, e nelle sue sezioni teoriche, la portata di quei meccanismi linguistici e di pensiero che comportano la distruzione del significato e che concorrono alla conservazione dello status quo; questi sono attivi sopratutto nell’informazione, e contemplano in maniera particolare il contenuto informativo d’ogni singola parola, il rapporto tra sostantivo e verbo e quello tra lessico e universalità.
Nessuna interpretazione “traslata” può astrarre dalla considerazione di tali elementi, che permettono di distinguere gli effettivi usi manipolatori del linguaggio. Composizione e architettura del romanzo fanno comprendere che Orwell era piuttosto accorto, e peraltro nel regime da lui descritto l’aderenza ai testi originali era proibita così come sembra impossibile nel sistema dei media. Nel rispondere a quanto è scritto, e non a quello che vogliamo leggere, si cerca d’essere fedeli alla realtà, esercitando una libertà che chiede disciplina.
Lo slang giovanile, così come ogni gergo settoriale, per quanto riduttivo possa essere, non è neolingua, in quanto non s’impone alla realtà tutta con la pretesa di manipolarla a favore di un potere istituzionale. Il linguaggio burocratico potrebbe avvicinarvisi, ma non riguarda né il pensiero né la vita quotidiana, e il suo impiego è concentrato in atti che si traducono in decisioni concrete. Quello attribuito allo stereotipo, ormai datato e falso, del carabiniere ignorante, mette al sicuro da manipolazioni proprio perché fa ridere. Le lingue straniere, dove studiate e comprese, aprono altri campi e arricchiscono il pensiero; ancora di più, permettono tale apertura i codici filosofici, artistici e scientifici, dalla semantica inesauribile, così come i simboli di cui si compongono le religioni storiche, riferiti ad un’universalità non riducibile a letture integraliste né a semplificazioni new-age.
Per le letture riduzioniste della scienza, il mondo si spiega con poche formule. Se un mondo che cambia esige un pensiero in grado di rinnovarsi di continuo, la propagazione del riduzionismo porta la realtà tutta a impoverirsi ai criteri di numero e calcolabilità. La distruzione del reale e del simbolico favorisce visioni parziali e razionalizzazioni forzate che pretendono di imporsi alla realtà ignorando però la consistenza. Tale forma di dittatura ha ancora forte presa, ma il potere costituito può trovarvi un alleato prescindo dalle sue premesse e implicazioni. Anche una delle sue forme più tipiche, quali il “peso logico” del dicibile di cui argomenta il Tractatus logico-philosophicus (1921) di Wittgenstein, risulta troppo complesso, e le sue esigenze di chiarificazione sono lontane dalle esigenze strettamente politiche.
Una lingua capace di pensiero si articola con un linguaggio ricco di sfumature ma concreto, non riduce le complessità ma le espone limpidamente, ha agganci con ricerche ed esperienze degne. Per affrontare le sfide attuali è necessario depurare le esigenze di scientificità e di farsi le domande giusto dalle interferenze riduzionismo, e mantenere un aspetto pubblico e politico del pensiero demistificando le ideologie, piuttosto che giustificarle. Inoltre, aldilà tanto dei pregiudizi anticlericali quando degli aspetti confessionali, è necessario comprendere le questioni religiose quali forme culturali complesse, irriducibili ad una boccata di oppio o al proprio convincimento: lo stesso mondo secolarizzato deve essere interrogato sulla permanenza di archetipi, riti e tradizioni.
Occorre assolvere anche il materialismo dialettico dall’imputazione di neolingua, recuperando l’intento marxiano di formulare un metodo di comprensione in grado di criticare la parzialità delle formazioni ideologiche a favore di un’antropologia integrale. Orwell detesta lo stalinismo e ne considera tutti limiti, ma non prescinde mai da un socialismo democratico e dall’esigenza di analizzare condizioni e apparati di potere per riorganizzare la massa dei “prolet”, nonostante i proletari, nel romanzo e nella realtà, siamo spesso piuttosto inclini alla loro stessa sottomissione. Inoltre, il marxismo non comporta una riduzione del linguaggio ma piuttosto elabora un codice molto articolato, nel quale convergono diverse tradizioni filosofiche; persino Stalin, in un’intervista alla «Pravda» del 20.06.1950 evitava di relegare il linguaggio a semplice sovrastruttura. Tuttavia, il pensarlo come elemento comune ad una popolazione e connesso al pensiero e allo scambio di pensieri, lo riduce, com’è comunque tipico del progressismo datato, a semplice strumento di comunicazione.
La società di 1984 negava una vita sessuale e in maniera particolare l’erotismo, e sottrarre la sessualità alla riproduzione significa incappare nel reasesso. Oggi il sesso è sganciato dalla generazione ma spesso è ridotto a ginnastica, vanificando la stessa tensione erotica, mentre la «dignità di commuoversi» sparisce insieme agli aspetti di «segretezza, amore e amicizia», così come già Orwell intravedeva. Inoltre, fenomeni sociali viziati da dipendenza da contrapposizione quali femminismo e genderismo, apparentemente configuratisi quali pratiche di liberazione, fanno comprendere che, anche al di là dell’aspetto sessuale, le forme dell’antagonismo di maniera non sono mai davvero radicali e d’opposizione quanto vorrebbero, per essere piuttosto in sottile sintonia con il banale permissivismo neoliberista.
Infatti, dove la rigidità maschilista è boriosamente assunta dalle donne in carriera e esistono maschi a cui è sufficiente cambiare un paio di mutande per sostituire integralmente la donna, si riscontra l’incapacità di pensare la realtà e gli opposti nel loro significato effettivo, già denunciata in altri termini da L’anticristo (1888) di Nietzsche. In generale, il “rivendicazionismo“ contemporaneo e tutte le sue ingenuità spesso si preoccupano di creare nuove categorie di consumatori-elettori, contribuendo alla degenerazione che ha permesso di ridurre il diritto al – per dirlo in metafora – poterlo prendere in culo: si trattasse proprio di bispensiero, invece di chissà che? Affine a queste posizioni è l’animalismo, che invece del genere contesta la specie, per poi proiettare sulle bestie caratteristiche umane: piuttosto di recuperare gli atavismi animali, si configura come fenomeno regressivo. Se queste sono le forme del “neomatriarcato”, che restino a casa a fare la calzetta senza cincischiare troppo in giro; se queste posizioni vorrebbero proporsi come emancipatorie, la realtà, che si differenzia a prescindere da antagonisti e divergenti, è già più avanti di tutto questo, ma del resto anche in Orwell i sostenitori più ottusi del potere sono donne e bambini.
Ad inibire il pensiero e a limitare la comprensione della realtà sono quindi soprattutto integralismi e new-age, radicalismi e infantilismi, linguaggi mediatici e propagande di ogni tipo, conformi all’intento della neolingua di eliminare persino la «possibilità di intendere che il mondo potrebbe essere diverso da quello che è» e parallelamente permettere di esprimere «opinioni corrette in modo automatico», indispensabile per chi vuole avere un ruolo nel sistema vigente. Ciò si può compiere anche facendo anche scempio del linguaggio comune, non serve “riscrinter pristes supautor anteclucoll (riscriverlo da capo e sottoporre tale prima stesura all’autorità superiore prima di includerla nella collezione).”
3. Correttezze politiche e inibizioni di pensiero
Non è possibile prescindere dal linguaggio nel considerare gli ambiti sociali, e questi possono permettere di riflettere sulle caratteristiche del controllo individuate da Orwell. Dove la neolingua si preoccupa di controllare e modificare la realtà attraverso l’uso di un linguaggio stereotipato e pregiudiziale, trova impiego affine alle prescrizioni del politically correct, diffuso negli anni ’80 e’90 nei college americani in sostegno delle politiche identitarie per esprimere un contropotere, grazie al quale la società sarebbe cambiata in virtù di manipolazioni sulla sua immagine intenzionate ad eliminare ogni tipo di offesa verbale vera o presunta.
Naomi Klein osserva come il politically correct sia stato sconfitto dal suo inconcludente narcisismo e dall’assimilazione alle pretese del marketing; ancora oggi, l’idiotismo semplificatorio del radicalismo di maniera privo di disegno politico si rovescia in un conformismo ancora più radicale di quello a cui si oppone. Il più trito politically correct non sfugge da un lessico stereotipato e spersonalizzato ed è affine alla new-age nel ridicolizzare ogni tentativo d’approfondimento come inutile complicazione. Il messaggio proposto sembra palesemente “orwelliano”: la fatica del pensiero va abolita, l’impegno del leggere è aborrito, quello dello scrivere è roba da stronzi. Nello scrivere bisogna essere, più che semplici, semplificatori, alla faccia della realtà: riduzionisti oltre ogni elementarità e a prezzo di descrizioni poverissime. Quindi, con una parola che non si ammetterebbe mai di mormorare, vengono mandati a fanculo studio e conversazione colta, ammissibili solo nel salotto di casa o sui libri degli scrittori morti.
Pur aggrappate ad ogni più insignificante particolarismo, queste posizioni assecondano gli aspetti peggiori di un mondo che pretende conformità: a chiedere ciò non è il Socing o chi per lui, ma il livellamento a cui conduce l’introiezione delle leggi di mercato, solennizzate dalla dissoluzione dei contenuti inoltrata dalla cosiddetta “comunicazione”; a tale ricatto si corrisponde anche mantenendo intatto il tradizionale panegirico sulla “decadenza” di questo e quello, al cui gioco comunque ci si presta. Tuttavia, il pensiero non può articolarsi dove è privo di termini e riferimenti appropriati, non può procedere ignorando di cosa parli oppure senza nemmeno volerlo comprendere. Inoltre, oggi più che mai, i dati sono reperibili a chiunque e scioglierne i nodi è interesse collettivo, indispensabile per interpretare il mondo e, forse, cambiarlo. Il problema è però che nella normalizzazione linguistica e di pensiero si è così immersi da non riuscire nemmeno a riconoscerla.
La pretesa di rivedere i termini di base per decisione amministrativa rientra nel campo della neolingua. E così, donsiderare «discriminatorie e obsolete» le parole “padre” e “madre” presenti sulla modulistica scolastica, come ha affermato a suo tempo il ministro Kyenge, significa, se la nostra logica è in grado di distinguere, che le diversità effettive invece di costituire una ricchezza reciproca siano una vergogna, con implicazioni in piena contraddizione con la retorica della differenza. Piaccia o meno, padre e madre hanno significati più ricchi di “genitore 1” e “genitore 2” e la capacità di generare la vita non è un’inezia: per quanto esistano codici culturali e pur ammettendo la sussistenza reciproca del femminile nel maschile, padri femminili e via discorrendo, è l’effettiva esistenza dei generi che permette di comprenderne l’unione possibile, simbolica ed archetipica, senza mescolarli a casaccio o annullarne le distinzioni (lo possono ricordare, tra gli altri, Baader, Weininger, Jung).
Se davvero la differenza muove il mondo, è importante non cadere da un pregiudizio ad un altro. Permettere comprensione e scelta significa anche non confondere fatto con diritto. Senza valutazione responsabile non c’è futuro: tutto ciò oggi è assente. Ritroviamo il coraggio di pensare, oltre i vecchi e nuovi conformismi. La difesa della specificità della generazione umana contribuisce a salvaguardare la stessa possibilità dell’umanità di sussistere e crescere: l’opposizione a tale realtà è destinata a incorrere in miraggi che realizzano il contrario di quanto si propone. Il regresso all’infinito a cui apre il politically correct è evidente: 1 e 2 esprimono una scorretta preferenzialità numerica, la parola “genitore” appartiene indecorosamente al genere maschile: e poi? Peraltro, le sue prodezze linguistiche non sono fini a se stesse, ma preparano a figli fatti più o meno come si ordinano le pizze: donazioni di sperma, uteri in affitto, provette e altre autentiche oscenità.
Non sembrano queste le condizioni a favore dell’antagonismo politico o dell’evoluzione sociale: piuttosto, nell’estendersi di fenomeni già piuttosto diffusi quali medicalizzazione della vita e mercificazione dell’infanzia, si profila il dominio assoluto della bioingegneria e del capitale finanziario sulla vita e sull’esistenza. Ed è probabilmente per questo, e non per difendere le persone omosessuali, degne come tutte le persone di diritti e tutela, che ogni discussione relativa a certe presunte liberazioni è diventata così controversa. L’esigenza di interrogarsi sui propri presupposti è imprescindibile per una cultura autentica. Laddove questo interrogarsi sia assente, occorre chiedersi: cui prodest?
Mentre i ragazzi vanno ai cortei del gay pride con la stessa apertura mentale con cui i loro nonni andavano alla processione di San Quintino e alle parate del Duce, la paralisi s’insinua nel pensiero, la realtà subisce immiserimento, si impone la paranoia, è impedito ogni ragionamento che possa dare luogo a confronto e nessuna opinione diversa è ammessa. Infatti, con la parola “omofobia”, che ha peraltro significato opposto a quello che gli si attribuisce (infatti vuol dire “odio del simile”) la neolingua del politically correct arriva a stigmatizzare non le violenze, comunque da condannare, ma anche ogni minima posizione critica su questioni che riguardano la società nel suo complesso. Ogni più elementare discussione è impedita da un’isteria incapace di ammettere repliche, come accade nel «coro delle esecrazioni» che coinvolgono la popolazione di 1984 nei Due Minuti d’Odio.
In tale uso del linguaggio, l’intento di argomentare e descrivere la realtà decade, a favore dell’affermazione di un potere indiscutibile, forte del consenso autogenerato dal proprio ambito di appartenenza: la “verità” è un fenomeno locale e di cortile, cosa mai può importarci di altre considerazioni? In questo modo, sembra a rischio proprio la democrazia nel cui nome si pretende di parlare; prosegue in un’intervista Roger Scruton, mettendo in guardia dai nuovi conformismi intellettuali falsamente progressisti: «La neolingua nega la realtà e la indurisce, trasformandola in un qualcosa di estraneo e resistente, un qualcosa ‘contro cui lottare’ e che deve ‘essere vinto’. Il linguaggio comune riscalda e ammorbidisce; la neolingua raggela e indurisce. Il discorso comune genera, con le sue stesse risorse, i concetti che la neolingua proibisce: corretto-scorretto; giusto-ingiusto; onesto-disonesto; tuo-mio.» Scrive il protagonista del romanzo Winston sul suo diario: «La libertà consiste nella libertà di dire che due più due fanno quattro. Se è concessa questa libertà, ne seguono tutte le altre.» Oggi è pieno di scemi che si sono fatti convincere che 2+2=5, e guai a contraddirli.
4. Il latino e l’esperanto: collanti e computazioni
Alcune lingue hanno esercitato, ed esercitano, la funzione di collante tra popoli e culture: tale aspetto è estraneo alle caratteristiche della neolingua. È un vizio ideologico meschino quello di leggere le epoche passate con le deviazioni della nostra estendendo una dannosa logica del risentimento anche alle epoche passate. Una lingua antica nutre il pensiero con la storia e ne apre le prospettive, la sua sopravvivenza permette alla civiltà di mantenersi. Sotto i Romani la diffusione del latino dipese spesso più dal prestigio, come nell’Illirico, che da una imposizione, avvenuta in Gallia. I popoli aderivano all’Impero anche per i vantaggi che comportava, e se tutto accadeva con riferimento a Roma, altri centri non si sentivano sminuiti, traendone anzi segno di coesione. Dobbiamo sicuramente vedere i limiti delle passate civiltà, interrogare le ceneri di Cartagine, effettivo centro del Mediterraneo, ma senza restringerne la portata complessiva in nome di un revisionismo da sfigati.
Nel mondo antico, il latino ha prevalso come lingua amministrativa, ma in diversi centri, legati all’ellenismo, e per autori importanti, tra cui Plutarco e Marco Aurelio, s’è a lungo conservato il greco, il quale dopo l’imperatore Eraclio diventò lingua ufficiale a Bisanzio, mantenendosi per secoli e trasmettendo alcune caratteristiche anche all’arabo e al cirillico. Il falisco, l’etrusco, il glacolitico, e mille altre lingue, non sono scomparse per qualche genocidio o altre cattiverie, ma perché anche le lingue hanno i loro periodi storici; inoltre, come insegna la stele di Rosetta e la traduzione dei geroglifici, lingue di riferimento sono indispensabili per compiere decifrazioni. Un’unica lingua non esisterà mai, ed è però molto utile che un codice linguistico possa costituire un riferimento comune: non soltanto per la scienza, ma anche laddove qualsiasi persona non voglia costringersi a passare la vita intera al paesetto con gli amici d’infanzia.
I tedeschi colti conoscono bene tanto il greco quanto il latino, che hanno influenzato in modi molto relativi la loro lingua, e nella storia i popoli germanici si sono decisamente impegnati per far rinascere l’impero: persino i sovrani sassoni, popolazione cristianizzata soltanto con Carlo Magno, per riunire l’eredità intera di Roma tentarono ripetutamente di imparentarsi con i bizantini; infine, il mezzosangue Ottone III nell’anno Mille pose la capitale imperiale all’Urbe, poi contrastato dai particolarismi cittadini: genti di Tuscolo e di Tivoli, che chissà che lingua potevano parlare già da allora. Il latino, d’estremo aiuto per logica e ragionamento, in Germania e Francia è stato a lungo utilizzato per la realizzazione di tesi e dottorati, in Ungheria è stato impiegato negli atti ufficiali fino al 1870, ed ha costituito la lingua della liturgia cattolica fino al Concilio Vaticano II: un carattere “vivo” lo ha quindi mantenuto a lungo.
L’uso del latino nella liturgia non è forma di controllo: piuttosto, mantiene il potere evocativo delle parole sciogliendole da un uso strumentale, così come nei mantra così apprezzati dagli amanti dell’esotico. Se la revisione dei testi sacri ha accompagnato la formulazione della religione cristiana, la non-esistenza di una parola scritta da Gesù mette relativamente al riparo dall’integralismo; inoltre, molti insegnamenti sono stati trasmessi per immagini, permettendo una straordinaria fioritura artistica. Indubbiamente la cultura protestante deve il proprio grande sviluppo alle traduzioni della Bibbia inaugurate da Lutero; tuttavia, questo ha portato anche ad un proliferare di sette, e infatti la parola “fondamentalismo” è nata presso gli evangelisti americani; inoltre, Jung aveva visto il mondo protestante svuotarsi progressivamente di contenuti per aver ridotto la sacralità di elementi che nel cattolicesimo sono ancora attivi e operanti.
L’esperanto è una lingua “pianificata” le cui forme e regole si basano su idiomi etnici preesistenti. Per quanto sia una lingua “nuova”, è una lingua viva e non ha le caratteristiche di annullamento del significato e di controllo mentale e sociale della neolingua. La derivazione di sostantivi, aggettivi, avverbi e verbi da una medesima radice messa in gioco dall’esperanto non è l’assimilazione del verbo al nome, la riduzione degli opposti ad uno, l’abolizione degli avverbi teorizzata da Orwell, che con tali dispositivi suggerisce anche che il cattivo uso del linguaggio riduce le capacità di pensiero. Soprattutto, a differenza della neolingua, l’esperanto non vuole imporsi alle altre lingue per annullarle: pur ponendosi come loro sintesi e minimizzandone ambiguità e sfumature, intende proprio preservare le differenze. Il suo ideatore Ludwik Lejzer Zamenhof, che si faceva chiamare dottor Esperanto, intendeva elaborare uno strumento semplice ed espressivo per migliorare la reciproca comprensione tra popoli, evitando sudditanze culturali e anche proteggendo gli idiomi minoritari dalla loro possibile estinzione.
Per quanto sembra che tra le lingue ausiliari sia la più sviluppata, non è tra le prime 100 ad essere parlata, nessuna organizzazione internazionale la adotta, come lingua “franca” è ancora poco diffusa e la sua letteratura è perlopiù composta di traduzioni. Insomma, si tratta di un esperimento che, pur se interessante e generoso, è forse fallito, almeno sotto alcuni aspetti. Del resto, nonostante gli intenti di emanciparne l’utilizzo da ogni sudditanza al movimento di base, il suo uso (ma sarebbe meglio dire il suo “culto”) non si sviluppa molto al di fuori d’alcuni circoli di sostenitori. Inoltre, la facoltà di pensare simultaneamente in diverse lingue può svilupparsi anche prescindendone.
I limiti dell’esperanto sono probabilmente insiti nelle sue stesse ambizioni, in cui la tensione al mantenimento dell’eterogeneità naturale è imbrigliata da un’omodirezionalità forzata: insomma vuole essere vario e vivo, ma rimane statico e larvale. Infatti, l’esperanto intende appartenere all’”umanità” e non ad un “popolo”: tuttavia, l’umanità nel suo sviluppo storico ha avuto tra i principali canali di realizzazione proprio popoli e culture diverse, le cui differenze linguistiche sono condizione, non solo d’incomprensioni e sudditanze, ma anche di significati sempre nuovi e continue libertà. Un mondialismo che non si riduca ad essere lo schiacciasassi della finanza internazionale dovrà tenere conto anche di questo.
Una lingua non esiste nell’essere appresa, ma nell’essere parlata, elaborata, pensata in rapporto a se stessa e all’altro da sé. L’esperanto mantiene, almeno per programma ideologico, tale aspetto, ma il suo altro è (ancora?) troppo astratto: infatti, si presta bene alla logica computazionale e alla programmazione informatica, poco tollerante alle sfumature che permettono (ancora) poesia.
5. Costruzione e confini di una lingua nazionale
Gli scrittori della penisola, dal Duecento in poi, hanno contribuito alla formulazione di una lingua e di una cultura che precedono il paese politico e dalle quali questo ha purtroppo sempre preso poca ispirazione. Manzoni si trova in una situazione non troppo diversa da autori lontani secoli e, tenendosi a distanza dagli autori ruffiani e privi d’onestà ha svolto, sulla base di un inquieto romanticismo che non ha mai rinnegato le basi illuministe, il lavoro in Francia compiuto da tre generazioni di scrittori, fornendo all’Italia il suo primo romanzo moderno, uscito in due edizioni diverse nel 1827 e nel 1840-2 (a puntate). Se la sua e molte altre eterogeneità sono state ingabbiate in un “classicismo” riduttivo, è a causa di una perdurante ignoranza, con i cui equivoci occorre smettere di porsi come collaborazionisti.
L’italiano nasce come lingua dotta, ma è sempre stato permeabile ai dialetti e alle sue forme già storicizzate, passibili continuamente di recuperi e integrazioni. Lo stesso Manzoni, che nel 1861 come senatore del regno apre all’unificazione linguistica da realizzarsi attraverso le scuole, prende a modello prima il lombardo, poi il fiorentino; peraltro il lombardo era la sua lingua “domestica”, pur se parlava e scriveva in un ottimo francese.
Per lungo tempo, la lingua nazionale fu diffusa in fasce piuttosto ridotte della popolazione, e ancora il cinema del neorealismo ha regalato alcuni dei momenti migliori nei dialetti più tipici della penisola. Manzoni, contrario ad ogni cambiamento violento ma polemico assai, avrebbe da ridire sul proliferare di presunti poeti, forti solo del parlare in dialetto, e anche sui professori che continuano rendere noioso tutto ciò che toccano: ritroverebbe tanto la poesia ridotta a «bizzarria da ubriachi all’osteria» quanto la spenta pedagogia del «sopracciglio comicamente greve dei maestri» già dileggiati nel suo capolavoro.
Lo stato italiano non ha fatto proprie queste preoccupazioni, e non ha compreso nemmeno che potessero esistere diverse lingue sullo stesso territorio. La negazione di quelle esposte al confine est fu violenta anche prima del fascismo; per contropartita, abbiamo quasi completamente perso comunità linguistiche italiane come quelle dalmate e istriane e ignoriamo quasi completamente il patrimonio letterario che appartiene loro: un danno incalcolabile. Inoltre, occorre considerare che città e regioni italiane avevano un carattere cosmopolita spiccato, per molti aspetti superiore a quanto hanno comportato gli esiti dell’unificazione. È importante recuperare questo patrimonio, ma non è il centralismo il problema, laddove il federalismo ha già introdotto nuove discriminazioni rispetto ai servizi principali (sanità, trasporti, scuola, previdenza), e ad un irritante provincialismo che è riuscito a coinvolgere anche città di antica cultura.
L’esistenza dei dialetti, nonostante le pretese distruttive che il paese può aver avanzato dall’unità alla fine del fascismo, non è in contraddizione con quella di una lingua nazionale, le cui corrispondenze con modi di pensare che agiscono dal fondo del pensiero sono sempre da scoprire. E se alcune parlate sono lingue a loro volta (riconosciute o meno, come rispettivamente lo sono il veneziano e il piemontese), nemmeno è da sopravvalutarle se non si vuole cadere in frammentazioni controproducenti.
Una lingua può essere impegnativa, così come un’opera letteraria, ma pensare ed esprimersi con proprietà è costrizione solo per chi si attacca, oltre che alle proprie abitudini mentali, a limiti localistici e processi di globalizzazione senza nemmeno capirli: infatti, l’esagerata importanza che oggi sembrano assumere fenomeni del tutto provinciali e il loro assurgere a elemento di identificazione è un effetto collaterale della globalizzazione, che affianca le piccole patrie nate all’ombra dei suoi processi.
Una lingua cambia, è affascinante vederla cambiare, e siamo anche noi a contribuire ad una trasmissione che non deve diventare stupro, masturbazione, oppure neolingua. Così com’è di grande stimolo parlare e comprendere quante più lingue e dialetti è possibile, è assurdo pretendere ridicole egemonie al ribasso: per comprendere quanto sia riduttiva e ridicola questa pretesa, basta immaginarsi il presidente Napolitano parlare napoletano al discorso di Capodanno: «Uè guajò, facete piano co li botti, m’ariccomann, eh!»
Alcune lingue sono nate in seguito a decisioni burocratiche. Il turco moderno, uno degli strumenti con cui il paese si è risollevato dopo lo sfascio ottomano seguito alla Grande Guerra, è stato ottenuto translitterando il turco antico in caratteri latini, quindi adattato alla grammatica tedesca e arricchito dal confronto con i dialetti anatolici. Anche l’ungherese attuale, lingua finnica in un mare slavo, deve la sua istituzione ad un processo affine: prima del 1875 la lingua ufficiale, quella degli atti, era il latino. I problemi comportano tanto la perdita del passato quanto la sopravvalutazione dell’esistente.
In Turchia le persone non sanno leggere un codice bizantino e nemmeno la lapide del proprio nonno, e le minoranze sono state a lungo negate anche a livello linguistico: Orham Pamuk e Ahmet Altan sono tra gli autori che hanno criticato i rapporti di forza tra i gruppi dominanti e le popolazioni kurde delle montagne («Milliyet» 17.04.1995), subendo persecuzioni giudiziarie. In Ungheria è molto diffuso un nazionalismo xenofobo, capace di negare ogni diversità su un territorio che non è mai stato identico a se stesso; fuori dei confini nazionali, l’etnia magiara è ampiamente perseguitata, e la letteratura del paese è spesso rimasta legata a toni manierati, nonostante il respiro europeo di Mihály Babits, che contesta la poesia patriottica nei versi di Ho giocato con le sue mani (Játszottam a kezével, 1915). Un piccolo accenno al serbo e al croato, e al ceco e allo slovacco: i tratti che assimilano tali lingue (anche le prime due, scritte in caratteri diversi) non sono venuti a cadere, nonostante la politica abbia separato paesi e vocabolari.
L’ambizione di utilizzare oppressivamente una lingua nazionale è destinata a fallire fin dove esistono una letteratura e un’arte capaci di non imitare vizi e stupidità nazionali e di esprimere la non omologazione. Se con il prevalere di una culturetta d’intrattenimento s’impone la grande editoria “bestsellerista” e produzioni “indipendenti” becere e grossolane, l’”opposizione culturale” esiste ancora.
La società contemporanea ci confronta con una bizzarra oscillazione tra complessità e semplificazioni: tra queste, il melting-pot, che istituisce omologazioni al ribasso basate su logiche consumiste, così come l’incontro tra culture e lingue diverse può dare luogo a formazioni linguistiche a cui possono essere attribuiti i caratteri di neolingua. Aldilà di questi pregiudizi, la pluralità delle espressioni linguistiche è fertile e necessaria, e porsi al loro crocevia permette una “lingua nuova” agli scrittori in grado di pensare e scrivere contemporaneamente in diversi idiomi, permettendo la formazioni di lessici come il pidgin che mescola lingue indigene e coloniali, oppure l’uso di lingue veicolari. Tuttavia, anche in rispetto di quanto nel De Vulgari eloquentia (1303-1305) Dante definiva come «volgare unitario» (superiore ai particolarismi e capace di essere illustre, cardinale, aulico e curiale), al quale si associava il compito inderogabile dello scrittore di contribuire alla formazione di un linguaggio, è inevitabile che prevalga la struttura di una specifica lingua.
Se dal proprio piccolo occorre essere capaci di ascoltare, oltre alla pagina, anche la strada, la lingua della strada da sola non arriva a niente, se si vuole giungere a quanto Heidegger chiamava la «dimora dell’essere». Se come ricorda Chomsky, «una lingua è un dialetto con dietro un esercito», l’armata più potente è sempre una grande letteratura, che appartiene al mondo intero, e così una lingua non è soltanto strumento espressivo, ma luogo di costituzione dei significati.
6. La Germania del Muro e il muro di Beppe Grillo
Il linguaggio pubblicitario si basa prevalentemente sull’utilizzo delle immagini. 1984 lo espone chiaramente, e non è una profezia: al tempo, la pubblicità e i suoi interessi già esistevano. Orwell aveva individuato la capacità della comunicazione mediatica di fare a meno delle idee, e anche dell’intelligenza, per fondarsi su linguaggi prevalentemente emozionali e su un “presentismo” privo di prospettiva, del quale sono aspetti anche la sopravvalutazione della “memoria” e il rifiuto della “storia”. Il riferimento allo stalinismo è palese, e per scoprire la presenza del dittatore al centro delle critiche può bastare sbirciare attacco e chiusura del libro, dove si fa riferimento ai suoi proverbiali baffoni e anche al suo sorriso. Il dittatore amava figurare come benevolo: in assurdi film dell’epoca impartiva benedizioni a giovani coppie e roba del genere.
Al di là di letture emotive e sensazionalistiche, capaci addirittura di ridicolizzare la stessa sofferenza che ostentano, è necessario precisare che lo stalinismo non è stato il nazismo, così come il ventennio fascista non ha molto in comune con quello berlusconiano, e che Grillo è un’altra cosa ancora. Diverse sono basi e modalità di queste forme di potere, differente è anche l’atteggiamento della propaganda e anche il ruolo della libido: il mondo descritto dal Socing è repressivo così come lo era il fascismo, il modello sovietico puntava ad emancipazioni inquadrate nel progetto politico complessivo, il liberismo anarco-capitalista contemporaneo è piuttosto permissivo. L’unica cosa che risulta sempre drammaticamente uguale è la capacità di trovare nuove sottomissioni e poi di autoassolversi da ogni responsabilità.
Se l’Italia, pur mantenendo tutte le sue ombre, è continuamente sotto i riflettori, la storia dell’Est europeo è generalmente sminuita e quasi nessuno racconta i rapporti tra blocco comunista e Occidente. Va ricordato che per Brecht fu inevitabile approdare con il Volksbühne a Rosa-Luxemburg-Platz, e mentre Stalin solennizzò il classicismo europeo e la Prussia sopravisse ad Est, il comunismo realizzava un sogno cullato in Germania. Nessun bispensiero può azzerare completamente la mente umana, anche perché chi vuole può sempre provare a mettere insieme i pezzi del reale e conoscere la storia, anche quella tutta da riscoprire dei paesi del socialismo reale. Il germanista e giornalista Nestore di Nola con Quel muro c’è ancora (2003) è uno di quelli che permettono di comprendere le relazioni intrattenute tra le due Germanie e vedere le brecce già aperte negli anni del Muro.
Una prima breccia la troviamo in Rudolf Bahro, che ne L’alternativa (1977) afferma l’esigenza di liberare il partito comunista dall’irrigidimento stalinista e dall’inerzia dello stato per riportarlo all’autentico insegnamento marxista. Il libro, pubblicato in Germania Ovest, gli costa una prigionia di due anni e l’espulsione dalla DDR; migrato ad Ovest, aderisce ai Verdi. Bahro recupera lo spirito tutto tedesco della Sonderweg (via speciale) dove teorizza la possibilità di ristabilire forme societarie preindustriali attraverso prassi di vita indipendenti dal mercato, capaci di superare l’economia capitalista. In quegli anni, i movimenti pacifisti della Germania federale, in contatto con i loro omologhi orientali, rigettano la corsa al riarmo degli euromissili accusando il governo di essere succube degli USA e della lobby degli armamenti. Nel maggio 1983 l’attivista verde occidentale Petra Kelly manifesta a Berlino Est contro il riarmo; nell’ottobre 1992 la Kelly è ritrovata morta con il marito Gert Bastian, militare che sentendosi più vicino al Patto di Varsavia aveva lasciato l’esercito per unirsi alla resistenza civile. Il caso rimane irrisolto; così, anche i rapporti tra guerra e pace.
Altre falle nel Muro di Berlino sono smosse proprio dagli interessi del capitale e degli uomini di guerra. Primavera 1983: accordo tra Franz Josef Strauss (ministro federale anticomunista e uomo di fiducia in Baviera della lobby internazionale degli armamenti) e Alexander Schalck-Golodkowsy, (esponente dei servizi segreti della Germania democratica più incline a strategie di mercato). L’insolita alleanza Strauss-Schalck ad Ovest è sostenuta dalla dal gruppo industriale di impostazione liberale Flick che coinvolge anche l’ex cancelliere Helmud Kohl, ad Est è forte dei servizi segreti della Stasi. Si muove disinvolta nell’oriente di spie, delatori, élite e abusi di potere, mentre in occidente finanzia movimenti pacifisti come l’Unione Tedesca per la Pace, un numero enorme di società d’intermediazione, gruppi di potere stranieri come il PCI. Christian Wolf, ex capo della Stasi, affermò esplicitamente di aver favorito in funzione anti NATO i legami tra i pacifisti delle due Germanie, aggiungendo che non tutte le iniziative sono state da biasimare.
Il Muro quindi non è pienamente coincidente con i limiti che contiene: infatti, a Berlino nel 1988 la non corrispondenza tra Muro e territorio permette a 200 contestatori e punk, che protestavano contro le misure edilizie del senato occidentale, di occupare a Postdamer Platz con una baraccopoli il cosiddetto Triangolo di Lennè, che apparteneva all’Est ma era interamente locato ad Ovest. Incalzati da una carica della polizia i manifestanti fuggono dall’altra parte, dove sono rifocillati, fatti riposare e poi rimandati a casa. Il personale di frontiera dell’Est era piuttosto tollerante con i contestatori occidentali, con cui condivideva la matrice anticapitalista. Non è soltanto il Muro a separare, se si parla la stessa lingua. Non sempre è neolingua.
Nella sua secolare storia d’indecenza e incapacità, la politica italiana sollecita l’intervento di Beppe Grillo, che dopo una fase d’attivismo di piazza fonda il Movimento 5 Stelle, portandolo quindi al parlamento. Pur rifiutando candidatura ed eleggibilità, guida il partito in modo verticista e autoritario; il comico ha gestito al massimo una presenza in rete molto ben attrezzata, ha un’agenzia di comunicazione alle spalle, ha riempito le piazze con campagne specifiche e ha anche un nome e una storia, perché non è soltanto molto conosciuto ma ha sempre dimostrato particolare attenzione a politica ed ecologia.
Grillo non ha avuto soltanto un blog come risorsa; tuttavia, non ha nemmeno dato vita ad un movimento effettivo, e inoltre è rimasto irretito in una particolare forma di bispensiero: da una parte l’abuso di un linguaggio massimalista e l’incapacità di conciliare hanno contribuito a limitare la portata delle proposte, dall’altre queste sono rimaste perlopiù legate a particolarismi irrelati. Tuttavia, il problema più enorme è che ha rappresentato la risposta sbagliata ad esigenze legittime, comportando una dispersione enorme. Il suo è un muro che non può né essere scalato né permette fratture.
Il Grillo comico aveva un linguaggio vivace ed aggressivo, arguto e fisico al contempo. Ha continua a gridare e a sudare quasi nello stesso modo, addirittura aggravando i toni in modo da essere comprensibile in un ambito dominato da semplificazioni come quello politico, risultando così meno serio e più buffone di prima. L’ingresso nel palazzo è stato voluto e pianificato, ed era necessario laddove la politica è decisione e amministrazione e non soltanto discorso più o meno ideologico. Le forme amministrative attuali sono ristagnanti e per esserne esponenti devi adeguarti ad un meccanismo che non sa più provvedere al bene comune: questo è noto. Tuttavia, esistono sempre figure che, silenziosamente, decidono cercando il meglio oppure tentano di evitare il prevalere del peggio, e ad ogni modo gli aspetti di mediazione e attesa sarebbero necessari anche se la politica non fosse la palude che è. Soprattutto, non esistono altre risorse oltre a quelle di far funzionare un parlamento ed essere per davvero una repubblica.
Il M5S ha rilanciato questioni importanti, dalla gestione delle discariche (dalla gestione della camorra passate a quella dei grandi partiti restando sempre, in senso figurato, schifosi immondezzai), al treno ad alta velocità (da sottrarre a progetti e proteste ambedue obsolete, impegnate in un conflitto che non permette nessuna chiarezza né sugli interessi collettivi né su quelli locali), all’Euro (da rettificare insieme a tutta la finanza, senza però pretendere di tornare al baratto e senza accusare i tedeschi di ogni cosa). Tuttavia, nelle proposte effettive non è andato oltre di una faciloneria rancorosa, piuttosto tipica delle modalità da blog populista dalle quali Grillo non sa emergere: avrebbe anche dovuto trattare meglio la sua posizione, anche per non restare imbrigliato negli stessi giochi che denunciava.
Più di ogni altro oppositore politica, Grillo somiglia in maniera smaccata a Goldstein, il nemico del Socing e sua parodia, capace di esprimersi in perfetta neolingua pur chiedendo liberà per tutto e accusando ognuno di tradimento. Un modo per uscire da difficoltà che dopo le denunce di Orwell non sono certo migliorate sarebbe quello di invertire completamente il criterio costitutivo della modernità: sciogliere la politica da ogni tipo di giustificazione culturale e considerarla come pura capacità amministrativa; in questo quadro, permettere in Italia una decisa riforma istituzionale, a partire dalla piena istituzione delle aree metropolitane. Ormai, occorre abbattere i tetti.
7. Solcando i mari del web
Winston Smith, il protagonista del romanzo, capace impiegato presso il Ministero della Verità, non ha nessuna convinzione o trasporto che lo lega al regime. La sua ribellione viene denunciata alle autorità da Julia, la spia di cui è innamorato, colei che ripeteva: «possono farci dire ‘qualunque cosa’, ma non possono farcela anche credere.» Posto sul banco degli accusati, Winston confessa e compromette ogni cosa con cui possa essere entrato in contatto. Mentre sta per essere annullato, si scopre «vincitore di se medesimo», e confessa il proprio amore per il Grande Fratello.
Astraendo dalle condizioni del romanzo, prive d’ogni possibilità di scampo, tale comportamento somiglia a quello di chi prima provoca e poi non sta al gioco, propagando un comportamento che in maniera esemplare riesce a «ritenere contemporaneamente valide due opinioni che si annullano a vicenda»: rinnega e rivendica, realizzando quella conciliazione tra contraddizioni che permette ai condizionamenti del potere di mantenersi.
Atteggiamenti del genere sono molti diffusi nel web e nei social network, di cui non è tanto da stigmatizzare l’apparente democrazia e l’effettiva capacità di tracciare ogni dato, quanto le notevoli difficoltà che dimostrano molti utenti di sostenere confronti fondati e argomentati, oppure di stabilire per primi dei criteri su quali aspetti far conoscere di sé. Tali limiti non rappresentano un destino, dove si prenda atto delle inadeguatezze da emendare, che in qualche modo si compendiano nel dire e fare qualunque cosa a cui non si creda.
Focalizziamo su alcuni aspetti più tipici e deteriori delle discussioni da social forum. Alcuni vivono nel computer e poi si dimostrano incapaci di affrontare testi più lunghi di cinque righe. Chi si lamenta della decadenza culturale, e poi dichiara tronfio di rinnegare le fonti. Quelli che rivendicano la cultura orale però lo fanno scrivendo e confondendola con la chiacchiera. Coloro che lanciano discussioni male impostate solo per promuoversi però poi non sanno seguirne gli sviluppi. Cazzeggiare a sproposito con questioni che s’ignorano e poi di fronte alle conseguenze della propria stoltezza atteggiarsi ad offesi, credendo che essere seri significhi non ridere.
A dare retta a costoro, del pensiero e delle altre arti rimarrebbe soltanto un possibile autocompiacimento e, a prescindere da ogni possibile generosità umana e non troppo umana, nessuno scriverà mai abbastanza e nessuno leggerà niente: finiremo con lo stare tutto il tempo ad oziare ripetendo sempre le medesime baggianate. Fortunatamente, ciò non è obbligatorio: il nostro agire può definire la realtà, e nel web c’è ancora molto da fare. Inoltre, il livello dei testi e la loro cura dipendono più che mai dall’interazione con comunità nelle quali è decisivo il contatto tra le diverse forme del leggere e dello scrivere, e dove può definitivamente prendere forma un autentico sentire cosmopolita. Sono vantaggi enormi, per i quali vale la pena impegnarsi, arginando aberrazioni, spezzettamenti, provincialismi vari.
Bisogna però avere idea di qual è il significato della scrittura. Invece, spesso sono ostentate proprio la mancanza di professionalità, l’incapacità d’ascolto, l’assenza della competenza più elementare: dimostrando, piuttosto che la presunta democraticità del mezzo, la propria personale inettitudine nel nutrire i propri stessi interessi. Certe cose sicuramente non sono mai state per tutti e, in tempi non sospetti, il sempre-dolce-dolce Schopenhauer aveva un’idea di moderazione molto molto simpatica: «È assolutamente sbagliato voler trasferire anche in letteratura la tolleranza che per forza si deve usare verso le persone ottuse e senza cervello in società, dove simili tipi brulicano. Nella letteratura costoro sono, infatti, intrusi sfacciati, e qui disprezzare le cose cattive è un dovere verso quelle buone: per colui per il quale nulla è cattivo, nulla parimenti è buono. In generale, nella letteratura la ‘cortesia’, che è di origine sociale, è un elemento estraneo, assai spesso dannoso; poiché essa esige che la roba cattiva sia riconosciuta buona, e perciò ostacola senz’altro i fini della scienza, come dell’arte.» (Sul mestiere dello scrittore e sullo stile, 1851).
Le persone adulte non si contentano di sentirsi dire “infatti”, e tra uomini interessati al sapere ogni posizione affermata è passibile di discussione, se alla critica corrisponde l’intento di distinguere, animato dall’esigenza di comprendere. Pensarla diversamente è una ricchezza, possiamo imparare molto da chi la pensa diversamente da noi, ma bisogna comunque pensare. Infatti, esistono criteri per formulare le opinioni (così come esistono idee sballate), e il diritto di parola, anche se sembra automatico, non solleva dalle responsabilità di quanto viene detto (ma troppe volte devono ricordarcelo le conseguenze). È necessario mantenersi vigili verso errori, evidenti dove le affermazioni non quadrano con l’ordine del discorso e quando si diffondono dati imprecisi non rispettosi di una minima etica della conoscenza. Così, non esiste nessun dogma verso la lingua, la lingua è invenzione, ogni errore può portare a nuove soluzioni, ed è anche questo a costituire libertà e stile: c’è però una decenza. Le parole non sono chiacchiere: se le riduciamo a tali, peggio per noi.
Affermazione che, per un motivo o per l’altro, non sono assolutamente convincenti dipendono da inadeguatezze esemplari, che in neolingua possiamo definire tanto «pensabuonate» quanto «archepensevoli». Sottoporre un’opinione a critica non è polemica, e anzi dove supera le parzialità scioglie dai personalismi. Peraltro, è molto più criminale permettere la diffusione di parzialità, errori e frescacce varie, che cercare di favorire un lavoro di riflessione al quale ognuno è chiamato e i cui benefici coinvolgono tutti. Una discussione non può fare a meno di confronti tra posizioni, le idee possono circolare soltanto se siamo in grado di distinguere.
La scrittura non prescinde da distinzioni, argomenti e confronti, anche perché la mediocrità non può essere in grado né di conoscere, né di commuovere. La mediocrità autocompiaciuta, così come la sguaiata stoltezza, sono però molto suscettibili: anche quando si parla d’altro, sono sempre pronte a rivendicare qualche sterile “cattiva infinità”; ma del resto, perdere tempo è la loro missione. Demistificare le presupposizioni ingenue non è affatto un atteggiamento presuntuoso: piuttosto, aiuta a dirimere alcune “conoscenze presunte” e favorisce chiarimenti. Tuttavia, è impossibile avere rapporti con chi sputa nel proprio riflesso e poi rimane a guardarsi. Imbambolata nella prosopopea della propria inutilità, tale presunzione radicale non porta contributi ma si limita a richiamare attenzioni su sé, credendo basti questo a fare “gultura” (spesso carente anche nell’ortografia). Non è seria, né fa ridere, è soltanto noiosa.
La tendenza alla svalutazione del sapere e della cultura era in corso già prima di Internet: alcuni la chiamano “comunicazione”. Gli aspetti di semplificazione linguistica e concettuale da tempo si sono imposti nei media, nell’istruzione e nella politica, accompagnando una generale corruzione che per molti imbecilli non solo è indiscutibile, ma è anche una condizione a favore. In questo clima, oltre a scrittorelli e poetastri (fanno chiasso ma basta saper leggere per riconoscerli) intenti nella contemplazione della propria vuota immagine, prosperano anche gli esponenti di una pseudo-cultura (più dannosi dei vecchi pseudo-intellettuali in quanto negano gli stessi criteri minimi di comprensione) profonda come l’inconsistenza. Figure di questo tipo, che con la scrittura non c’entrano niente e che ambiscono a popolare il “pianeta dei famosi” non sono una novità; ora, proprio la rete che ne segna il proliferarsi può permettere di contrastarli, confutarli e procedere oltre. Questo è possibile laddove ci si assuma la responsabilità e la decenza di pensare: attività che, pur se non interessa tutti, è comunque a disposizione di ognuno. Nel “professare” tale decenza e responsabilità, possiamo trovare una linea di difesa inattaccabile.
Esistono alcune distinzioni precise dei comportamenti in rete, che oppongono, secondo uno schema esplicativo, l’”attore” all’”eroe”. L’”attore”, nei casi migliori, è come un bambino che invade una partita di campionato per giocare a figurine; generalmente interessato non tanto alla “relazione” quanto alla “masturbazione”, spesso non sa, non sa di non sapere e nemmeno gliene frega un cazzo. Può prendere il fastidio e il disprezzo che suscita come segno di distinzione, oppure rivendicare spazi di “libertà” per continuare a “trastullarsi” inutilmente. In definitiva, non c’è molto di cui parlare con lui perché, di fatto, non parla. L’”eroe”, per creare “impresa” del proprio sapere e poter avviare un proficuo “commercio” di idee, non può più limitarsi ad essere interessato al contenuto, ma ne deve essere promotore, deve rimetterlo al centro di ogni messaggio senza scinderlo dalla forma e dal contesto, cercando di rinnovare i codici e di ristabilire degli ambiti, ad un livello nel quale il “pensiero” sa farsi “evento”. Niente paura, eroi: in un’epoca di smaterializzazioni, l’esperienza dell’evento è così comune da essere banale. Occorre soltanto fare in modo che ad essere veicolati siano studi ed esperienze effettive.
Con Internet abbiamo tutti imparato a scrivere. Adesso occorre cominciare a pensare: altrimenti sono soltanto chiacchiere. Per quanto sugli aspetti tecnici sia inevitabilmente datato, è ancora in grado di farci comprendere i rischi di un uso acritico della rete il libro di Luciano Floridi L’estensione dell’intelligenza (1996), che stabilisce l’importanza di un «controllo di qualità». Al riguardo, credo che non dobbiamo aspettare la tutela di nessuna istituzione: è diritto e responsabilità della nostra intelligenza provvedere, se ne abbiamo cura. La posta in gioco è sempre il libero scambio di informazioni, che per essere davvero tale deve «potersi premunire contro ogni forma di sapere corrotto o incompleto» in modo da evitare che le persone non siano più in grado «più in grado di distinguere tra lo spazio intellettuale del sapere e un ambiente inquinato da spazzatura e rifiuti digitali». Il controllo di qualità può quindi essere praticato anche attraverso l’assunzione dei criteri scientifici di argomentazione e attendibilità, da mettere continuamente alla prova. Non sempre succede, ma siamo noi a scegliere.
Nell’ambito dei social, l’operazione, è a mio avviso possibile soprattutto su Twitter (impostato sulla sintesi), LinkedIn (basato su competenze riscontrabili), GooglePlus (sistematico e indicizzato), ma certo non basta. Tali strumenti possono permettere di formulare contesti dove è possibile intervenire per dare contributi verificabili e lavorare a livelli diversi e comunque capaci di reciproca implicazione. Divulgare non significa involgarire, fare ricerca non significa escludere, in una comunicazione responsabile la qualità dei contenuti deve essere preservata. La curiosità, l’intelligenza e le migliori possibilità di metterle in gioco non devono essere mortificate da noiose facilonerie, vizi ideologici e populismo spinto. Ma non finisce, e non comincia, qui: Infatti, bisogna sopratutto ricomprendere il rapporto che lega il virtuale ad altre esperienze e determinazioni.
Il “virtuale”, per chi l’ha capito, non si oppone al “reale” per poi sostituirsi a lui in un generalizzata follia, e se favorisce la riconsiderazione del verosimile non comporta nemmeno il prevalere della falsità. Pierre Levy (Il virtuale, 1995) pone il virtuale in relazione con l’”attuale” e gli affida il compito di permettere la riapertura di strutture nella realtà quotidiana già presenti e in atto, favorendo così tanto il manifestarsi di qualità inibite che non possono manifestarsi pienamente, quanto di il reinterpretare l’organizzazione secondo modi capaci di dischiudere progetti inediti e di rivoluzionare l’immaginazione personale e collettiva. Tuttavia, come la spora che si diffonde, il virtuale per dispiegarsi necessita di un ambiente adatto: mica basta digitare.
La storia di millenni e ogni giorno del mondo è in grado di far comprendere a chiunque che esistono moltitudini di relazione a cui la scrittura conduce. Non è il caso di rifiutare barbaramente la possibilità di dirsi qualcosa di significativo nella lingua in cui ci si esprime: altrimenti, per davvero sarebbe preferibile il silenzio. La presenza di persone d’ogni tipo deve rendere la discussione valida aldilà d’ogni banalizzazione, senza l’assurdità tipica del populismo di ogni colore di emarginare chi ha dati e competenze, riscontrabile anche nelle conferenze organizzate dagli ignoranti. Tra lo sfascio delle istituzioni e l’infantilizzazione della cultura oggi sembra davvero di vivere in una versione anarco-capitalista del mondo orwelliano. Provare a ricostruire un sapere lì dove siamo: questa è la sfida. La pedagogia al ribasso è impossibile, e lo sfoggio da evitare è quello di frasi fatte e stereotipi culturali. Sennò, ce lo meritiamo il Grande Fratello.
8. Verso una nuova letteratura?
La scrittura chiede attenzione e raccoglimento: leggere non significa guardare e basta. Riconoscere una visione esige attenzione. L’opposto esatto della scrittura è chiacchierare troppo senza comprendere niente, come succede quando ci si limita ad essere generici e lamentosi. È il modello esatto dei media: occorre essere attenti a non assumerlo come dogma, oppure imitarlo pur laddove si crede di criticarlo. Secondo un movimento diverso, i media possono appropriarsi della letteratura: Orwell evidenziava che la versione in neolingua dei classici della letteratura li impoverisse irrimediabilmente: tuttavia, i molti adattamenti che ormai si affiancano agli originali non sembrano, nel migliore dei casi, toglierli dignità, quanto estenderla, in un rapporto aperto e vivo. Ci sono invece alcune scritture contemporanee che si presentano piuttosto conformi alla distruzione del significato e alla negazione della realtà: a qualcuno può piacere, perché è bello immaginarsi scrittori, e quando non si è in grado di leggere e scrivere qualche illusione può sicuramente aiutare.
Scrivere è elaborare, il resto sono seghe. Esiste però anche una “letteratura non creativa”, per cui il critico statunitense Kenneth Goldsmith parla espressamente di «imparare a gestire la grande quantità di testi già esistenti», capacità che dovrebbe soppiantare la «necessità di nuovi testi»: questa ultima frase è però la parafrasi pedestre di quanto affermato dall’artista concettuale Douglas Hueber, che a sua volta parlava di «oggetti» e non di «testi» (realtà piuttosto diverse). Nuovi testi si producono di continuo, proliferano indefinitivamente, sono sollecitati da un mondo che cambia e vuole essere compreso: tutto questo accade, anche se alla cieca, persino con gli “esercizi” (che non sono quindi scrittura definita) proposti dal simpatico buontempone americano Goldsmith. Tuttavia, quale scrittore che abbia qualcosa da dire si contenta di fare esercizi? Il plagio poi, in quanto tale, oltre ad essere reato, è anche un’ammissione di stupidità. A chi piacciono gli scrittori stupidi?
L’uncreative writing può aggiornare il cut-up praticato da Burroghs, il quale comunque non aveva problemi a realizzare frasi originali, e poteva quindi pure permettersi di decostruirle. Se si volesse ricondurre questo discorso ai “gesti” di John Cage, peraltro anche un formidabile scrittore, quella di Cage è musica squisita raccolta nel suo puro ascolto, oltre ad essere zen. Invece, per la retorica latina, l’imitatio consisteva nella traduzione dei greci, l’aemulatio nella loro rielaborazione stilistica, comportando soprattutto la fiducia nell’identità della parola con il vero: ma non possiamo chiamare a testimone i classici, il nostro fronte è completamente da un’altra parte.
Se oggi lo scrivere è utilizzato da tutti, non tutti possono appellarsi “scrittori”: le declinazioni dell’autore sono numerose, ed esistono anche scriventi e redattori che sanno trattare testi perché li conoscono bene a livello tecnico, di tessitura e articolazione. Inoltre, se da sempre ci sono quelli che aprono bocca e gli danno fiato, oggi ci sono quelli che digitano senza pensare. Sono tanti, ma non per forza hanno ragione loro.
Saper pensare è proprio quanto serve per scrivere qualcosa che ne valga la pena. È assolutamente falso che si sia ormai detto tutto e che non si può quindi più aggiungere nulla di nuovo e valido. L’impotenza non è un destino, in ogni angolo di questo mondo c’è continuamente qualcosa che si offre: ma anche qui, bisogna saper vedere.
La provocazione di Goldsmith si basa sulla celebrazione del «programmatore», ad ogni modo uno che sa dove «mettere le mani», e con molta precisione. Tuttavia, il feticismo tecnologico potrebbe essere a sua volta datato, così come la proscrizione dell’originalità compiuta dal post-moderno: infatti, ne derivano pure i guasti della comunicazione e della sua mezza cultura, ormai evidenti, almeno a chi sa vederli. Inoltre, se il digitale rappresenta per la scrittura di quello che per la pittura fu la fotografia, non va sottovalutato che questa permise alla pittura l’esplorazione dei propri specifici valori, disancorandoli da preoccupazioni rappresentative, come dall’impressionismo in poi è evidente a chiunque sappia “leggere” un quadro. Pertanto, oggi potrebbe essere possibile esplorare le frontiere che si aprono ad una scrittura capace di essere in relazione con se stessa.
Le analogie tra letteratura e programmazione, in quanto basate sulla costruzione di reti articolate, sono oggetto della riflessione e del lavoro di scrittura di Vikram Chandra, autore di Amore e nostalgia a Bombay (1997). L’autore indiano evidenzia la differenza tra gli usi denotativi del linguaggio (che stabiliscono significati univoci) e quelli connotativi (per i quali sono decisivi contesto e articolazione simbolica – ricondotti al concetto induista di dhvani, riverbero). L’esigenza di distinguere i piani contribuisce a mettere un argine anche alle pretese dei geek di essere “artisti”, che rischia di togliere ogni specificità all’arte delle parole, irriducibile alla loro “forma” (in quanto costituita dal movimento stesso delle idee); per il resto, il suo romanzo prevede ambientazioni contemporanee e qualche elemento retrò, e si risolve nel raccontare storie all’interno di una storia.
Viviamo sicuramente un’epoca di cambiamenti così veloci da formulare un’immagine di immobilismo, quindi è meglio andarci piano con l’ottimismo; se poi vogliamo ancora un’emancipazione possibile, l’ingenuità di credere che Internet segni automaticamente la fine di un sistema di potere verticista va demistificata. Infatti, spesso la “moltitudine” si limita ad essere il megafono distorto della “casta”, e aver confuso la dovuta critica dell’autorità con l’infantile rifiuto dell’autorevolezza ha prodotto troppe “star culturali” ridicole e dannose, determinando una straordinaria influenza del pattume. Inoltre, se per gli scrittori sentirsi stranieri in questa terra non è una novità, occorre più che mai essere pronti a gestire i cambiamenti con coraggio e, al contempo, cautela. Web semantico e meta-linguaggio sono direzioni che chiunque non si accontenti della masturbazione diffusa deve assumere e configurare da subito.
Saper distinguere non è mai stato un esercizio popolare ed è diventato anche piuttosto arduo: proprio per questo, occorre insistere, senza troppi complimenti. Saranno stati scritti anche molti romanzi in questi anni, ma la narrativa di consumo è perlopiù composta da robaccia, rabberciata alla meglio con cliché datati: farsela piacere per forza è un crimine contro l’umanità. I peggiori sono quelli che si danno un tono: il misticume light di Paulo Coelho e l’impegno alla carlona di Erri De Luca esemplificano come il sistema migliore per portare avanti il progetto di dar fuoco ai libri sono proprio i cattivi scrittori.
Una letteratura è tale anche perché esplora un presente: è quindi inevitabile una minima considerazione dei linguaggi della programmazione, che consistono in indicazioni scritte in particolari codici. Ad esempio, è certamente una bella sfida descrivere attraverso l’algebra booleana, che elabora matematicamente la logica proposizionale attraverso reticoli dotati di proprietà (distributività, complementarietà, minimi e massimi) e costruisce circuiti elettronici attraverso operatori logici (NOT e AND). Tuttavia, rendere dogma l’adeguamento alle emergenze porta a risultati ridicoli, che spariscono con l’ondata a seguire e non soddisfano l’esigenza di significato. Non c’è poi oggi nessuna tendenza che obblighi a questo o a quello: in letteratura, da tempo generi e correnti sopravvivono per pura convenzione di mercato, oppure per un’esigenza di fare mafia estremamente diffusa anche tra chi ostenta moralismi, soprattutto in Italia.
In 1984 esiste una macchina per scrivere romanzi, alla quale è addetta Julia, l’amante e traditrice del protagonista, e c’è anche il versificatore che scrive canzonette sentimentali; oggi, il software per narrare possiamo comodamente scaricarlo da Internet, si chiama Bibisco e prevede precise funzionalità. 1) Tutto ciò che ti serve (organizza capitoli e scene, gestisci le revisioni, esporta il romanzo in pdf o rtf. E, naturalmente, scrivi con un text editor completo di tutte le funzionalità). 2) Organizza le tue idee (crea la struttura del romanzo, definisci premessa, fabula, linee narrative, luoghi e il contesto sociale e temporale in cui si svolge la storia). 3) Conosci i tuoi personaggi (un romanzo funziona quando i personaggi sono credibili, cioè quando emerge la complessità della loro natura umana. Per questo ti aiutiamo a conoscere tutto dei tuoi personaggi). 4) Analizza in dettaglio (osserva come i personaggi, i luoghi e le linee narrative sono distribuiti cronologicamente e attraverso i capitoli). 5) Fatto con amore, per scrittori (questo è un progetto personale, fatto con amore. Amiamo i libri e vogliamo aiutare gli scrittori a scrivere bellissimi romanzi. Ah, Bibisco è gratis e open source!).
Alla finfine, tra una spiegazione e una moina, il tutto si riduce ad un word processor un po’ più elaborato, strutturato per tenere conto di capacità e procedure che nella scrittura occorre gestire a livelli di complessità impossibili da prevedere per qualsiasi algoritmo, propriamente definito come una serie limitata di istruzioni per risolvere un problema logico o matematico: insomma, un calcolo. In sintesi, Bibisco è un programma che aiuta a tenere in ordine schede e appunti, premesse, fabula e ambientazione, linee narrative caratteri e funzioni dei personaggi e loro distribuzione nelle varie scene. Per farla breve, tutto ciò che può stare su una scrivania viene delegato ad un programma: non è un problema, se riesce a stare anche dentro una testa. Ma serve davvero?
Bibisco o non bibisco, esistono da tempo meccanismi di scrittura scontati, dei queli scriventi e “leggenti” pigri di mente non sanno fare a meno. Farsi uno schema è il minimo: infatti, ne servono un’infinità, solidi e variabili al contempo. Forse può bastare carta e penna, memorie esterne possono sempre essere d’aiuto, ma certamente chi è in grado di farsi tali domande sa che certi elementi non possono essere sostituiti da download, software e da tutto quanto può ridursi ad automatismi. Compiutezza d’espressione ed elaborazione stilistica sono variabili complesse, non gestibili attraverso la semplice esecuzione di algoritmi.
Una storia non è caratterizzata soltanto da fluidità, ma ha anche significati. La gestione di linee narrative parallele può essere tutto tranne che meccanica, e richiede controlli intrecciati. Anche lo schematizzare può esigere revisioni retrospettive: se non esclude l’invenzione, questa stessa ha schemi di funzionamento, mai completamente razionalizzabili. E in ogni momento può irrompere una nuova idea. Uno strumento è tale in quanto è funzionale ad uno scopo e lo supporta. Lo strumento è uno strumento: è la pagina che deve esplodere.
Nessuna preclusione: apprezzo le possibilità di controllo che la scrittura digitale ha introdotto, le capacità di precisare il pensiero che è in grado di permettere. Non per questo però ogni scimmia può digitare l’Amleto: esiste un livello semantico che richiede particolare vigilanza. Programmi per scrivere commenti sono diffusi nello spam, e quando sono entusiasti preferiresti siano veri. Le traduzioni automatiche hanno grossa utilità, ma se non conosci un minimo le due lingue e l’argomento in questione fai ridere. Leggere, comprendere e assimilare sono processi che richiedono una mente sufficientemente allenata: ed è la capacità di rileggersi con distacco a permettere una scrittura elaborata.
Le capacità di leggere e valutare forniscono il senso di testi e contesti e devono essere scelte e coltivate con criterio; non comportano di necessità alcun “successo” ma possono facilitare la comprensione delle cose, per coloro a cui interessa. Probabilmente, oggi “pubblico” e “critica”, prese nel loro senso effettivo, non hanno alcuna influenza. Infatti, nelle pratiche più diffuse sembrano prevalere consumi letterari e comunicazioni promozionali basate proprio sulla denigrazione delle capacità di leggere con raccoglimento e di utilizzare strumenti valutativi. Proprio per questi motivi, il primo e più severo critico deve essere lo scrittore stesso, se è davvero tale ed è in grado di raccapezzare in sé l’umanità per cui scrive: altro che intuizione. Se ne accorse già Baudelaire, cosciente di essere moderno e che «l’aureola del poeta» fosse ormai «caduta nel fango», e capace di guadagnarsi il successo perseguendo quanto ritenesse giusto, anche al costo di sottostare a processi giudiziari. Un’autentica serietà professionale esige competenza: per muovere il mondo, o almeno provarci, è necessario trovare punti d’appoggio, servono cognizioni adeguate e argomenti puntuali, insomma tutto quanto non è chiacchiera.
Rispetto agli atteggiamenti estremi degli scrittori, credo sia evidente che nell’essere troppo convenzionali difficilmente può realizzarsi qualcosa di interessante. Tuttavia, per riuscirci non basta certo sconvolgersi di droghe o roba del genere: anzi forse è meglio restare a casa che andarsi a mettere nei casini – e non lo dico soltanto perché, personalmente, ne ho combinati abbastanza. Occorre definitivamente rendersi conto che viviamo in una stagione molto diversa da quella dei maledetti storici: la trasgressione ormai è banalità ed è molto più funzionale al capitalismo degli stessi borghesi, destituiti dal loro ruolo decisionale. Una sovversione deve però riflettersi anche sul linguaggio: ad esempio, non basta dire “sesso non convenzionale”, potrebbe pure essere soltanto pubblicità e masturbazione.
Una nuova letteratura si ottiene anche disarticolando gli ordini di potere e decostruendo le pratiche ordinarie, ma ogni “stranezza” deve riconquistare piena intelligibilità: una vera competenza linguistica ha la dignità di una conquista consapevole laddove è dotata di quell’universalità che permette di agganciare la contingenza del nostro particolare esserci al passato e al futuro. Un relazionarsi degno permette l’autenticità di una pienezza di senso sempre possibile: tutto quello che non è neolingua.
9. La rivincita del congiuntivo
Il senso di sfumatura e possibilità espresso dal congiuntivo è opacizzato da una mentalità ossessivamente schiacciata, come ha segnalato anche Marc Augé, su un presente privo di prospettive: di fatto, è proprio concepire tempi e modi diversi dal “qui e ora” a essere diventato complesso. In questo, la neolingua si dimostra agita laddove ad una forma linguistica trascurata corrisponde un pensiero atrofizzato. Consideriamo però che la nostra lingua rispetto ad altri idiomi europei ha maggiore stabilità: infatti, noi ancora comprendiamo Dante, gli inglesi non capiscono Chaucer. Tuttavia, un alternarsi di modi diversi come quello praticato da Manzoni ci sfugge.
Ci sfugge quindi pure il congiuntivo? Modo dell’irrealtà, nelle subordinate indica volizione, aspettativa, opinione, persuasione, mentre nelle proposizioni indipendenti ha ruoli esortativi, concessivi, dubitativi, ottativi ed esclamativi. Ad esempio, il ruolo ottativo è quello di: «Tizio non rideva: aveva il terrore d’essere seguito e a ogni angolo di strada si voltava o tornava indietro per vedere se c’era qualcuno che lo stesse pedinando.»
Il congiuntivo a volte si esprime pure a gesti, nei dialetti che ancora li ‘parlessino’ tutti, per quanto in forme diverse da quelle ormai storicizzate e spesso riconosciute come lingue, fatto che anni fa sarebbe stato impensabile. Quante delle scelte “economiche” che nel linguaggio semplificano i ruoli di subordinazione delle frasi sono dettate dall’influenza dialettale? Quante da quelle straniere? Quante da una diffusa involuzione culturale spesso incapace di far ridere anche involontariamente?
E fino a che punto arriva l’inconsistenza dell’irreale in cui siamo immersi, capace di costringere il congiuntivo ad eclissarsi eppure a continuare a esistere? Contro l’ansia nei confronti del congiuntivo, un articolo dell’Accademia della Crusca parla proprio di una sua “vitalità”, tuttavia costretta a vistosi “regressi” che negli usi linguistici, a volte sollecitati addirittura dalle preoccupazioni comunicative delle redazioni giornalistiche ed editoriali, gli preferiscono l’indicativo; la sparizione, infatti, riguarda più i tempi composti del trapassato remoto e del futuro anteriore: “ebbi parlato” e “avrò parlato” sono ancora meno diffusi dei congiuntivi passato e trapassato “abbia parlato” e “avessi parlato”, ma non è che possiamo semplificarli e abolirli per far favori a chi non li comprende: sarebbe questa un’applicazione piuttosto manualistica dei principi della neolingua.
Inoltre, deve essere ribadito che proprio i processi di globalizzazione conducono a “paesanizzazioni” e quindi a localismi spinti e diffuse resistenze linguistiche. L’inglese, più pratico che banale, è sempre poco praticato dai provinciali italioti; la lingua più diffusa al mondo è lo spagnolo la cui somiglianza all’italiano è minata da molti “falsi amici”. Il cinese è ricercato non per gli involtini primavera ma per lo sviluppo dei mercati asiatici; l’ideogramma ha implicazioni interessanti che rispondono ad altri criteri rispetto a quelli alla base di grammatica e logica delle lingue alfabetiche: forse, in una comprensione sempre più legata al fattore iconico, ci può sembrare meno lontano di un tempo.
Bisogna distinguere anche riguardo l’influenza della televisione: infatti, non esiste soltanto una generazione di figli del tubo catodico: fino ad inizi anni ‘80 la tv aveva ancora un valore didattico, e naufragò soltanto in seguito: oggi, l’aspetto educativo potrebbe essere recuperato proprio attraverso lo sviluppo della rete, nella quale andiamo verso il web semantico, detto anche 3.0. Sarà qualcosa più di un numero e di un nome? Si potrebbe trattare di dare attenzione ai contenuti uscendo dagli abusi comunicativi in cui tutti scrivono ma nessuno legge nemmeno quel che scrive? Potrebbe finire lo spregio annoiato che, di continuo, ingenui e ipocriti accumunati dalla medesima stoltezza compiono dei concetti stessi di elaborazione, documentazione, verifica, correzione, revisione? E se avessi avuto una ruota sarei stato una cariola, dico bene?
Il congiuntivo è una piega, che si potrebbe scegliere oppure no, per motivi d’economia: tuttavia, valutare i contesti discorsivi è davvero così costoso? Lo è dove qualcuno continua a ripetere: «Tu crederai che il lavoro consista nell’inventare nuove parole. Neanche per sogno! Noi distruggiamo le parole, invece. Dozzine, ma che dico? Centinaia di parole ogni giorno. Stiamo riducendo la lingua all’osso. [..] Non ti accorgi che il principale intento della neolingua consiste proprio nel semplificare al massimo le possibilità del pensiero? Giunti che saremo alla fine, renderemo il delitto di pensiero, ovvero lo ‘psicoreato’, del tutto impossibile perché non ci saranno più parole per esprimerlo. Ognuna delle idee che sarà necessaria verrà espressa esattamente da una “unica” parola, il cui significato sarà rigorosamente definito, mentre tutti gli altri significati sussidiari verranno aboliti e dimenticati.»
10. Decondizionamenti sonori: Hugh Hopper
«In 1984 ho fatto tutto il possibile per cambiare i suoni: ho accelerato i nastri, li ho rallentati, li ho fatti girare in senso inverso, ho creato sovrapposizioni di piste. Ho anche usato sul basso un pedale che si chiamava TootleBug e che era uno dei primi pedali analogici per il cambio d’ottava. Avevo anche cominciato a comporre alcuni temi minimali e degli spazi dentro i quali ho aggiunto diverse parti di basso scritte e improvvisate. Poi ho inserito effetti o strumenti strani, utilizzati in modo assolutamente inconsueto, facendo spesso ricorso ai loop. Ho invitato poi altri musicisti a suonare con me, come John Marshall che ha suonato la maggior parte delle percussioni. In alcuni dei pezzi più lunghi, quelli dalla dimensione quasi psichedelica, ho rallentato le tracce che contenevano i piatti della batteria, per evidenziare quella sensazione ruvida ma anche molto fluttuante.»
In un’intervista realizzata nel 2005, quattro anni prima della sua scomparsa, il bassista e compositore Hugh Hopper descrive il lavoro compiuto nel suo primo disco solista del 1973. 1984 è un lavoro di nessuna fortuna commerciale, emblematico della ricerca musicale, che cattura in maniera esemplare le atmosfere cupe ed ossessive del romanzo di Orwell, a cui sono dovuti anche i titoli dei brani, privi di testi (due anni dopo è Diamond Dogs di David Bowie a riuscire in tale impresa). Ne è in qualche modo prologo 1983, la traccia che nello stesso anno, con il pensoso e minimale uso degli intervalli di una grande settima di Fa, chiude Six dei Soft Machine e la proficua partecipazione di Hopper, che è stato anche giornalista e scrittore, ai lavori della proteiforme band inglese.
I paesaggi sonori di 1984 rievocano i quattro ministeri del Socing. Miniluv (Ministero dell’Amore – 14:32) esplora le diverse declinazioni e sovraincisioni di un basso, impegnato in tutto tranne che nel relegarsi al ruolo di accompagnamento, annodato in loop e decostruito in sussulti. Uno stacco sorprendente apre Minipax I (Ministero della Pace – 3:20): i sax di Gary Windo e Lol Coxhill, contrappuntati dai tromboni di Nick Evans e Malcom Griffiths, articolano un tema cromatico discendente in tre quarti, che parte da La, tocca Fa diesis e torna a La, quindi trasposto in Do e poi sviluppato in variazioni sostenute dai riff della chitarra di Pye Hastings e dalla ritmica di John Marshall e Hopper; segue Minipax II (3:14) che tra loop e improvvisazioni intarsia tra loro percussioni, fiati e basso. Minitrue (Ministero della Verità – 1:25), è una frase lunga e spezzata dove tutti i musicisti ci riportano alle coordinate di Facelift dei Soft Machine, scritta dallo stesso Hopper. Miniplenty (Ministero dell’Abbondanza – 17:04) si compone di continue variazioni dove insieme al pulsare e al vorticare del basso giocano anche le distorsioni di chitarra e percussioni minimali. Minitrue reprise (3:18) è caratterizzata da un loop di fiati su cui improvvisa il basso. Chiude il disco Miniluv reprise (5:03) improvvisazione collettiva di solido impianto.
In un incrocio dei suoni straniante e perfetto, il basso elettrico di Hopper dimostra la capacità di essere anche qualsiasi altro strumento, sfuggendo a ogni normativizzazione. Inutile usare parole come jazz-rock-psycho-ambient, nominare parentele e prossimità: questa è musica. Non ci resta che ringraziarlo: più di quarant’anni dopo, a molti può risultare ancora incomprensibile, nel suo essere intenta a scardinare le abitudini d’ascolto con i suoni di un futuro impossibile. Come dice Orwell alla fine del romanzo, è tutto a posto. 1984 non passerà mai. Già sappiamo che se il futuro sarà simile al presente, nessuno potrà ascoltare un messaggio non conforme: se il domani sarà differente, niente di tutto questo avrà significato. Eppure, qualcuno sa: «Ci incontreremo nel luogo dove non c’è tenebra».
•
Tratto da discussioni del gruppo Scritture di LinkedIn, novembre 2013-giugno 2014
Fotografia: Claudio Comandini, “Neolingue” – Sofia, agosto 2002