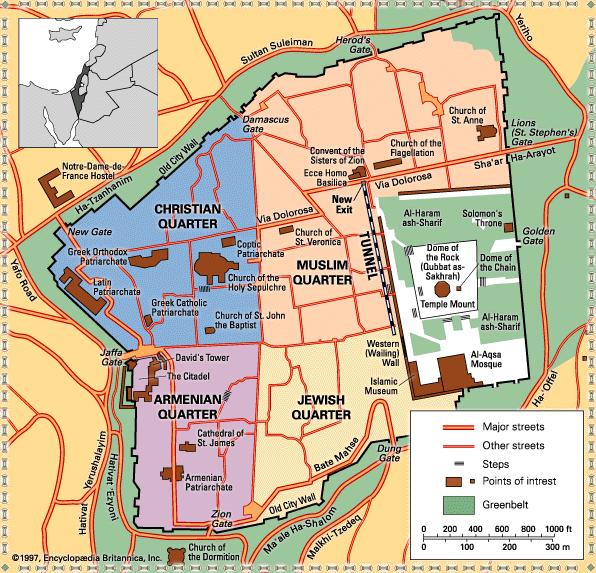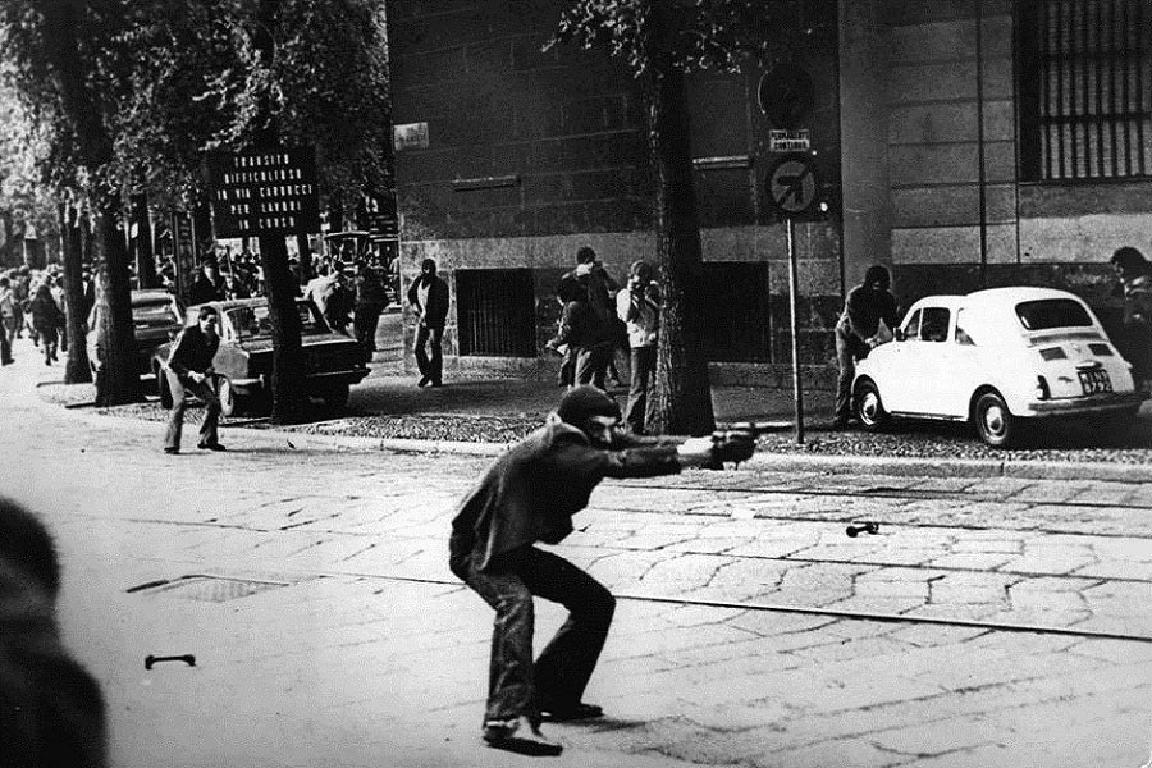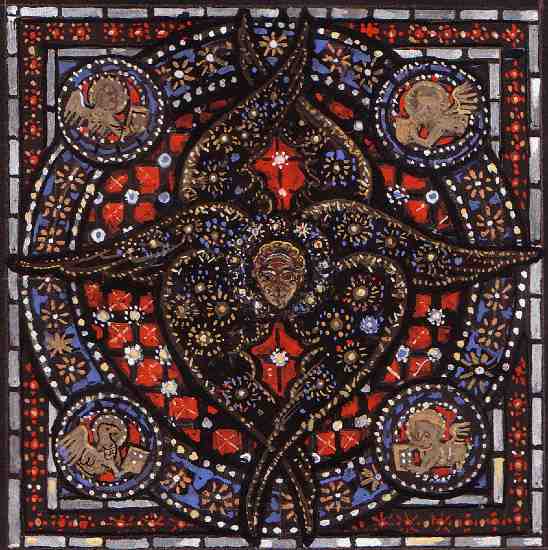Una polemica apparsa recentemente sul The New Yorker a firma di Ruth Ben-Ghiat si chiedeva perché in Italia edifici legati al fascismo, quali il Foro Italico e il Palazzo della Civiltà Italiana (o del Lavoro), non venissero abbattuti. E nel lamentare la presenza di neo-fascisti al Parlamento compiutasi con gli alleati di Berlusconi, che a suo dire nella loro scalata sarebbero addirittura stati aiutati dall’esistenza di palazzi e monumenti e dalla rete di luoghi di pellegrinaggio, ricordava la forte colonizzazione dell’immaginario compiuta da Mussolini durante il ventennio, verso la quale non sarebbe mai stata compiuta alcuna rieducazione analoga a quella tedesca. Tuttavia, se in Italia esiste una recrudescenza fascista, che ha rappresentanze decisamente più impresentabili rispetto alla destra di governo di AN ed eredi, i cui demeriti non vanno comunque minimizzati, questa non trova ragione nei motivi addotti da Ben-Ghiat, che soffrono di più di una superficialità di analisi. Piuttosto, se gli stili di cui si avvalse l’architettura del ventennio furono piuttosto vari e niente affatto disprezzabili, la mancata rieducazione degli italiani dipende soprattutto dalla retorica con cui il Paese ha elaborato l’eredità del ventennio, senza approfondire adeguatamente né i motivi interni né quelli internazionali che ne segnarono la fine e l’inizio. Infatti, come mostrano anche le convulse vicende legate all’8 settembre, fu il parlamento fascista a destituire il Duce, mentre i generali del Re cercarono trattative con gli Alleati e arrivarono in alcuni casi anche collaborare alla Resistenza; da parte loro, gli inizi del fascismo, il cui movimento a fianco della matrice nazionalista ne aveva pure una socialista, ricevettero considerazione piuttosto dignitosa prima da Francia e Inghilterra e poi da esponenti del New Deal americano, con cui comunque non condivideva la forma politica dittatoriale. Insomma, per effettuare un inquadramento storico che non censuri in maniera paradossalmente ’fascista’ un intero periodo storico è opportuno reinquadrare, come da tempo ha fatto Renzo De Felice, l’origine del movimento fascista nelle esigenze di un paese dall’unità incompiuta di organizzare le proprie forze e legittimarsi di fronte ad interlocutori internazionali. Inoltre, dopo venti anni, il regime fascista si sarebbe letteralmente suicidato, lasciando ad ogni modo dietro di sé molti riciclati e diverse istituzioni tuttora in piedi. Il suo fantasma viene invece mantenuto vivo da folckore nostalgico un po’ stantio che riceve linfa anche da un retorico antifascismo dietro cui si nasconde una politica incapace di affrontare i propri compiti. E ciò in larga misura è ancora cronaca.
Quanto è però più interessante da notare a livello storico è come venisse percepito il fascismo agli occhi dei politici degli altri paesi loro contemporanei, sul cui giudizio ovviamente pesava non il futuro massacro del secondo conflitto mondiale ma il crollo della borsa di Wall Street del 1929. Così, come ebbe poi modo di evidenziare per la prima volta in modo sistematico del 1973 lo storico John A. Garraty, le differenze tra le diverse reazioni mondiali alla crisi del liberismo non avevano messo ancora in luce le distinzioni per cui poi giunsero al loro fatale scontro, ed erano complessivamente reputati quali sistemi di capitalismo di stato impegnati a fondare comunità di eguali sulla base di una leadership a base plebiscitaria, alla quale erano particolarmente congeniali gli strumenti di comunicazione di massa. Tali affinità può mostrarle, in modi che la Ben-Ghiat sembra del tutto ignorare, proprio la stessa architettura, anch’essa intenta in ogni paese a liberarsi dal caos stilistico determinato dall’approccio tecnico e funzionale del modernismo, e così rivalutare il carattere simbolico delle opere pubbliche. Roma fu coinvolta da un programma per cui le demolizioni delle città storica dovevano riportare alla luce quella antica e fonderla con i monumenti lineari che ne ostentavano i simboli; Berlino iniziò ad essere smantellata per lasciare così spazio al cantiere di pretesa capitale del mondo di nome Germania; Mosca modernizzò per intero il proprio aspetto pur senza riuscire a completare l’ambizioso palazzo dei Soviet; gli spazi vuoti di Washington furono colmati da opere di gusto neoclassico, europeo e anche fascista il cui esplicito intento era quello «appassionare», in modi che sarebbero piaciuti anche agli urbanisti fascisti, nazisti e comunisti. Cogliere le somiglianze e le divergenze tra le politiche di Roosevelt, Hitler e Mussolini con una solida analisi di programmi e obiettivi, senza nessun revisionismo e consapevoli che «una comparazione non è un’equazione» (Garraty), è l’obiettivo che si è posto Wolfgang Schivelbusch in 3 New Deal (2006), che entrando nel discorso proprio attraverso l’architettura mostra in maniera documentata l’evolversi dei rapporti tra il New Deal americano e i totalitarismi europei.
1. 1933, anno di pace
Se c’è stato un anno di pace, nella prima metà del XX sec., che ha rappresentato il momento più basso del sistema liberaldemocratico e quello più alto del totalitarismo fascista, è stato il 1933. Le repubbliche dell’Europa centrale nate tra tanti squilli di tromba dopo la Grande guerra erano in gran parte governate da dittatori autoritari (con l’importante eccezione della Cecoslovacchia). Il fascismo celebrava il suo undicesimo anno al potere e con le elezioni vinte dai nazional socialisti in Germania la democrazia liberale subiva una sconfitta epocale nella più grande nazione industrializzata del continente. Nel marzo 1933, a simbolica conferma del trionfo, si costituiva un’Internazionale fascista [progetto esclusivamente italiano di intellettuali fascisti inclini al trotzkismo delusi dalla burocratizzazione mussoliniana. Promossa con molta enfasi, agli occhi degli osservatori si risolse nel 1935 in una «truffa colossale».]. [1]
Nei primi giorni di quello stesso mese, Franklin Delano Roosevelt prestava giuramento come presidente degli Stati Uniti: un evento da alcuni considerato una vigorosa reazione dell’America all’evoluzione politica ed economica del mondo, da altri una tacita resa a tale evoluzione. Gli ampi poteri concesso a Roosevelt dal Congresso, prima che l’organismo decadesse, non avevano precedenti in tempo di pace. Attraverso quella “delega di potere”, il Congresso aveva in pratica rinunciato alle proprie prerogative di ramo legislativo del governo. L’unico strumento di controllo sul poter esecutivo restava la Corte suprema.
In Germania un procedimento analogo aveva fatto assumere a Hitler il potere legislativo dopo l’incendio del Reichstag, di sospette origini dolose, il 28 febbraio 1933. Come negli Stati Uniti, il potere giudiziario si sarebbe mantenuto indipendente, almeno per un breve periodo. L’Alta corte tedesca, infatti, assolse i quattro indiziati, tra i quali il comunista bulgaro Georgi Dimitrov, processati per l’incendio del Reichstag, il quello che fu il canto del cingo della magistratura tedesca.
2. La prospettiva europea
I nazionalisti salutarono con favore le misure assistenziali di emergenza attuate nei primi undici giorni delle presidenza Roosevelt, giudicandole in sintonia con il proprio programma rivoluzionario. L’11 maggio 1933, il principale quotidiano nazista, il Völikisher Beobachter, prendeva posizione con un articolo dal titolo Le misure dittatoriali di Roosevelt per la ripresa. L’autore scriveva: «Ciò che che traspare negli Stati Uniti, da quando Roosevelt ha assunto la presidenza, è un chiaro segnale dell’inizio di una nuova epoca anche negli Stati Uniti».
Il tono non era mutato qualche mese dopo, il 17 gennaio 1934: «Anche noi nazionalsocialisti tedeschi guardiamo all’America […] Roosevelt sta facendo esperimenti coraggiosi. Temiamo soltanto che possano fallire.» E il 21 giugno di quell’anno, il giornale trasmetteva le prime conclusioni dall’esito positivo del New Deal: «Roosevelt ha ottenuto quanto era umanamente possibile considerato le basi di partenza limitate e insufficienti».
Come il nazionalismo era seguito al «periodo burocratico» di decadenza della Repubblica di Weimar, sosteneva il Völkisher Beobachter, il New Deal aveva scalzato «la smania sfrenata della speculazione di mercato» degli anni Venti americani. Il giornale sottolineava il fatto che Roosevelt aveva «adottato elementi del pensiero nazionalsocialista per le sue riforme economiche e sociali» e ne lodava lo stile di leadership, paragonabile al Führer-prinzip della dittatura hitleriana: «Anche se non sempre con parole identiche, [Roosevelt] esperta a mettere l’interesse collettivo prima di quelli egoistici e individuali. Molti passi del suo libro “Guardando nel futuro” avrebbero potuto uscire dalla penna di un anzionalsocialista. In ogni caso, si può presumere che egli senta una notevole affinità con la filosofia nazional socialista.»
Il giornale ammetteva che Roosevelt aveva conservato quella che definiva «una parvenza di democrazia», ma proclamava che anche negli Stati Uniti era «in corso un’evoluzione verso uno Stato autoritario». Il commentatore aggiungeva: «Il corso politico del presidente ha ancora in sostanza al proprio interno tendenze democratiche, ma è profondamente segnato da un forte nazionalsocialismo». [2]
Lo stesso Hitler aveva dichiarato all’ambasciatore americano William Dodd di essere «d’accordo con il presidente nel ritenere che i valori del dovere, della disponibilità al sacrificio e della disciplina debbano governare il popolo intero. Queste esigenze morali che il presidente colloca sopra ogni singolo cittadino degli Stati Uniti sono anche la quintessenza della filosofia dello Stato tedesco, che trova la propria espressione nella parola d’ordine: “Il bene pubblico trascende gli interessi dei cittadini”.» Ancora nel 1938, il successore di Dodd, Hugh R. Wilson, riferiva positivamente a Washington delle proprie conversazioni con Hitler:
«Hitler ha poi affermato di avere osservato con interesse i metodi che lei, signor presidente, ha cercato di adottare negli Stati Uniti per far fronte ad alcuni problemi simili a quelli che egli aveva dovuto affrontare una volta assunta la carica. Gli ho risposto che nel mio ancor breve soggiorno in Germania devo già avuto modo di notare le analogie tra alcune difficoltà economiche che lei sta tentando di superare e quelle che egli aveva affrontato e, in taluni casi, risolto. Ho anche aggiunto che lei aveva un fortissimo interesse per certi aspetti dell’intervento sociale in corso in Germania, soprattutto verso i giovani e gli operai, e che uno dei miei primi compiti sarebbe consistito nel riferirle del loro svolgimento.» [3]
Va aggiunto che non erano solo i nazisti a osservare da questa prospettiva le vicende americane durante la presidenza Roosevelt. Anche la stampa tedesca non di partito, che fino al 1936 fu in gran pare libertà di parlare degli Stati Uniti come riteneva più opportuno, dipigeva Roosevelt alla stregua di un leader carismatico e autoritario e definiva gli interventi della sua amministrazione come quelli di una dittatura economica, da socialismo di Stato. La stampa non nazista era meno interessata a fare confronti espliciti, ma il principale quotidiano del paese, la Frankfurter Zeitung, continuava ad annoverare Roosevelt «tra gli uomini che hanno compreso lo spirito collettivo del proprio popolo e che, con energia giovanile e ipnotica, sanno ispirare nuova fiducia e nuovo vigore alle masse, le quali altrimenti oscillano continuamente tra dubbio e speranza». Il giornale arrivava a questa conclusione: «Roosevelt è un leader [Führer] e un riformatore del suo popolo, in una fase nuova della vita comunitaria». [4]
Gli osservatori inglesi e francesi fecero un ritratto non dissimile dipingendo Roosevelt sistematicamente come un comandante in tempi di emergenza, sulla falsariga di un dictator dell’antica Roma repubblicana o come un autocrate plebiscitario alla Mussolini (più di rado si citava Hitler). Il francese Bernard Fay, ammiratore del presidente americano, così lo definiva: «Un autentico dittatore, sostenuto dall’affetto e dall’entusiasmo delle masse». [5]
I paragoni con il fascismo erano facilitati dal fatto che il regime di Mussolini, a differenza del nazionalsocialismo, era già a potere da vari anni. Aveva superato la fase iniziale di violenza rivoluzionaria ed era ormai accettato dalle democrazie occidentali, nonostante l’impronta dittatoriale, come membro legittimo della comunità politica internazionale. Mussolini si dimostrava un apprezzato bastione contro il bolscevismo, merito che le democrazie occidentali ancora non riconoscevano a Hitler, da poco annesso al potere. Questa è l’unica spiegazione del riconoscimento internazionale di cui godette il fascismo già negli anni Venti e fino all’invasione dell’Etiopia del 1935. Agli occhi dell’Occidente, Mussolini era un leader mondiale legittimo, il carismatico contraltare di Lenin, e il suo regime offriva una prima efficace linea di difesa contro il comunismo. Il nazionalsocialimo invece, nonostante la retorica antibolscevica, era considerato pericolosamente rivoluzionario e, nella sua componente comunitaria, addirittura protobolscevico. [6]
Un ulteriore e più specifico motivo per cui, nel 1933, il New Deal era messo sovente a confronto con il fascismo era il seguente: l’Italia, sfruttando una massiccia campagna di propaganda, aveva da diversi anni avviato la transizione da un sistema di libero mercato a uno a gestione pubblica o corporativo. Negli anni Trenta il corporativismo era visto, sul piano internazionale, come una reazione perfettamente comprensibile al crollo dell’economia liberista, allo stesso modo della politica di autosufficienza nazionale e di separazione dell’economia mondiale praticata nell’Unione Sovietica sotto Stalin.
Certo, il programma corporativismo italiano, che lo storico Maurizio Vaudagna definisce «l’innovazione più originale del fascismo fino a quel momento», appariva di gran lunga preferibile al «grande balzo in avanti» del comunismo, perché non comportava l’abolizione della proprietà privata. [7] Gli analisti del periodo non potevano non notare elementi di corporativismo nella gestione roosveltiana dell’economia attraverso la National Recovery Administration, l’ente costituito nel 1933 per stabilire i “codici” obbligatori di produzione e di prezzo per l’industria americana. La stampa italiana era attentissima a tali analogie e Mussolini aveva posto le basi per un confronto del genere in una recensione da lui scritta del libro di Roosevelt Guardando nel futuro. Per un verso, identificava un’affinità spirituale: «L’appello alla risolutezza e alla sobrietà virile della gioventù nazionale, con cui Roosevelt esorta qui alla lotta i suoi lettori, ricorda i modi e i mezzi con cui il fascismo ha ridestato il popolo italiano.»
In altri passi, Mussolini era più riservato: «Spesso ci si domanda, in America come in Europa, quanto ‘fascismo’ sia presente nel programma del presidente degli Stati Uniti. Dobbiamo stare attenti a non eccedere nelle generalizzazioni. Ricorda il fascismo il principio secondo il quale lo Stato non lascia più l’economia al controllo dei suoi specifici meccanismi, avendo riconosciuto che il benessere economico coincide con quello del popolo. Senza dubbio lo spirito che accompagna questo cambio di rotta somiglia a quello del fascismo. Più di questo, per il momento, non si può affermare.» [8]
Le riserve di Mussolini rispecchiavano l’etichetta in uso tra i leader mondiali, che cercavano di evitare di apparire troppo di parte: nel luglio 1933, mese in cui uscì l’articolo del Duce, il suo ufficio stampa aveva ricevuto l’ordine di non definire fascista il New Deal, perché questo avrebbe offerto graditi argomenti agli avversari politici di Roosevelt negli Stati Uniti. [9] Un anno dopo, Mussolini si era abbastanza convinto della saldezza della posizione del presidente da lasciare da parte la diplomazia nella scelta delle parole. Nella sua recensione dell’edizione italiana di Nuovi orizzonti, di Henry A. Wallace, segretario dell’Agricoltura dell’amministrazione Roosevelt, scriveva:
«Il libro nel suo insieme è tanto ‘corporativista’ quanto lo sono le singole soluzioni avanzate. È una dichiarazione di fede e un atto di accusa ne confronti del liberismo […]. La risposta di Wallace all’interrogativo si quello che vuole l’America è questa: tutto tranne un ritorno al libero mercato, all’economia anarchica. Dove va l’America? Questo libro non lascia dubbi: è sulla strada del corporativismo, il sistema economico di questo secolo.» [10]
Nonostante il precedente diktat del Duce, la stampa italiana faceva frequenti paragoni tra Stati Uniti e Italia, e il dibattito si svolgeva in un clima che lo storico Marco sedia definisce «di completa libertà». [11] C’era un accordo unanime sul fatto che il New Deal, nel suo orientamento economico e sociale, fosse antiliberale come il fascismo. Nella rivista di teoria politica del Partito fascista Gerarchia, Giovanni Selvi sosteneva che i piani della National Recovery Administration «recavano il segno del fascismo» ed erano un «corporativismo senza corporazioni». [12]
Ciò che creava più problemi, in questi confronti, era che il New Deal, a differenza del fascismo, non cercava di fare a meno del sistema democratico. Un autore fascista tentò di chiosare la differenza: «Anche negli Stati Uniti il capitalismo è entrato nella sua fase corporativa». Un altro si limiti ad asserire che l’ordine economico postliberale «collega il movimento liberale al fascismo che a tutti gli altri esperimenti sociali che si rifanno al modello italiano». Altri ancora, per spiegare le differenze tra i due sistemi politici, si concentravano sull’analisi delle personalità di Mussolini e di Roosevelt, mettendo in luce il vigore, la forza di volontà del presidente americano, nonché la sua «modernità di prospettiva, che lo colloca senza alcun dubbio tra gli statisti di nuovo tipo». [13]
Oltre ad aver accolto con favore gli elementi economici postliberali del New Deal, i nazionalisti e i fascisti videro nell’elezione di Roosevelt una straordinaria occasione di propaganda, in quanto dava loro la possibilità di sostenere che la nazione più potente del mondo aveva imboccato las testa via da loro percorsa e sostenuta da anni. In un sol colpo, i fascisti si presentavano come una potenza mondiale, la cui influenza travalicava i confini nazionali.
Un simile autoritratto, tuttavia, non mancava di consapevoli dissonanze. Da un punto di vista psicologico, il Duce e il Führer si trovavano nella stessa situazione di un proprietario di una bettola malfamata, nella quale, tra la sorpresa generale, era arrivata la prenotazione di un ricco gentiluomo. Si sentivano orgogliosi e contenti, o provavano un misto di simpatia e di disprezzo per quell’uomo che era caduto tanto in basso da non avere nessun altro posto dove andare? Nei discorsi degli italiani e dei tedeschi sul New Deal sono evidenti entrambi i tipi di reazione. Nel 1933, quanto stava avvenendo in America offriva motivi di soddisfazione, e nazisti e fascisti si vedevano legittimati dalla nazione più potente della terra. Un paio d’anni più tardi, però, italiani e tedeschi cominciarono a prendere le distanze.
La ragione principale di questa inversione di rotta fu il raffreddamento delle relazioni tra i paesi liberal-democratici e quelli fascisti in seguito all’invasione italiana dell’Etiopia, nel 1935, e al coinvolgimento italo-tedesco nella guerra civile spagnola, agli occhi dell’Occidente entrambi esempi di espansionismo totalitario. Italiani e tedeschi non presero seriamente le voci antifasciste provenienti da Washington, in seguito a quello che era percepito come il fallimento economico del New Deal. «Gli Stati Uniti», azzardava un periodico tedesco, «sono privi di un’unità nazionale e di una guida diretta, presupposti decisivi per il successo di riforme coraggiose come quelle che Roosevelt aveva avviato nel 1933.» Lo stesso giornale aggiungeva che, a differenza del New Deal, «la rivoluzione nazionalsocialista ha mantenuto le proprie promesse». [14]
La critica non mancava di argomenti concreti. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti era salito in modo notevole nel 1937, ritornando quasi ai livelli del 1932, mentre Germania e Italia godevano della piena occupazione. Se si accettava l’interpretazione oggi unanimemente condivisa dagli storici, secondo la quale gli Stati Uniti sarebbero del tutto usciti dalla Depressione soltanto con l’ingresso nel conflitto mondiale, ci si presentava un ulteriore parallelismo tra fascismo/nazismo e New Deal. Tutte e tre i sistemi ideologici avevano bisogno del riarmo e della guerra per riportare in piena salute le economie nazionali.
3. La prospettiva americana
Probabilmente non stupirà che i confronti tra il New Deal e le ideologie totalitarie fossero parte integrante della retorica quotidiana degli avversari interni di Roosevelt. Un senatore repubblicano dell’epoca sostenne che la National Recovery Administration (Nra) si era «spostata sin troppo in direzione della Russia», mentre perfino un democratico la criticava per aver tentato di «trapiantare l’hitlerismo in tutti gli angoli di questo paese». Herbert Hoover esortava alla resistenza aperta nei confronti delle politiche della Nra: «Dobbiamo batterci per un governo che ritrovi le sue basi nelle libertà e nelle opportunità individuali, che erano le basi stesse della visione americana. Se perdessimo, continueremmo lungo la strada del New Deal che ci porta a un governo di tipo personale basato su teorie collettiviste. Con idee del genere il nostro può trasformarsi in uno Stato d’impianto fascista». [15]
Sentimenti del genere potevano certamente essere ascritti alle normali polemiche di parte e alle rivalità interne ai partiti, se non fosse per il fatto che erano ripresi anche da intellettuali attenti alle scene politiche e sociali, i quali erano per altri versi vicini a Roosevelt. Il giornalista liberale Mauritz Hallgren scriveva sullo Spectator: «Noi americani siamo destinati a dipendere molto dallo Stato come unico mezzo per salvare il sistema capitalistico. Senza il seguito di eserciti in camicia nera e di azzimati dittatori economici (almeno per il momento) siamo sospinti in modo rapido e definitivo verso il fascismo […]. E in un altro passo osservava: «Sono certo che in questo paese si presenterà gradualmente, camuffato con orpelli democratici per non spaventare la gente. Ma quando arriverà, non avrà sostanziali differenze dai regimi fascisti dell’Italia, e della Germania. Ecco il ruolo di Roosevelt: far sì che il popolo rimanga convinto che il capitalismo di Stato in costruzione sia del tutto democratico e costituzionale.» [16]
Sulla North American Review, Roger Shaw rincarava la dose: «Stranamente, i fautori del New Deal ricorrono a mezzi fascisti per fini liberali. La Nra, con il suo sistema di norme, le clausole che regolano l’economia, e certi aspetti tesi a migliorare la situazione sociale, è stata un semplice adattamento meccanico dello Stato corporativo italiano nei propri meccanismi. La filosofia del New Deal assomiglia da vicino a quella del Partito Laburista inglese, ma i suoi meccanismi sono stati presi a prestito dall’antitesi italiana al laburismo.» [17]
Da un punto di vista marxista in qualche modo piùortodosso, V. F. Calverton scriveva sul Modern Monthly: «La Nra, pur senza assumere modi fascisti, sta facendo ciò che il fascismo europeo è deciso a compiere, cioè la liquidazione dell’uomo comune e la morte della piccola impresa come forza economica. Così Franklin Delano Roosevelt, eletto dai dimenticati d’America, diventa il padre di una strategia economica che di propone per sua stessa natura di far sprofondare nell’oblio completo quei dimenticati, estinguendoli come classe. Così facendo, raggiunge uno degli obiettivi economici che il fascismo sta conseguendo con metodi più drastici e violenti.» [18]
Sulla stessa rivista, il capo dell’American Socialist Party, Norman Thomas, si esprimeva in questo modo: «Le analogie tra l’economia del New Deal e quella dello Stato corporativo di Mussolini o dello Stato totalitario di Hitler sono strette ed evidenti. Lo stile ‘liberale’ con il quale Roosevelt ha finora rivestito la sua irregimentazione non muta la sostanza sta mostrando ormai la corda». [19]
«Stiamo sperimentando l’economia fascista, senza averne sofferto i guasti sociali e politici» affermava George Soule, il direttore liberale di New Republic, nel libro The Coming American Revolution, pubblicato nel 1934. [20] Sul Political Quarterly, Oswald Garrison Villard era molto più scettico: «Nessuno può negare che l’intera legislazione Roosevelt abbia enormemente accresciuto l’autorità del presidente, gli abbia conferito alcuni poteri dittatoriali e abbia stabilito precedenti che renderebbero facile a un qualsiasi successore di Mr. Roosevelt, o a lui stesso, di instradarci sulla via del fascismo o del socialismo di Stato.» [21]
Nel 1934, un articolo per Harper’s Magazine di Joseph Brown Matthews e Ruth Enalda Shallcross si chiedeva: «L’America deve diventare fascista?» Gli autori rispondevano: «Nella natura stessa del piano di ripresa, dei suoi metodi e dei suoi obiettivi, è possibile osservare una tendenza che, se spinta alle logiche conclusioni, porta alla fase fascista del controllo dell’economia. Le misure blande non hanno funzionato e con il loro fallimento hanno aperto le strade verso il controllo fascista.» [22] Gilbert H.Montague, nell’edizione del 1935 degli Annali of the American Academy of Political and Social Sciences, aveva avanzato questa conclusione: «La Nra corrispondeva a una forma di legiferazione che era inconsapevolmente, ma comunque nella sostanza, fascista». [23]
In termini generali, dunque, gli osservatori americani presentavano un quadro analogo a quello dei loro omologhi europei, riguardo alle affinità tra New Deal e fascismo. L’uno e l’altro erano giudicati espressioni di uno stile di governo postliberale, la cui spinta principale era in direzione della pianificazione sociale e dell’economia guidata dallo Stato. Allo stesso tempo, i commentatori americani sottolineavano una differenza di fondo: il New Deal, contrariamente al fascismo, aveva preservato le libertà civili individuali. A questo punto l’interrogativo sorgeva spontaneo: il New Deal era la risposta americana al fascismo, o il primo sintomo di un’infezione fascista? In un articolo sul New York Times, Norman Thomas si chiedeva: «In che misura possiamo aspettarci di avere un’economia fascista senza una politica fascista?» [24]
Gli stessi uomini del New Deal cercavano sempre di evitare, almeno in pubblico, di dare l’impressione che le proprie scelte politiche avessero punti di contatto con i sistemi autocratici europei. La cosa non deve sorprendere, perché il maggior timore dei politici americani degli anni Trenta era quello di essere etichettati come “antiamericani”. Ci furono, però, eccezioni, e alcuni membri del governo ammisero l’esistenza di affinità. Lo stesso Roosevelt, in presenza di giornalisti, parlò di Mussolini e di Stalin come di «fratelli di sangue». In occasione del pubblico annuncio del Natonal Industrial Recovery Act, il presidente, riferendosi alle associazioni industriali appena ricostituite, le chiamò modern guilds, e le persone attente alla terminologia non stentarono a riconoscervi l’implicito riferimento al sistema delle corporazioni fasciste. [25]
In privato Roosevelt era molto più esplicito nell’esprimere simpatia nei confronti di Mussolini e interesse per l’ordine sociale ed economico del Duce. Se rispetto alla vision sociale, ideologia e politica di Hitler aveva sempre avvertito una distanza profonda, per Mussolini, fino alla metà degli anni Trenta, aveva provato «simpatia e fiducia». [26] A un corrispondente alla Casa Bianca confidò: «Non mi perito di dirle, in confidenza, che mi tengo in contatto piuttosto stretto con quel degno gentleman italiano».
Uno dei suoi primi atti, appena salito alla presidenza, nel marzo 1933, fu la nomina di Breckinridge Long ad ambasciatore a Roma. Costui, da tempo alleato politico di Roosevelt, non aveva mai fatto mistero del proprio entusiasmo per il modello sociale fascista. Il presidente si faceva mandare rapporti da Roma direttamente da Long e non, come prassi, attraverso il Dipartimento di stato. Quando ricevette una prima entusiastica missiva dall’ambasciatore, si dice che abbia dichiarato: «Pare che non ci siano dubbi sul fatto che [Mussolini] sia interessante a quello che stiamo facendo, e anch’io sono interessato a molto colpito da quanto ha realizzato e dalle sue intenzioni senza dubbio oneste di riformare l’Italia». [27]
Lo stesso atteggiamento si riscontrava in coloro che collaboravano a stretto contatto con il presidente, per quanto fossero attenti a non ammettere pubblicamente la convergenza tra quanto facevano nel loro paese e i modelli fascisti, né l’interesse di alcuni di loro per gli esperimenti comunisti in Unione Sovietica. Non esistono prove inoppugnabili dell’accusa secondo la quale il capo della Nra, Hugh Johnson, fosse talmente entusiasta di un libro sul corporativismo italiano, da regalarlo spesso ad amici e conoscenti, [28] ma molte testimonianze dimostrano le affinità filofasciste dei circoli interni e vicini al New Deal.
Rexford Tugwell, l’uomo considerato più a sinistra del trust di cervelli di Roosevelt, che manifestava senza remore la propria ammirazione per l’economia pianificata sovietica, era altrettanto scatto nel dimostrare rispetto per e riforme politiche di Mussolini, pur essendo ostile al fascismo per ragioni ideologiche. Di ritorno da un viaggio conoscitivo in Italia, Tugwell notava sul proprio diario che nel tentativo di superare la crisi economica e di modernizzare la società, il regime di Mussolini aveva fatto «molte cose che a me sembrano necessarie. E in ogni caso [l’Italia] viene ricostruita materialmente e in modo sistematico. Mussolini ha senza dubbio gli stessi oppositori di FDR, ma controlla la stampa e così costoro non possono stellare le loro fandonie tutti i giorni. Governa un paese compatto e disciplinato, anche se con risorse insufficienti. Almeno in superficie, sembra aver compiuto un enorme progresso.»
Tugwell era rimasto anche colpito dalla capacità del fascismo di farsi motore del cambiamento: «È la macchina sociale più scorrevole e netta, la più efficiente che io abbia mai visto. E ne sono invidioso». [29] Non era l’unico a provare invidia per la facilità con cui Mussolini sembrava aver riformato la società italiana. Lorena Hickok intima amica di Eleanor Roosevelt e giornalista autrice di reportage sul New Deal, criticando un certo funzionario di un ente locale, scriveva: «Se Roosevelt fosse davvero un dittatore, riuscirebbe a concludere qualcosa. Ma così non c’è speranza». E poi aggiungeva: «Sono quasi costretta a trovarmi d’accordo con lui. Avessi vent’anni e pesassi trenta chili di meno, credo che mi verrebbe voglia di fare la Giovanna D’Arco del movimento fascista negli Stati Uniti». [30]
Adolf Hitler e il nazionalsocialismo non godettero mai di quel misto di rispetto e simpatia che l’amministrazione Roosevelt dimostrava verso Mussolini e il fascismo. Questo fatto, però, non impedì a Washington di esaminare a fondo le misure e i programmi avviati da Berlino, per vedere se fossero in qualche modo imitabili. Il segretario degli interni di Roosevelt, Harold Ickes, per esempio, aveva dichiarato: «Ciò che facciamo in questo paese è analogo a quanto si sta facendo anche in Russia e addirittura sotto Hitler in Germania. Solo che lo facciamo in maniera metodica». [31]
In un certo senso, il diverso atteggiamento di Washington verso l’Italia e la Germania era un riflesso degli stereotipi nazionali. L’Italia era il paese dell’operetta, incapace di costituire una minaccia. La Germania rappresentava esattamente l’opposto. Era stata la principale avversaria dell’America nella Grande guerra, demonizzata dalla propaganda e sconfitta solo al costo di un enorme sforzo. Fin dai suoi esordi il nazionalsocialismo si presentava come la manifestazione più estrema dell’aggressività e della barbarie teutonica. L’immagine propagandistica della Prima guerra mondiale, di soldati tedeschi che infilzavano i bambini belgi sulle baionette, era stata direttamente trasferita ai pogrom antiebraici, mentre era finita nel dimenticatoio l’immagine innocua e inoffensiva che la Germania aveva trasmesso di sé nei 14 anni della repubblica di Weimar.
Inoltre, all’inizio degli anni Trenta erano ancora vividi gli echi della rivoluzione nazista, mentre le violenze di piazza che avevano accompagnato l’ascesa al potere di Mussolini erano ormai solo un ricordo. L’indignazione dei liberali davanti alle violenze perpetrate dai fascisti ai danni degli avversari politici era da tempo svaporata, lasciando il posto all’ammirazione per la puntualità con cui la rete ferroviaria italiana rispettava gli orari.
•
[1] Micheal Ledeen, Universal Fascism: The Theory and Practice of the Fascist International, 1928-1936, New York 1972, pp. 125-6.
[2] Hans-Jürgen Scröder, Deutschland und die Vereinigten Staate, 1933-1939, Wiesbaden 1970, p. 93; Hans-Jürgen Scröder, Das Dritte Reich un die Usa), in AAVV, Die Usa und Deutschland, 1918-1975, Monaco 1978, pp. 117-8; Harald Frisch, Das deutsche Roosevelbild (1933-1941), tesi di dottorato, Freiuniversität Berlin 1967, p. 35; Phillip Gasest, Amerika in Dritten Reich, Stuttgart 1997, pp. 210-2.
[3] William Dodd, in Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs, Cambridge, Massachusetts 1969, vol. II, p. 27; Woodrow Wilson, in Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs, 2nd sir., New York 1995, vol. IX, pp. 21-22.
[4] Harald Frisch, Das deutsche Roosevelbild (1933-1941), cit.; Kiran Klaus Patel, Amerika als Argument: Die Wahrnehmung des New Deal am Anfang des ‘Dritten Reiches’, tesi di dottorato, Humboldt Univirsität Berlin, anche in Amerikastudien, vol. XV, 2000; Michael Freund, Deutsche Zeitschrift, vol. XLVII (1933-1934), p. 310.
[5] Bernard Fay, Roosevelt and His America, Boston 1934, p. 310; Fenner Brockway, Will Roosevelt Succeed, in John Dizikes, Britain, Roosevelt and the New deal: British opinion, 1932-1938, New York 1979, pp. 96, 166-7.
[6] Hamilton Fish Armstrong, Hitler’s Reich, «Foreign Affairs» vol. XI (06.1933), p. 595; Wolfgang Schilder, Das italienische Experiment: Der Faschismus als Vorbild in der Krise der Weimarer Republik, «Historisches Zeitschrift» vol. CCLXII (1996), pp. 72-125, 84, 99.
[7] Maurizio Vaudagna, New Deal e corporativismo nelle riviste politiche ed economiche italiane, in Massimo Teodori (a cura di), Italia e America dalla Grande Guerra a oggi, Roma 1986, p. 103.
[8] Benito Mussolini, Recensione a “Guardando nel futuro” di Franklin Delano Roosevelt, «Popolo d’Italia» 7.07.1933; anche in Marco Sedda, Il New Deal nella pubblicità politica italiana dal 1933 al 1938, «Il Politico», vol. LXIV (1999), p. 250.
[9] Maurizio Vaudagna, Corporativismo e New Deal, Torino 1981, p. 201; Maurizio Vaudagna, Mussolini e Roosevelt, in Cornelis A. van Mine and John G. Sears, Roosevelt and His Contemporaries, New York 1992, p. 165.
[10] Marco Sedda, Il New Deal nella pubblicità politica italiana dal 1933 al 1938, cit., p. 263.
[11] Ibid, p. 247.
[12] Giovanni Selvi, Fermentazione fascista nel mondo, in Gerarchia (1935), pp. 576-7.
[13] Marco Sedda, Il New Deal nella pubblicità politica italiana dal 1933 al 1938, cit., pp. 252, 258, 265; Rosaria Quartaro, Roma e Mosca: l’immagine dell’Urss nella stampa fascista, 1925-1935, in Storia contemporanea, vol. XXVII (1996) pp. 447-72.
[14] Die deutsche Volkswirtschaft, vol. II (1938), p. 75, vol. III (1938), p. 100.
[15] Herbert Hoover, Addresses Upon the American Road, New York 1938, p. 160; George Wolfskill and John A. Hudson, All But the People: Franklin D. Roosevelt and His Critics, 1933-1939, London 1969, p. 214.
[16] Mauritz Hallgreen, «Spectator» 18.08.1933, p. 211; Arthur A. Ekirch, Ideologies and Utopia: The Impact of the New Deal on American Thought, Chicago 1969, pp. 188-9.
[17] Roger Shaw, Fascism and the New Deal, «North America Rewiev» vol. CCXXXVIII (1934), p. 472.
[18] V. F. Calverton, Will Fascism Come to America?, «Modern Monthly, vol. VIII (1934), pp. 559, 562.
[19] Ibid, p. 462; George E. Sokolsky, America Drift Toward Fascism, «American Mercury», vol. XXXII (1934), p. 259.
[20] George Soule, The Coming America Revolution, New York 1934, p. 294.
[21] Oswald Garrisn Villard, «Political Quarterly», vol. V (1934) pp. 53-54.
[22] Joseph Brown, Matthews and Ruth Enalda Shallcross, Must America Go Fascist?, «Harper’s Magazine», vol. CLXIX (1934), pp. 53-54.
[23] Gilbert H, Montague, «Annals of the American Academy of Political and Social Sciences», vol. CLXXX (1935), p. 159.
[24] Norman Thomas, Is the New Deal Socialism? A Socialist Leader Answer, «New York Times» 18.06.1933.
[25] Franklin D. Roosevelt, citato in Arthur M. Schlesinger, The Politics of Upheaval (The Age of Roosevelt vol. III), Boston 1960, p. 648; Franklin D. Roosevelt, The Public Papers and Addresses, New York 1938, vol. II, p. 252.
[26] Maurizio Vaudagna, Mussolini e Roosevelt, cit., p. 158.
[27] Breckinridge Long, citato in John P. Diggins, Mussolini and Fascism: The View from America, Princeton 1972, p. 279; Maurizio Vaudagna, Il corporativismo nel giudizio dei diplomatici americani a Roma, 1930-1935, «Studi Storici» (07-08.1975), pp. 772-sgg.
[28] Fausto Pitigliani, The Italian Corporative State, Londra 1933.
[29] Micheal Vincent Namorato, The Diary of Rexford G. Tugwell: The New Deal, 1932-1935, New York 1991, pp.138-9; James C. Wright, Capital and Labor Under Fascism, National Archive, Record Group 9, Records of the National Recovery Administration, Special Research and Planning Reports and Memoranda, 1933-5, Entry 31, Box 3).
[30] Richard Lowitt and Maurine Beasley, One Third of a Nation: Lorena Hickock Reports on the Great Depression, Urbana 1981, p. 218.
[31] Harold Ickes, citato in Lewis S. Four, American Travelers to the Soviet Union, 1917-1932. The Formation of a Component of New Deal Ideology, «American Quarterly» vol. XIV (1962); Kiran Klaus Patel, Soldaten der Albeit, Gottinga, 2003, pp. 412-13.

•
Fotografia: “Fascist Architecture in Washington: Lisner Auditorium by Faulkner & Kingsbury” (1941-1943)
Wolfgang Schivelbusch, “3 New Deal” (2006), Marco Tropea Editore 2008, pp. 23-36. Traduzione di Guido Lagomarsino.