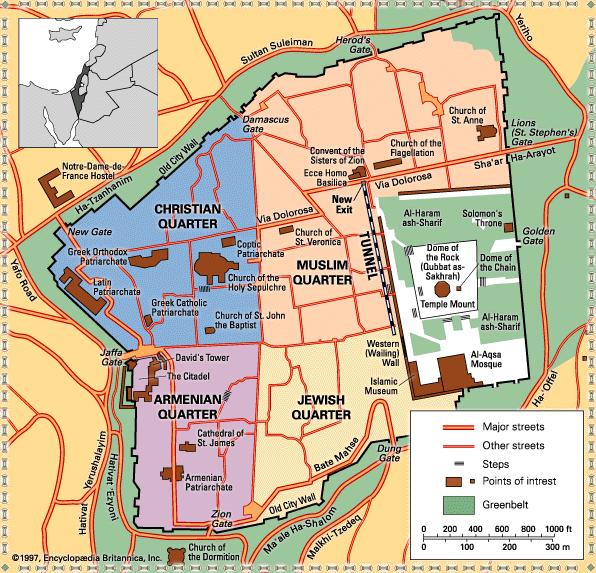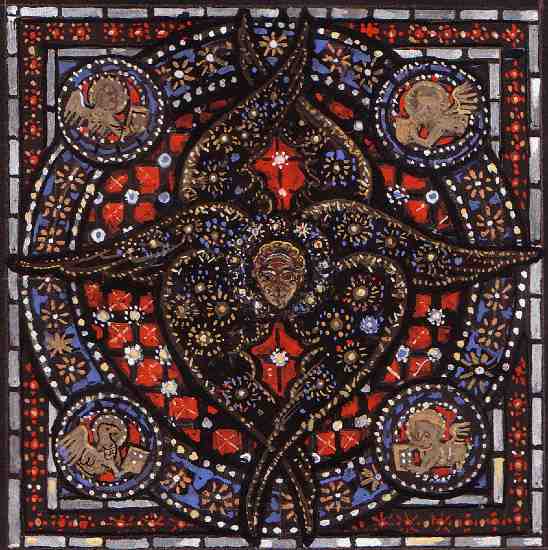I social media hanno fagocitato le notizie – minacciando il consolidamento delle cronache giornalistiche di pubblico interesse e inaugurando un’era nella quale ognuno rivendica la creazione di fatti a proprio arbitrio. Questo tradisce del tutto il modello, aperto e agerarchico, al quale originariamente si era fatto riferimento per la Rete, e le conseguenze vanno molto al di là del giornalismo e riguardano sopratutto le nuove dinamiche di potere venutesi a creare, particolarmente brutali. E se c’è stato un tempo nel quale qualcuno era arrivato a credere che Internet avrebbe permesso una specie di repubblica planetaria del giornalismo diffuso, oggi lo spazio virtuale è perlopiù filtrato nel chiuso recinto dei social e vi prevale il sensazionalismo più grossolano. La politica sembra assimilarne i modi a tutti i livelli favorendo e assecondando populismi che minano a loro volta la fiducia nelle istituzioni, compresa la stampa, permettono il diffondersi di narcisismi autoreferenziali e distruttivi nei confronti di programmi e contenuti. Tuttavia, tale modello non regge né di fronte alla complessità del mondo, né nei confronti di quelli che sono i doveri dell’informazione. Un articolo di Katharine Viner, caporedattore del Guardian.
Un lunedì mattina del settembre 2014, la Gran Bretagna si svegliò con una nuova storia piuttosto depravata. A detta del Daily Mail, il primo ministro David Cameron aveva commesso un «atto osceno con una testa di maiale morto». Il giornale riportava: «Un insigne contemporaneo di Oxford afferma che Cameron una volta ha preso parte ad una scandalosa cerimonia di iniziazione presso un evento organizzato dal Piers Gaveston Society, che coinvolge un maiale morto». Piers Gaveston è il nome di una dissoluta società conviviale di Oxford; gli autori della storia hanno sostenuto che la loro fonte fosse un deputato, il quale ha detto di aver visto le prove fotografiche: «Il suo straordinario suggerimento è che il futuro premier abbia inserito una parte piuttosto intima della sua anatomia nell’animale».
La storia, estrapolata da una nuova biografia di Cameron, ha scatenato un immediato furore. Piuttosto volgare, ha rappresentato una grande opportunità per umiliare un primo ministro elitario, e molti ritenuto che suonasse vero per un ex membro del famoso Bullingdon Club. In pochi minuti, #Piggate e #Hameron sono stati trend topic su Twitter, e anche politici di alto livello sono uniti al divertimento: Nicola Sturgeon ha detto che le accuse avevano «intrattenuto tutto il paese», mentre Paddy Ashdown ha scherzato sul fatto che Cameron avesse «grufolato nei titoli di tutti giornali».
In un primo momento, la BBC ha rifiutato di parlare delle accuse, e dal numero 10 di Downing Street hanno fatto sapere che non avrebbero «nobilitato» la storia con una risposta – ma ben presto sono stati costretti ad emettere una smentita. E così, un uomo potente è stata svergognato sessualmente, in un modo che non aveva nulla a che fare con la sua politica di divisione, e in maniere alle quali non avrebbe mai potuto rispondere veramente. Ma a chi poteva importare? Del resto, lui era in grado di sopportarlo.
Poi, dopo una giornata piena di allegria online, è accaduto qualcosa di sconvolgente. Isabel Oakeshott, giornalista del Daily Mail e co-autore della biografia insieme a Lord Ashcroft, un uomo d’affari miliardario, è andato in televisione e ha ammesso che non sapeva se il suo enorme e scandaloso scoop fosse anche vero. Pressata nel fornire una prova per la propria sensazionale affermazione, Oakeshott ha ammesso che non ne aveva alcuna.
«Non siamo potuti andare a fondo delle fonti delle accuse», ha detto Channel 4 News. «Così, abbiamo semplicemente riportato la considerazione fornitaci dalla fonte… senza prendere posizione sul fatto che sia vera oppure no.» In altre parole, non vi era alcuna prova che il primo ministro del Regno Unito avesse davvero «inserito una parte intima della propria anatomia» nelle fauci di un maiale morto – una storia riportata in decine di giornali e ripetuta in milioni di tweet e di aggiornamenti Facebook, che molte persone presumibilmente oggi ancora credono sia vera.
Oakeshott è andata anche oltre, assolvendo se stessa da ogni responsabilità giornalistica, e ha concluso: «Spetta ad altre persone di decidere se devono fornire ad una notizia credibilità o meno». Ovviamente non è la prima volta che affermazioni stravaganti sono state pubblicati sulla base di prove inconsistenti, ma questa è stata una difesa insolitamente sfacciata. Sembra che i giornalisti non siano più tenuti a credere alla veridicità delle proprie storie e, a quanto pare, nemmeno hanno più bisogno di fornire qualche prova. Piuttosto, spetterebbe proprio al lettore – che non conosce nemmeno l’identità della fonte – di decidere per proprio conto se vero o no. Ma in base a cosa? Istinto, intuizione, umore?
Ha quindi più importanza la verità?
•
Nove mesi dopo che la Gran Bretagna si è svegliata ridacchiando sulle ipotetiche intimità suine di Cameron, il paese si alzato la mattina del 24 giugno per la molto reale visione del primo ministro che, in piedi fuori Downing Street alle 8 del mattino, annunciava le proprie dimissioni.
«Il popolo britannico ha votato per lasciare l’Unione Europea e la sua volontà deve essere rispettata», ha dichiarato Cameron. «Non è stata una decisione presa alla leggera, anche perché sul significato di questa decisione tante cose sono state dette da molte organizzazioni diverse. Quindi non vi può essere alcun dubbio sul risultato».
Tuttavia, divenne ben presto chiaro che quasi tutto era ancora in dubbio. Al termine di una campagna elettorale che ha dominato le notizie per mesi, è diventato improvvisamente ovvio che la parte vincente non aveva un piano per come o quando il Regno Unito avrebbe lasciato l’Unione europea – mentre le affermazioni ingannevoli che avevano trascinato la campagna per il Brexit alla vittoria si erano improvvisamente sbriciolate.
Venerdì 24 giugno alle 06:31, poco più di un’ora dopo che il risultato del referendum era diventato chiaro, il leader dell’Ukip Nigel Farage ha ammesso che in una UK post-Brexit non sarebbero in realtà a disposizione i 350 milioni a settimana di riserva da spendere sul servizio sanitario nazionale, un diritto fondamentale della fuoriuscita dalla UE che era stato messo in evidenza persino sul bus che propagandava la campagna di voto per il Leave. Poche ore dopo, l’eurodeputato Tory Daniel Hannan ha dichiarato che l’immigrazione non era suscettibile di essere ridotta – un’altra affermazione chiave.
Non era certo la prima volta che i politici non erano riusciti a fornire quanto avevano promesso, ma potrebbe essere stata la prima volta che hanno ammesso la mattina dopo la vittoria quanto, per tutto il tempo della campagna elettorale, le promesse erano state false. Questo è stato il primo voto importante nell’era della post-verità politica: la fiacca campagna per il remain ha tentato di combattere la fantasia con i fatti, ma rapidamente scoperto che la moneta dei fatti era stata gravemente svalutata.
I fatti preoccupanti e gli esperti preoccupati dalla parte del Remain sono stati respinti con il nome di “Progetto Paura” – e rapidamente neutralizzati da “fatti” opposti: se 99 esperti hanno detto che potrebbe esserci un crollo economico e uno è in disaccordo, la BBC ha informato che ogni parte aveva una visione diversa della situazione. (Questo è un errore disastroso che finisce per oscurare la verità, e riecheggia anche in come da alcuni viene riportata la questione del cambiamento climatico.) Michael Gove ha dichiarato su Sky News che «la gente in questo paese ne ha avuto abbastanza degli esperti». Inoltre ha paragonato 10 premi Nobel economisti che hanno firmato una lettera anti-Brexit agli scienziati nazisti fedeli a Hitler.
Per mesi, la stampa euroscettica ha strombazzato ogni dubbia affermazione e ha criticato aspramente ogni avvertimento degli specialisti, riempiendo le prime pagine confezionando troppi titoli anti-migranti per essere contati – molti dei quali più avanti erano stati tranquillamente corretti in caratteri molto piccoli.
Una settimana prima del voto (lo stesso giorno Nigel Farage ha presentato il suo infiammante manifesto “Breaking Point”, e la deputata laburista Jo Cox, che aveva fatto un’incessante campagna per i rifugiati, è stata uccisa) la copertina del Daily Mail ha dato rilievo ad un’immagine di migranti caricati nella parte posteriore di un camion che entrava nel Regno Unito, con il titolo “Veniamo dall’Europa – fateci entrare!” Il giorno dopo, il Mail e il Sun, che ne aveva anche riportato la storia, sono stati costretti ad ammettere che i clandestini provenivano in realtà da Iraq e Kuwait.
Lo sfacciato disprezzo per i fatti non si è fermato dopo il referendum: in un fine settimana di inizio luglio 2016, la candidata conservatrice alla dirigenza di breve durata Andrea Leadsom, fresca di un ruolo da protagonista nella campagna per il Leave, ha dimostrato il declinante valore delle prove. Dopo aver detto al Times che l’essere madre farebbe di lei un primo ministro migliore della sua rivale Theresa May, ha gridato «giornalismo scandalistico!», e ha accusato il giornale di travisare le proprie osservazioni – anche se lei aveva affermato esattamente questo, in modo chiaro e definitivo e su nastro. Leadsom è un politico post-verità anche rispetto alle sue proprie verità.
Quando un dato di fatto comincia ad assomigliare a quanto viene sentito come vero, diventa molto difficile per chiunque dire qual è la differenza tra fatti che sono veri e i “fatti” che non lo sono. La campagna per l’uscita dalla UE era ben consapevole di questo – e ha preso il massimo vantaggio, con la certezza che la Advertising Standards Authority non ha potere di vigilare sulle rivendicazioni politiche.
Pochi giorni dopo il voto, Arron Banks, il più grande donatore di Ukip e il finanziatore principale della campagna Leave.EU, ha detto al Guardian che la sua squadra ha sempre saputo che i fatti non avrebbe vinto la competizione. «Ma assumere un approccio multimediale in stile americano si», ha detto Banks. «Nella fase iniziale è stato detto che ‘I fatti non funzionano’, e questo è tutto. La campagna per il Remain ha dato rilievo continui ai fatti, semplicemente non funziona. Conta aver modo di relazionarsi con le persone emotivamente. Ed è questo il successo di Trump».
Ma c’è anche poco sorprendente che alcune persone sono rimasti scioccate dopo il risultato della Brexit nello scoprire che questa potrebbe avere gravi conseguenze e pochi dei benefici promessi. Quando i «fatti non funzionano» e gli elettori non si fidano dei media, tutti credono nella loro propria “verità” – e i risultati, come abbiamo appena visto, possono essere devastanti.
Come siamo finiti sin qui? E come si fa a risolvere tale problema?
•
Venticinque anni dopo che il primo sito è andato online, è chiaro che stiamo vivendo un periodo di transizione vertiginoso. 500 anni dopo Gutenberg, la forma dominante delle informazioni è stata la pagina stampata: la conoscenza è stata consegnato principalmente in un formato fisso, il quale ha incoraggiato i lettori a credere in stabile e stabilite verità.
Ora, siamo presi in una serie di battaglie confuse tra le forze opposte: tra verità e menzogna, realtà e rumori di fondo, gentilezza e crudeltà; tra i pochi e i molti, il connesso e l’alienato; tra la piattaforma aperta del web come i suoi architetti l’hanno immaginata e i recinti sbarrati di Facebook e di altri social network; tra un pubblico informato e una folla sconsiderata.
Ciò che è comune a queste lotte – e quanto rende la loro risoluzione una questione piuttosto urgente – è che tutti coinvolgono lo stato deficitario della verità. Questo non significa che non ci siano verità. Significa semplicemente, come quest’anno ha reso molto chiaro, che non possiamo essere d’accordo su quello che queste verità sono, e quando non c’è consenso sulla verità e non c’è modo per realizzarlo, il caos segue al più presto.
Sempre più spesso, ciò che conta quale fatto è semplicemente un’opinione che qualcuno sente come vera – e la tecnologia ha reso molto facile a tali ”fatti” di circolare molto velocemente e di raggiungere questo era inimmaginabile ai tempi di Gutenberg (o anche soltanto dieci anni fa). Una dubbia storia su Cameron e un maiale appare su un tabloid una mattina, e a mezzogiorno è volata sui social media per tutto il mondo trasformandosi in una fonte fidata di notizie. Questo può sembrare cosa da poco, ma le sue conseguenze sono enormi.
«La Verità», come Peter Chippindale e Chris Horrie scritto in Stick It Up Your Punter!, la loro storia del quotidiano The Sun, è una «’bald statement’ (dichiarazione vera pur se priva di prove ) che tutti i giornali stampano a proprio rischio e pericolo». Di solito ci sono diverse verità in contrasto su ogni argomento, ma nell’era della stampa, le parole su una pagina inchiodavano le cose, sia che si rivelassero come vere, oppure no. Le informazioni erano sentite come se fossero la verità, almeno finché il giorno successivo non avesse portato un altro aggiornamento oppure una correzione, e tutti condividevamo un insieme comune di fatti.
Questa “verità” stabilita è stata di solito trasmessa dall’alto: una verità istituita, spesso fissata nella propria posizione da un gruppo dirigente. Tale disposizione non è stata esente da difetti: troppa stampa ha spesso esibito un’inclinazione verso lo status quo e una deferenza nei confronti dell’autorità, ed era proibitivamente difficile per la gente comune sfidare il potere della stampa. Ora, le persone diffidano gran parte di quanto viene presentato come fatto – in particolare se i fatti in questione sono scomodi, o fuori sincronia con le proprie opinioni – e mentre parte di tale sfiducia è fuori luogo, in alcuni casi non lo è affatto.
Nell’era digitale, la pubblicazione di informazioni false è più facile che mai, queste vengono rapidamente condivise e quindi prese per vere – come vediamo spesso proprio in situazioni di emergenza, quando la notizia si sta infrangendo in tempo reale. Per prendere un esempio tra tanti, durante gli attacchi terroristici del novembre 2015 a Parigi, si sono rapidamente diffusi sui social media voci e rumours per cui il Louvre e il Centre Pompidou erano stati colpiti e François Hollande aveva subito un ictus. Gli organi di informazione attendibili sono necessari proprio per demistificare tali panzane.
Talvolta voci come queste diffondo il panico, a volte senza malizia, talvolta invece la manipolazione è deliberata, per le quali una compagnia o un regime pagano la gente per diffondere il loro messaggio. Qualunque sia il motivo, falsità e fatti ora si diffondono allo stesso modo, attraverso ciò che gli accademici chiamano come “informazione a cascata”. Come descrive il giurista ed esperto di molestie online Danielle Citron «la gente promuove quello che pensano gli altri, anche se l’informazione è falsa, fuorviante o incompleta, perché pensano che hanno imparato qualcosa di prezioso.» Questo ciclo si ripete, e prima che tu lo sappia, la cascata diventa inarrestabile. Si condivide un post di un amico su Facebook, forse per mostrare vicinanza o accordo oppure che si è “al corrente”, e in tal modo si estende ad altri la visibilità del loro post.
Algoritmi come quello che potenzia le notizie di Facebook sono progettati per darci sempre di più di quello che secondo loro noi vogliamo – il che significa che la versione del mondo da noi incontrata ogni giorno nel nostro flusso personale è stato invisibilmente curata per rafforzare le nostre credenze preesistenti .
Quando Eli Pariser, il co-fondatore di Upworthy, ha coniato il termine “filter bubble” nel 2011, stava parlando di come il web personalizzato – e in particolare la funzione di ricerca personalizzata di Google, per la quale non esistono due persone che fanno ricerche su Google che si assomigliano – significa che ci sono minori probabilità di essere esposti a informazioni che ci sfidano o che ampliano la nostra visione del mondo, e minori probabilità di incontrare fatti che smentiscono le false informazioni che gli altri hanno condiviso.
L’appello di Pariser, in quel momento, è che chi gestisce le piattaforme dei social media dovrebbero garantire che «la priorità maggiore dei loro algoritmi sia quella di compensare visite e fornire notizie importanti, non soltanto la roba che è più popolare o più auto-convalidata». Tuttavia, in meno di cinque anni, grazie alla incredibile potenza di alcune piattaforme sociali, la “filter bubble” descritta da Pariser descritto è diventata molto più estrema.
Il giorno dopo il referendum UE su un post di Facebook Tom Steinberg, l’attivista Internet britannico e fondatore di mySociety, ha fornito una vivida illustrazione del potere della “filter bubble” – e le gravi conseguenze civili per un mondo nel quale i flussi di informazioni in gran parte attraverso i social network:
«Attraverso Facebook sto cercando attivamente le persone che celebrano la vittoria del Brexit, ma la “filter bubble” è TALMENTE forte, e si estende TALMENTE lontano in cose quali la ricerca personalizzata di Facebook, che non riesco a trovare qualcuno che sia felice *nonostante il fatto che oggi più della metà del paese è chiaramente giubilante* e nonostante il fatto che io stia *attivamente* cercando di sentire quanto stanno dicendo.»
«Il problema di questa camera di risonanza è ora TALMENTE grave e TALMENTE cronico che posso soltanto chiedere ai miei amici che effettivamente lavorano per Facebook e altri importanti social media e con la tecnologia di dire con urgenza ai loro leader che non agire su questo problema immediatamente equivale a sostenere attivamente e consolidare la lacerazione del tessuto delle nostre società… stiamo ottenendo paesi nei quali una metà non sa nulla circa l’altra metà.»
Chiedere però alle aziende di tecnologia di «fare qualcosa» per la “filter bubble” presume che questo sia un problema che possa essere facilmente risolto – piuttosto di considerare che sia parte integrante dell’idea stessa delle social come progettate per darti quello che tu e i tuoi amici volete vedere.
•
Facebook, lanciato soltanto nel 2004, ha ora circa 1,6 miliardi di utenti al mondo. È diventato il modo privilegiato con cui le persone trovano le notizie in Rete – ed è di fatto dominante in maniere che sarebbe stato impossibile immaginare nell’epoca dei giornali. Come ha scritto Emily Bell: «I social media non hanno soltanto fagocitato il giornalismo: hanno inghiottito tutto. Hanno divorato campagne politiche, sistemi bancari, storie personali, il settore del tempo libero, la vendita al dettaglio, persino il governo e la sicurezza.»
Bell, direttore del Tow Center for Digital Journalism alla Columbia University – è un membro del consiglio della Scott Trust, proprietario del Guardian – ha delineato l’impatto sismico dei social media sul giornalismo. «Il nostro ecosistema delle notizie è cambiato forse più drammaticamente negli ultimi cinque anni, che in qualsiasi altro momento nei cinquecento trascorsi.» Il futuro dell’editoria è stato messo nelle «mani di pochi, che ora controllano il destino dei tanti». Gli editori delle notizie hanno perso il controllo sulla distribuzione del loro giornalismo, che per molti lettori è ora «filtrata attraverso algoritmi e piattaforme opache e imprevedibili».
Questo significa che le aziende di social-media sono diventate potentemente schiaccianti nel determinare quanto viene letto – ed enormemente redditizie per la monetizzazione del lavoro di altre persone. Come osserva Bell: «C’è un’enormemente maggiore concentrazione di potere in tal senso rispetto a quanto sia mai stato in passato.»
Pubblicazioni curate da editori sono state in molti casi sostituite da un flusso di informazioni scelte da amici, contatti e familiari, elaborate da algoritmi segreti. La vecchia idea di un wide-open web, di una Rete estesa e aperta, dove i collegamenti ipertestuali da un sito all’altro creassero un network di informazioni non-gerarchico e decentrato, è stata largamente soppiantata da piattaforme progettate per massimizzare il tuo tempo all’interno delle loro mura, alcune delle quali (come Instagram e Snapchat) non consentono a tutti collegamenti verso l’esterno.
Infatti, molte persone, soprattutto adolescenti, ora spendono sempre più tempo su applicazioni di chat chiuse, che permettono agli utenti di creare gruppi per condividere messaggi in privato – forse perché i giovani, che hanno più probabilità di ricevere molestie on-line, sono alla ricerca di spazi sociali protetti con maggiori attenzione. Ma lo spazio chiuso di una chat app è come un silos ancora più restrittivo rispetto al giardino recintato di Facebook o altri social network.
Come ha scritto sul Guardian all’inizio del 2016 il pionieristico blogger iraniano Hossein Derakhshan, imprigionato a Teheran per sei anni per la propria attività on-line, la «diversità che il world wide web aveva inizialmente immaginato» ha lasciato posto alla «centralizzazione delle informazioni» all’interno di pochi e selezionati social network – con il risultato finale di «rendere tutti noi meno potenti nei confronti delle amministrazioni e le aziende».
Naturalmente, Facebook non decide quello che si legge – almeno non nel senso tradizionale che avrebbe il prendere decisioni – e né di dettare quanto deve produrre l’industria delle notizie. Tuttavia, quando una piattaforma diventa la fonte principale per accedere alle informazioni, le società che organizzano le notizie spesso adattano il proprio lavoro alle esigenze di questo nuovo mezzo. (La prova più visibile dell’influenza di Facebook sul giornalismo è il panico che accompagna gli editori ogni cambiamento nell’algoritmo dei feed delle news che minaccia di ridurre loro le pagine visitate dagli utenti).
In questi pochi anni, molti organi di informazione si sono fatte deviare da un giornalismo di interesse pubblico verso notizie “junk-food”, a caccia di pagine visualizzate nella vana speranza di attrarre clic e pubblicità (o investimenti) – ma, come il cibo spazzatura, odi te stesso quando te ne ingozzi. La manifestazione più estrema di tale fenomeno è stata la creazione di aziende preposte alla pubblicazione di notizie false, che attraggono traffico con falsi report, progettati per assomigliare a notizie reali, e quindi ampiamente condivisi sui social network. Lo stesso principio vale però per le notizie che risultano fuorvianti o clamorosamente disoneste, anche se non sono state create per ingannare: per troppi organi di informazione, la nuova misura di valore è la viralità, piuttosto che la verità o la qualità.
Naturalmente, i giornalisti hanno avuto in carico cose sbagliate anche in passato – per errore o pregiudizio o talvolta anche per intento. (Freddie Starr probabilmente non ha mai mangiato un criceto.) Quindi sarebbe un errore pensare che questo è un nuovo fenomeno tipico dell’era digitale. Ciò che è nuovo e significativo è però che oggi, rumours, voci e menzogne sono roba che viene letta in maniera molto diffusa, che vengono letti tanto quanto fatti veri e preziosi – e spesso anche anche di più, in quanto sono più selvaggi della realtà e più emozionanti da condividere.
Il cinismo di tale approccio è stato espresso in maniera ancora più palese da Neetzan Zimmerman, già impiegato presso Gawker come specialista in storie virali ad alto traffico, che già nel 2014 ha affermato: «Al giorno d’oggi non è importante se una storia è reale. L’unica cosa che conta davvero è se gli utenti ci cliccano sopra.» I fatti, ha suggerito, sono ormai finiti: rappresentano una reliquia ereditata dall’era della stampa, quando i lettori non avevano altra scelta. E ha proseguito: «Se una persona non condivide una notizia, questa sostanzialmente non fa notizia.»
La crescente diffusione di tale approccio suggerisce che ci troviamo nel bel mezzo di un cambiamento fondamentale nei valori del giornalismo – un cambiamento di tipo consumista. Invece di rafforzare i legami sociali, o la creazione di un pubblico informato, o l’idea di notizie quali bene civico e necessità democratica, questo cambiamento crea delle gang, i cui membri diffondono falsità istantanee e modellano il proprio parere, rafforzando reciprocamente le proprie credenze e guidandosi l’un l’altro più in profondità nel condividere opinioni piuttosto che fatti accertati.
Ma il guaio è che il modello di business della maggior parte delle organizzazioni che producono informazioni digitali si basa sui click. I mezzi di informazione di tutto il mondo hanno raggiunto il picco della loro febbre al passo di una frenetica sbornia di pubblicazioni, al fine di racimolare centesimi e centesimi di pubblicità digitale. (E non c’è poi molta pubblicità da ottenere: nel primo trimestre del 2016, 85 centesimi di ogni nuovo dollaro speso in pubblicità online negli USA, che prima andava agli editori di notizie, è stato preso da Google e Facebook.)
Nei feed di notizie viste sul telefono, tutte le storie sembrano le stesse – tanto se provengono da una fonte credibile o meno. E, sempre di più, fonti altrimenti credibili stanno pubblicando anche notizie false o fuorvianti, o storie deliberatamente indegne. «Regna il clickbait, l’adescamento al click facile, e così le redazioni si dedicano a stampare acriticamente alcune delle cose peggiori che vengono esternate, fornendo così legittimità alle stronzate», ha detto ad un’intervista del Guardian Brooke Binkowski, editor del sito di demistificazioni Snopes. «Non tutte le redazioni sono in questo, ma molte sì.»
Dobbiamo però stare attenti a non respingere qualsiasi cosa con un titolo attraente a livello digitale come clickbait – titoli accattivanti sono una buona cosa, se conducono il lettore ad un giornalismo di qualità, serio e anche non. La mia convinzione è che quanto distingue il buon giornalismo da quello povero è il lavoro: il giornalismo che le persone apprezzano di più è quello per cui si può dire che qualcuno ci ha messo in un sacco di lavoro – dove si può sentire l’impegno che è stato speso a loro favore, i doveri grandi o piccoli, importanti o divertenti. Ed è l’esatto contrario di quello che in inglese viene chiamato “churnalism”, il riciclo infinito di storie di altre persone per i click.
Attualmente il modello di pubblicità digitale non discrimina tra vero o non vero, ma soltanto tra grande o piccolo. Come ha scritto il giornalista politico americano Dave Weigel ha scritto in seguito ad una bufala che divenne un successo della viralità per tutto il viaggio di ritorno nel 2013: «’Troppo bello per essere controllato’ era usato dai direttori di giornali come monito per non saltare sulle stronzate. Ora invece è un modello di business.»
Un’industria delle notizie e dell’editoria che insegua disperatamente il click facile non sembra essere un settore in una posizione di forza e, in effetti, il business della pubblicazione di notizie è in difficoltà. Il passaggio all’editoria digitale ha rappresentato uno sviluppo entusiasmante per il giornalismo – come ho detto nel 2013 presso l’Università di Melbourne alla AN Smith conferenza “The Rise of the Reader“, avendo indotto un «ridisegno fondamentale della relazione di giornalisti con il nostro pubblico, il modo con cui pensiamo i nostri lettori, la nostra percezione del ruolo che abbiamo nella società, il nostro status». Ha significato che abbiamo trovato nuovi modi per ottenere storie – dal nostro pubblico, dai dati, dai social media. E ci ha dato nuovi modi per raccontare storie – con tecnologie interattive e ora con la realtà virtuale. Ci ha dato nuovi modi per distribuire il nostro giornalismo, per trovare nuovi lettori in luoghi sorprendenti; ci ha dato nuovi modi per interagire con il nostro pubblico, aprendoci alla sfida e al dibattito.
Ma mentre le possibilità del giornalismo sono state rafforzate dagli sviluppi digitali degli ultimi anni, il modello di business è in grave pericolo, dato che, nonostante quanti click si ottengano, non saranno mai abbastanza. E se si fanno pagare i lettori per accedere al vostro giornalismo si dispone di una grande sfida per convincere il consumatore digitale a pagare per parte di quelle informazioni che invece è abituato ad ottenere gratuitamente.
Gli editori di giornali di tutto il mondo stanno vedendo profitti ed entrate gocciolare drammaticamente. Se si desidera un’illustrazione cruda delle nuove realtà dei media digitali, occorre considerare i risultati finanziari del primo trimestre annunciate all’inizio del 2016 dal New York Times e Facebook ad una settimana di distanza. Il New York Times ha annunciato che i suoi profitti operativi erano scesi del 13%, a 51.5 milioni di dollari – più in salute rispetto alla maggior parte del resto del settore editoriale, ma un calo notevole. Intanto Facebook rivelava che nello stesso periodo il suo utile netto era triplicato – ad un piuttosto sconcertante 1.51 miliardi di dollari.
Molti giornalisti hanno perso il lavoro negli ultimi dieci anni. Tra il 2001 e il 2010 il numero di giornalisti nel Regno Unito si è ridotto fino a un terzo; tra il 2006 e il 2013 negli USA le redazioni sono diminuite di un ammontare analogo. Soltanto tra il 2012 e il 2014 in Australia c’è stato un taglio del 20% della forza lavoro giornalistico. All’inizio del 2016, presso il Guardian ha annunciato che avrebbe avuto bisogno di rinunciare a 100 posizioni giornalistiche. Nel marzo dello stesso anno, l’Independent ha cessato di esistere come giornale cartaceo. Dal 2005, secondo la ricerca da Press Gazette, il numero di quotidiani locali nel Regno Unito è sceso di 181 – ancora una volta, non a causa di un problema con il giornalismo, ma per problemi di finanziamento.
I giornalisti che perdono il lavoro non rappresentano però semplicemente un problema per i giornalisti: l’impatto è dannoso sull’intera cultura. Come ha avvertito nel 2007 il filosofo tedesco Jürgen Habermas: «Quando in questo settore chiave riorganizzazione e riduzione dei costi compromettono gli abituali standard giornalistici, viene colpito il cuore stesso della sfera pubblica e politica. Perché, senza il flusso di informazioni ottenuto attraverso ricerche approfondite, e senza lo stimolo di argomenti basati su un know-how che non è economico, la comunicazione pubblica perde la propria vitalità discorsiva. I media pubblici potrebbero quindi cessare di resistere alle tendenze populiste, e potrebbero non essere più in grado di svolgere la funzione che dovrebbero avere nel contesto di uno stato democratico di diritto».
Forse allora l’attenzione dell’industria delle notizie ha bisogno di rivolgersi all’innovazione commerciale: come salvare i finanziamenti per il giornalismo, che è quanto è in pericolo. Il giornalismo ha visto innovazioni drammatiche negli ultimi due decenni digitali, ma i modelli di business non ne hanno avute di analoghe. Nelle parole del mio collega Mary Hamilton, direttore esecutivo del Guardian per il pubblico: «Abbiamo trasformato tutto il nostro giornalismo e non abbastanza di nostre imprese.»
•
L’impatto sul giornalismo della crisi nel modello di business è che, nell’inseguire click a basso costo a scapito dell’accuratezza e della veridicità, le organizzazioni delle news minano la ragione per cui esistono: scoprire le cose e dire ai lettori la verità – corrispondere, riferire, denunciare.
Molte redazioni stanno rischiando di perdere ciò che conta di più nel giornalismo: il prezioso, civico, consumare-le-strade, spulciare-gli-archivi, fare-domande-impegnative, insomma tutto il duro lavoro di scoprire cose che qualcuno non vuole che tu sappia. Il giornalismo di interesse pubblico è esigente, serio, e non ce n’è mai stato bisogno come ora. Aiuta a mantenere onesti i potenti; aiuta le persone a dare un senso al mondo e al loro posto in esso. Fatti e informazioni affidabili sono essenziali per il funzionamento della democrazia – e l’era digitale lo ha reso ancora più evidente.
Non dobbiamo però permettere che il caos del presente ci faccia gettare sul passato una luce rosea – come si può vedere dalla recente risoluzione di una tragedia che è diventata uno dei momenti più bui della storia del giornalismo britannico. Alla fine dell’aprile 2016, dopo due lunghi anni di inchiesta, è stato stabilito che le 96 persone morte nel disastro di Hillsborough nel 1989 erano state uccise in modo sommario e non avevano affatto contribuito alla situazione pericolosa creatasi sul campo di calcio. Il verdetto è stato il culmine di un’infaticabile campagna condotta dalle famiglie delle vittime per ben 27 anni. Il cui caso è stato seguito per due decenni con grande sensibilità e cura dei particolari dal giornalista del Guardian David Conn. Il suo giornalismo ha aiutato di scoprire la verità su quanto accaduto a Hillsborough e il successivo insabbiamento da parte della polizia – classico esempio del giornalista che tiene a bada il potente per conto del meno potente.
Per quasi tre decenni le famiglie avevano condotto una campagna contro una menzogna messa in circolazione dal Sun. L’aggressivo e destrorso direttore del tabloid, Kelvin MacKenzie, aveva accusato del disastro i tifosi, suggerendo che avevano forzato l’ingresso nel campo senza biglietto – una denuncia rivelatasi poi falsa. Conformemente alla storia che Horrie e Chippindale ricostruiscono rispetto alle vicende del Sun, MacKenzie ha assolto i suoi giornalisti e ha posto le parole “LA VERITÀ” sulla prima pagina, sostenendo che tifosi del Liverpool erano ubriachi, che hanno borseggiate le vittime, che hanno preso a pugni e calci e hanno urinato sugli agenti di polizia, che hanno gridato che volevano fare sesso con una donna vittima delle violenze e già morta. I tifosi, avrebbe detto un «alto ufficiale di polizia», anno «agito come animali». La storia, come scrivono Chippindale e Horrie, rappresenta quanto è definita in gergo come “classic smear”, una diffamazione ordinaria nella quale cascano tutti, priva di qualsiasi verificabile attribuzione, la quale «fissa in modi precisi la formula di MacKenzie di pubblicizzare a voce piena su tutto il paese un pregiudizio ignorante e cotto a metà».
Rimane difficile imaginare che potesse succedere oggi una Hillsborough: se 96 persone fossero calpestati a morte davanti a 53,000 smartphone, con fotografie e testimonianze oculari tutti postati sui social, ci sarebbe voluto così tanto per far uscire la verità?
•
La verità è una battaglia. E chiede duro lavoro. Ma ne vale la pena di lottare: i tradizionali valori dell’informazione sono importanti e fondamentali, e meritano ogni difesa. La rivoluzione digitale ha fatto sì che i giornalisti – giustamente, a mio avviso – siano più responsabili nei confronti del loro pubblico. E, come gli spettacoli di storia di Hillsborough, i vecchi media erano certamente in grado di perpetrare falsità terribili, che avrebbero richiesto anni per essere svelati. Alcune delle vecchie gerarchie sono state decisamente scalzate, portando ad un dibattito più aperto e una sfida più sostanziale alle vecchie élite i cui interessi spesso hanno dominato i media. Ma questa epoca di informazioni implacabili e immediate – e di verità incerte – può essere schiacciante. Sbandiamo da un oltraggio ad un altro, ma li dimentichiamo tutto molto rapidamente: ogni pomeriggio è il giorno del giudizio.
Allo stesso tempo, il livellamento nel paesaggio delle informazioni ha scatenato nuove ondate di razzismo e sessismo e nuovi modi per umiliare e molestare, suggerendo un mondo nel quale prevarranno gli argomenti più forti e più crudi. Si tratta di un ambiente già mostratosi particolarmente ostile alle donne e alle persone di colore, rivelando che le disuguaglianze del mondo fisico sono riprodotte con sin troppa facilità negli spazi online. Anche testate di livello non ne sono immuni, ed è per questo che una delle mie prime iniziative come redattore capo del Guardian è stato quello di lanciare il progetto il Web che vogliamo, al fine di combattere una cultura generale di abuso online e chiedere come noi, in qualità di istituzione, possiamo essere in grado di favorire una migliore e più civile conversazione sul web.
Ad ogni modo, la sfida per il giornalismo oggi non è semplicemente l’innovazione tecnologica o la creazione di nuovi modelli di business: è soprattutto quella di stabilire quale ruolo le organizzazioni giornalistiche possono ancora giocare in un discorso pubblico che è diventato incredibilmente frammentato e radicalmente destabilizzato. Gli incredibili sviluppi politici dello scorso anno – tra cui il voto per la Brexit e quello per Donald Trump – non sono semplicemente i sottoprodotti di un populismo risorgente o la rivolta di coloro che lasciati indietro dal capitalismo globale.
Come l’accademico Zeynep Tufekci ha sostenuto in un saggio di inizio 2016, l’ascesa di Trump «è in realtà un sintomo della crescente debolezza dei mass media, soprattutto nel controllare i limiti di quanto è accettabile dire». (Un esempio simile potrebbe essere quello della campagna Brexit.) «Per decenni, i giornalisti che lavoravano presso le principali industrie dei media hanno agito come portieri che forniscono il giudizio su quali idee possano essere pubblicamente discusse, e su quanto è stato considerato troppo radicale», ha scritto Tufekci. L’indebolimento di questi vecchi portieri è tanto positivo quanto negativo, ci sono opportunità e non ci sono pericoli.
Anche gli esempi del passato ci fanno comprendere che i vecchi portieri erano capaci di nuocere gravemente, ed erano spesso arroganti nel rifiutarsi di dare spazio ad argomenti ritenuti estranei ai consensi politici mainstream. Ma senza un qualche consenso, è difficile per qualsiasi verità di affermarsi. Il declino dei vecchi portieri ha donato a Trump la possibilità di dare spazio ad argomenti ritenuti tabù in passato, come il costo del regime free-trade che favorisce le corporazioni invece dei lavoratori, una questione che l’élite americana e maggior parte dei media aveva rigettato da tempo – oltre a, più ovviamente, permettere alle sue bugie oltraggiose di prosperare.
Quando lo stato d’animo prevalente è anti-élite e anti-autorità, la fiducia nelle grandi istituzioni, media compresi, comincia a sgretolarsi.
Credo che per una cultura giornalistica forte valga la pena lottare. Quindi è un modello di business che serve e che premia le organizzazioni dei media capaci di mettere la ricerca della verità al centro di tutto – capace di costruire un pubblico informato e attivo, capace di esaminare con attenzione i potenti, e non di imbonire una banda di reazionari disinformati capace soltanto di attaccare i deboli. I tradizionali valori dell’informazione devono essere abbracciati e celebrati: relazionare su fatti e verificarli, raccogliere le dichiarazioni di testimoni oculari, fare ogni volta un serio tentativo di scoprire cosa sia realmente accaduto.
Abbiamo il privilegio di vivere in un’epoca in cui per farlo possiamo utilizzare molte nuove tecnologie – e l’aiuto del nostro pubblico. Dobbiamo però anche affrontare le questioni alla base della cultura digitale, e renderci conto che il passaggio dalla stampa ai media digitali non ha mai riguardato soltanto la tecnologia. Dobbiamo anche affrontare le nuove dinamiche di potere che tali cambiamenti hanno creato. Tecnologia e mezzi di comunicazione non esistono in isolamento – aiutano la forma sociale, così come questa li modella a loro volta. Ciò significa impegnarsi con attori sociali, cittadini, alla pari. Si tratta di fare le pulci al potere, lottando per uno spazio pubblico, assumendosi la responsabilità per creare quel tipo di mondo nel quale davvero vogliamo vivere.
•
Pubblicato come: Katharine Viner, “How technology disrupted the truth”, «The Guardian» 18.06.2016.
Traduzione: Claudio Comandini.