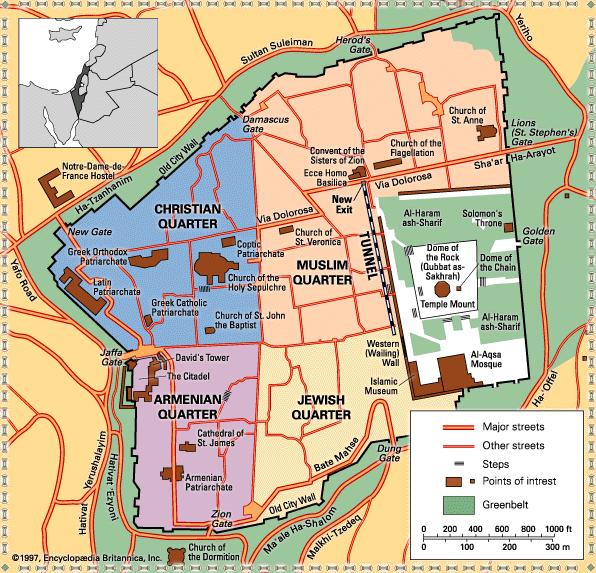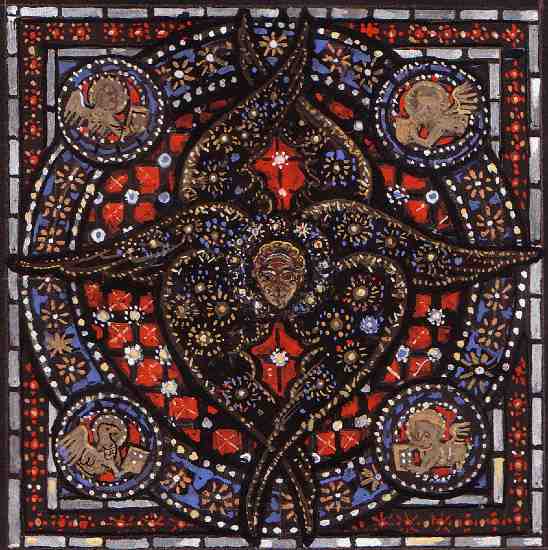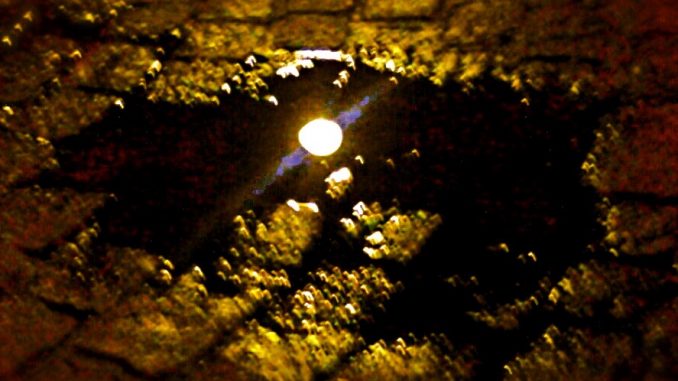
Cultura, comunicazione e sagre dell’inutile. Segre: eredità non riscosse. Dubois: la letteratura e le sue legittimazioni. Schücking: gruppi letterari e concorrenza commerciale. La scrittura, il digitale e Cicerone. Cordelli: il parlamento della palude. Cortellessa: la terra della prosa. Tribalismo e anomia. Dibattito: Policastro, Longo, Sortino, Calcaterra, Gallerani, Voce, Mancuso, Mascheroni, Raimo, Beretta, Pedullà, Di Consoli, Di Paolo, Minardi, Silvestri, Berardinelli. Breve storia dell’arte di raccontare storie: dal romanzo borghese di Hegel agli scrittori inutili di Cavazzoni. Note sul narrativismo e sui sofware di scrittura. Dubini: il ripensamento dell’economia del libro. Ferroni: scritture a perdere. Eccessi, evaporazioni, successi, bestiari. Oscillazioni del narrare. Responsabilità per la parola e cura del mondo.
1. L’origine della palude
L’eredità di culture secolari sembra ridursi a strumento di consolazione di minoranze di melanconici, si impone una culturetta inconsistente di frasi fatte, mezze polemiche e rivendicazioni idiote: manca un’entità collettiva capace di traghettare la cultura umanistica dentro la multimedialità, nessuno sembra in grado di cavalcare l’innovazione per trasformarla in un veicolo di cultura rinnovata. Queste osservazioni di Cesare Segre, che concludevano la monumentale Storia della letteratura italiana diretta da Enrico Malato (uscita nel 2000 per Salerno, cinque anni dopo diffusa in edicola per il Sole 24ore – quindi potenzialmente a disposizione di tutti…), indicano esigenze e difficoltà ancora attuali. Quale pantano costringe a restare incapaci di prendere posizione e trovare direzioni?
Fin dove la comunicazione mediatica e la «scuola dello scorrevole nulla» (Giulio Ferroni, Scritture a perdere, 2010) hanno inghiottito anche le forme della cosiddetta cultura? Sembra impossibile formulare contenuti nelle sagre dell’inutile: trasmissioni televisive con un tasso più o meno letterario, megafestival librari e premi super-istituzionali dedicati questo, quello e quell’altro, bestseller blasonati di cui tutti sanno la trama senza averli nemmeno maneggiati. Il giornalismo disprezza apertamente stile, ricerca e rigore, imponendo aberrazioni autoreferenziali che però ormai sono inutili anche a vendere giornali. Lo spazio infinito di Internet, nonostante la ricchezza di soluzioni, è spesso ostaggio desideri e limiti di un intrattenimento di massa propriamente pornografico. Il gusto medio si adagia sull’acclamazione del mediocre, sostenuto da media, politici, popolo, sviluppo produttivo.
Se la produzione letteraria sembra ormai inadeguata a rappresentare la realtà e gli scrittori possono figurare come stucchevoli perdigiorno, la sociologia della letteratura permette di comprendere che quanto definiamo “cultura” non è un fenomeno neutro e sempre uguale a se stesso, ma un processo di interazione con altri elementi che concorrono a definirne senso e funzioni. Per Jacques Dubois (La letteratura come istituzione, 1978) esistono aspetti di carattere collettivo e «istituzionali» che permettono definizione e legittimazione nelle opere letterarie; lo schema di base contrappone «scuole» in avvicendamento reciproco, anche laddove l’emergere di un autore, com’è riscontrabile per Baudelaire o Céline, possa seguire processi più complessi di quelli definiti da rigide appartenenze.
Le modalità di svolgimento descritte da Dubois contribuiscono a relativizzare l’esistenza di uno «spirito dell’epoca» nel quale si manifesterebbe un’«assoluta libertà dell’arte», e Levin Schücking (Sociologia del gusto letterario, 1961) evidenzia che il cosiddetto gusto è imposto da gruppi la cui concorrenza è analoga a quella commerciale, costringendo le persone a non avere più gusti personali; l’irruzione di nuovi soggetti può rompere gli schemi preesistenti e costringere a messe in discussione complessive, ma è sempre richiesta l’assunzione di ruoli che permettano il determinarsi di una nuova situazione.
Le novità non mancano, ma è difficile decodificarle. La crisi d’utenza coinvolge giornali e televisione, più che i libri, mentre la rete è sempre più frequentata e, tra una videata e l’altra, sono guardati, letti e scaricati anche testi di ogni tipo. Il digitale sta inoltre ridefinendo il modo di fare e diffondere libri, e il giornalista americano David Streitfield, esperto di letteratura e tecnologia, segnala il continuo incremento delle forme d’integrazione tra formati cartacei e immateriali e tra editori e comunicatori; inoltre, si può essere autori apprezzati anche sulle piattaforme digitali, dove peraltro è possibile anche usufruire di royalty maggiori. Tuttavia, se sono disponibili libri antichi e fuori catalogo, articoli scientifici e nuove proposte, non può essere sottovalutato che spesso si abusa di tutto il progresso del mondo per sfogarsi nei modi più banali, favorendo ampia diffusione di roba grossolana che, oltre ad essere facilmente “vendibile”, è in grado di provocare complicità degne dei compagni di merende di paccianiana memoria.
Ricorda Cicerone nelle Tuscolanae Disputationes (I, 3-6, 45 a.C) che «chi usa in modo distorto il proprio tempo libero e le lettere» permette ad altri di sentirsi autorizzati a «scrivere con la stessa sciatteria»: nell’era delle comunicazioni di massa, le parole dell’esigente oratore romano pesano ancora di più che se scritte su pietra, facendo comprendere che il diffuso costume di giocare al ribasso degrada il gusto, marginalizza le eccellenze, inibisce l’intelligenza. Il disprezzo per la letteratura non è una novità e nel passato ha accompagnato anche correnti culturali a loro tempo necessarie laddove l’urgenza era ritrovare maggiore coesione verso le concrete condizioni del vivere: oggi però gli aspetti anticulturali e normalizzatori dei luoghi comuni basati su un vitalistico spregio del sapere sono sin troppo evidenti e dannosi.
Una polemica scaturita da un articolo di Franco Cordelli, scrittore e critico teatrale, pubblicato su la Lettura #131 del 25 maggio 2014 ha richiamato, pur senza particolari approfondimenti, alcune di tali questioni. «La letteratura italiana degli ultimi vent’anni (a cominciare dal declino della critica, impoverita ancor più di romanzo e poesia) non è che una palude, in cui il bello e il brutto sono detti e sostenuti secondo un percorso prestabilito: pubblicazione (ma pubblicano tutti), recensione, premio. Non c’è altro. Oppure c’è, a guardare bene, meno distrattamente, il riconoscimento di una tribù: un’adesione prodiga di stilemi iperbolici. Sì, la faccenda è uguale per tutti, o quasi tutti; la plausibilità del valore è minima o nulla; la palude nasconde gruppi che non si riconoscono come tali, che neppure sanno di esserlo, e in cui ognuno per conto proprio persegue lo stesso fine – vale a dire (prima ancora del successo) la sopravvivenza editoriale».
Su tali assunti è quindi elaborato, in base ad una propria «percezione», un Parlamento della Palude che, senza voler fare valutazioni di merito, suddivide settanta autori in sei gruppi. In base ad una propria capacità di strutturare i dati a disposizione è formulata una vera e propria istituzione: metafora funzionale ad evidenziare la qualità della «porzione più visibile» del mondo letterario. Sono già nomi utili per orientarsi nella produzione contemporanea; alcuni hanno ricevuto particolare ricorrenza nella polemica scaturita dalla provocazione di Cordelli, e sarà quindi possibile accennare anche a quanto scrivono: il che, nel parlare di letteratura, non è affatto scontato.
A sinistra troviamo i Novisti (Pecoraro, Siti, Belpoliti, Pincio, Falco, Mazzoni, Cortellessa, Giglioli, Pugno, Vasta, Pedullà jr, Lagioia, Parrella): «Un che di simile a una casta di incerta memoria politica, erede di una tradizione di stile e rigore e i cui esponenti, per quanto sempre in prima linea, faticano a ritrovare l’antico vigore». Esternamente a questi, i Dissidenti (Fofi, Severini, Cavazzoni, Colasanti, Pusterla, Ferracuti, Giacopini, Raimo): «Sparuta e ideologicamente incoerente raccolta di nomi di irriducibili guardiani dell’hic et nunc». A destra, i Conservatori (La Capria, Berardinelli, Rasy, Cavalli, Ficara, La Porta, Onofri, Febbraro, Murgia, Marchesini): «Quanti mostrano un’orgogliosa indifferenza per il tempo che passa e sono spesso riconosciuti in quanto sempre reattivi a ciò che viene di sinistra presunto». All’estrema destra, Vitalisti (Moresco, Benedetti, Scarpa, Nove, Scurati, Genna, Di Consoli): «Di matrice dannunziano-pasoliniana, si caratterizza per un’aggressività verbale e una vistosa muscolarità». Al centro, come pertiene all’ago della bilancia, i Moderati (Montefoschi, Serra, Affinati, Doninelli, Magrelli, Manica, Veronesi, Trevi, Balestra, Piperno, Bajani, Giordano, Di Paolo): «Una forza ad alta vocazione istituzionale pronta ad assumere sulle proprie spalle il ruolo che la società culturale gli riconosce». Marginalmente, il Gruppo Misto (Lolini, Permunian, Di Mauro, Albinati, Di Stefano, Raffaeli, Trevisan, Galaverni, Gallerano, Torino, Caterini): «Composto da minoranze, transfughi e orfani». A parte, i Senatori a vita (I vari Guglielmi, Celati, Magris, Vassalli, Ferroni) «Assisi nel distacco della loro indiscussa celebrità, guardano con relativa attenzione a quanto gli accade intorno.»
La prima ad intervenire nella disputa è stata Gilda Policastro, riconoscendo come la situazione editoriale sia definitivamente compromessa dalle esigenze di mercato, che coinvolgono addirittura le singole uscite impedendo ogni visione d’insieme. In questo quadro, già delineato da André Schriffrin (Editoria senza editori, 1999), l’elaborazione di stili e concetti complessi si contamina con la decadenza linguistica, e per bene che vada gli scrittori devono sopportare le pretese di editor «pischelli» estranei a preoccupazioni di tipo linguistico. La contestazione verso Cordelli è netta e coinvolge validità dei gruppi e criteri di designazione: alle dense difficoltà di Giorgio Falco (castigato dal critico, che probabilmente lo considerato Novista per incomprensibilità) viene contrapposta la insipida semplicità di Andrea Bajani (Moderato – per la Policastro a causa delle sue deboli forze).
Invece, Giorgio Ficara (Conservatore, ma per rapporti di semplice buon vicinato) è attaccato dalla Policastro perché Cordelli non ne aveva parlato male considerando Riviera (2010) un romanzo di viaggio piuttosto innovativo, che ora però diventa qualcosa di cui è meglio tacere. Le maggiori bastonate le riceve Antonio Scurati (Vitalista «chissà perché») la cui lingua desueta e improbabile è incapace di rappresentare il mondo e inciampa su se stessa in ripetizioni un po’ rimbambite («indubbiamente indubbia bellezza»). Incapace di approdare a quel conflitto culturale depurato dagli asti personali la cui necessità è sostenuta dalla stessa Policastro in Polemiche letterarie (2012), l’articolo, oltre che alle attenzioni degli editor, sfugge anche alla propria stessa sapienza, e pur offrendo spunti risulta così involuto da farsi il verso da solo.
L’appassionata difesa sembra in realtà confermare una delle principali accuse: ad alcuni autori non interessa scrivere, ma, con le parole di Cordelli, «mettersi in posa», rendendosi responsabili di una letteratura di «pura farneticazione». Lo provano sintagmi che «non vogliono dire niente» tipo: «sagome sudate» (La gemella H, 2014), «aria accucciata», «energia di una moneta» (L’ubicazione del bene, 2009): ad esserne autore è Giorgio Falco, aderente ad una «circoscrizione che per comodità diremo d’”avanguardia”», nel quale sta in compagnia del critico Giorgio Vasta, che lo elogia con questi termini: «il bisogno di ricomporre per via letteraria una genesi del contemporaneo, vale a dire quella cosa che chiamiamo presente […], il desiderio di rendere conto nella lingua di ogni microfenomeno umanamente percepibile». Cordelli nota ironicamente che da sempre la lingua accoglie tali tensioni, e che «contemporaneo» e «presente» sono la medesima identica cosa: ma quando la sua indignazione tocca l’apice quanto arriva a quella che Vasta chiama «la messa in torsione dell’etica, il suo sfiguramento».
Dopo i rilievi nei confronti di monete energetiche ed etiche sfigurate, arriva quindi la rivelazione: l’«esaltazione» di cui in certi ambienti sarebbero oggetto autori non particolarmente meritevoli dipende da questioni di mera appartenenza «tribale», di cui porta ampia traccia la «ricca quanto tendenziosa antologia di Andrea Cortellessa La terra della prosa, dedicata agli scrittori che hanno esordito dopo il 1999». Laddove sappiamo, e non per diceria, che il “riconoscimento” non deriva da un’astratta e generica “bravura” ma da una serie di istanze di legittimazione, la rivelazione risulta in definitiva piuttosto scontata e neanche troppo scandalosa.
Il recente libro di Cortellessa è recensito da Francesco Longo che lo definisce come una sorta di contro-antologia di un’assenza: considerata la storica «inabilità al romanzo» della letteratura italiana, nonché il modificarsi delle stesse forme narrative, il testo assume come criterio elettivo proprio quello di «non scrivere romanzi», di cui anzi viene lamentata la diffusa omogeneità, dettata delle esigenze di facile commercializzazione imposte dall’industria culturale. Ispirato testualmente né a criteri di bellezza, contenuti o stile, ma di «qualità letteraria», il lavoro di Cortellessa si concentra soprattutto su libri inclassificabili e su autori dotati di background poetico e con alle spalle la realizzazione di reportage narrativi, nei quali siano riscontrabili influenze di autori quali Manganelli o Landolfi, eco leopardiane o beckettiane, con il particolare pregio di presentarsi in «opposizione» a qualcosa.
I temi prediligono le localizzazione: svincoli, rotonde, alberi rinsecchiti, confini, periferie, estraneità, non-luoghi. Gli argomenti riguardano lo sconforto (Falco: «il male oscuro dell’hinterland del benessere»; Rastello: «corpi nudi, scossi da un moto d’angoscia, come di partorienti fecondate da un mostro») e il disagio (Vasta: «Voglio ancora carotare nonostante il malessere, anzi tramite il malessere»; Arminio: «Scrivo perché devo morire»). A detta di Longo, la “qualità” di riferimento sembra dipendere troppo da elementi extraletterari, dimostrandosi incapace di scommettere sulle abilità allegoriche del romanzo e in definitiva sulla stessa letteratura.
In un’intervista Andrea Cortellessa (collocato tra gli incerti e affaticati Novissimi) difende il proprio lavoro critico: le appartenenze si basano anche su comuni visioni, e «parlare dei metodi di selezione renderebbe meno ovvia la pubblicazione di interventi come quello di Cordelli, che si basano su impressioni soggettive. Quella della palude è un’immagine mal scelta. Per definizione, è impossibile cartografare una palude. Si tratta di un ossimoro. Se Cordelli ha potuto fare una mappa, è proprio perché questa palude a cui fa riferimento non esiste, anche se gli elementi di oscurità non mancano.»
Quindi, il compito critico al quale non ci si è ancora dedicati è quello di rischiarare le oscurità della letteratura italiana contemporanea, che guarda caso rimandano ad acque torbide: adempierlo potrebbe forse far saltare tanto la mappa quanto il territorio, portando a scoprire un altro mondo, nel quale la narrazione è compresa in un ecosistema più ampio. Intanto, la terra della prosa a cui approda Cortellessa comprende gli autori: Pincio, Nori, Cornia, Pascale, Permunian, Lagioia, Raimo, Pica, Ciamarra, Pugno, Arminio, Magrelli, Morelli, Trevi, Bàino, Falco, Samonà, Baroncelli, Vorpsi, Ricci, Rastello, Saviano, Jones, Bajani, Pecoraro, Vasta, Bortolotti, Pedullà, Policastro, Orecchio, Carbé.
«Il bitume in cui viviamo è reale, infesta la letteratura italiana e due sono le posizioni»: l’isolamento, per cui si impongono erudite classificazioni, quali quello di André Gide (Le Paludi, 1895 – tradotto proprio da Cordelli) e l’assimilazione, che porta a regredire a forme primitive, come sperimentato da Cormac McCarthy (La strada, 2007). In tali termini, Paolo Sortino apprezza il valore allegorico della palude e, volendo sorprendere, rivela che gli scrittori, pur se apparentemente fanno letteratura, appartengono al campo della biologia: infatti, sono studiati proprio «per carpire il segreto della sopravvivenza e l’origine di tutti gli esseri viventi. Il letterato ha un romanzo da scrivere ma non lo porterà mai a termine perché non vuole davvero comprendere la vita che pullula sul fondo del bitume.»
Il corpo a corpo di un autore è quindi con la lingua: «la vera melma è la lingua italiana, scivolosa e splendente di colori cangianti come una bestia coperta di squame.» Non è certo una novità, anche se in questo modo era stato detto soltanto nei fumetti: del resto, sono stati definitivamente erosi i confini tra letteratura disegnata (definita tecnicamente come paraletteratura, sempre più lontana nelle sue realizzazioni da rappresentazioni conformiste) e quella di sole parole (nella quale spesso è compresa anche la letteratura di massa che in teoria dovrebbe esserne esclusa). Fa riflettere sulle condizioni della letteratura che in Italia, dopo stagioni entusiasmanti, una grigia e decomposta produzione fumettistica tende ad assimilarsi ad una compiaciuta letteratura d’accatto, in una zona grigiastra della quale il campione sembra essere Tito Faraci: mancano anche le condizioni per permettere vette simili a quelle dell’inglese Alan Moore, autore già nei primi anni ottanta delle dense e intricate storie di Swamp Thing – la cosa della palude, toccante proprio dove si incontra con un parlamento di alberi al quale le piccole miserie umane non possono insegnare assolutamente nulla.
Contesta la metafora parlamentare cordelliana Domenico Calcaterra: preferibile un «canovaccio descrittivo riferito al tempo che fa, alle diverse latitudini intellettuali». Quindi, riposiziona le varie caselle basandosi su criteri meteorologici, mantenendo incertezze sulla locazione di Cordelli, a suo agio «nell’arido come nel frigido», in quanto parla soltanto del «deserto della sua desolazione». Insomma, la convulsa aggettivazione delle previsioni del tempo può adattarsi alle linee di tendenza della letteratura odierna ed è capace di descrivere le opere di qualità da questa offerta: come unica garanzia, è chiesto di passare dalla «percezione» al «senso comune». Le argomentazioni di Cordelli sarebbero potute essere più consistenti, ma quelle di Calcaterra sono piuttosto sciatte: infatti, se la percezione è già una forma di strutturazione, una letteratura costretta a correre dietro al senso comune ne espone sin troppo i parametri alle intemperie.
Molti degli attacchi trascurano che la tassonomia proposta da Cordelli cerca una descrizione utile a comprendere il senso della letteratura odierna e tratta di una «necessità intrinseca in quanto è reputato culturalmente significativo»; estranea ad una ripartizione in «buoni e cattivi», intenzionalmente teneva fuori tanto gli scrittori già acquisiti a riconosciuta eccellenza, quanto la maggior parte dei poeti che, per problemi loro, da tempo hanno «rinunciato a dire qualcosa in più, rispetto ai propri versi». L’aspetto realmente stagnante e davvero inquietante di quanto emerge dalla Palude è che proprio il «culturalmente significativo» tende ad autorappresentarsi come raggrumato in un ambiente melmoso e puzzolente.
Il tribalismo contemporaneo era stato elogiato in ambito postmoderno dal sociologo Michael Maffesoli, ma la nozione sembrerebbe ormai piuttosto esaurita: quel che resta della società ormai si compone non tanto di «appartenenze sovraindividuali», quanto di bozzoli, nel quale a polverizzarsi è lo stesso individuo. In tale atomizzazione, anche i gruppi di cui la letteratura e l’arte si compongono sono vessati da una corruzione endemica dove il merito non ha posto, venendo così a costituirsi in cosche verticiste niente affatto meritocratiche, oppure in gruppi di auto-aiuto del tutto alieni a questioni di poetica e stile, dei quali si è parte per mera casualità o per semplice opportunità: insomma, per sostegno e protezione, nel migliore di casi amicizia e birra, prescindendo del tutto da questioni di carattere letterario e stilistico.
Esempio emblematico di queste contorsioni è che Cordelli tra i Novisti ci piazzi Walter Siti, che con Resistere non serve a niente (2013) offre l’esempio programmatico di una letteratura di destra che però piace ai cultori del “nuovo” a loro agio a sinistra: siamo però sicuri che la semplice reattività del resistere sia qualcosa che sappia guardare davvero avanti, così come la classica definizione di sinistra dovrebbe richiedere? E non è ormai storicizzato che la destra abbia sfacciatamente incensato il nuovo che avanza?
La collocazione di un autore in un gruppo o in un altro appare del tutto estrinseca, eppure l’operazione di riconoscerlo non è affatto umorale, e ne difende l’eticità Stefano Gallerani (Gruppo Misto). Il Parlamento della Palude corrisponde ad una metafora strumentale, valida per quanto riesce a dire, i suoi principi sono esplicitamente di tipo sintomatico: se gli è stato attribuito «carattere inclusivo ovvero esclusivo, quasi si trattasse di un canone», questo era proprio quanto dichiaratamente escluso. Pertanto, l’intera polemica è basata su un equivoco, lamenti e attacchi sono gratuiti: chiunque, invece di accanirsi, poteva proporre criteri e questioni diverse. I rilievi sulla scrittura di Falco e Vasta sono pertinenti, dato che da sempre la critica deve «cogliere i passi cruciali di un testo, quei brani che trascendono il testo stesso o ne rappresentano un concentrato». L’ancoraggio alla realtà è dimostrato dalla capacità di leggere un arco d’autori che coprono un quarantennio; stupore, spaesamento e irritazione sono legittimi dove esistono troppi luoghi comuni da smuovere.
2. Immersi nella palude
Alcuni dei luoghi comuni che ingombrano il dibattito rappresentano il dazio da corrispondere alle tradizionali appartenenze politiche e ideologiche che, seppur in modo approssimativo o confusionario, a qualcuno sono ancora richieste dalle testate di riferimento o da altre circostanze, dimostrando una volta in più come sia necessario ripensare i rapporti tra sapere e potere in modi che garantiscano alla cultura la possibilità d’essere politica senza dover subire condizionamenti o persecuzioni da amministratori o presunti tali. A sinistra, Lello Voce lamenta la monotonia delle continue apocalissi letterarie proclamate da chi si compiace a pronunciare profezie di «pochi passaggi, rapsodici e spesso oscuri»; tuttavia, dimostra a sua volta superficialità d’analisi, lasciandosi inghiottire dallo stesso nulla denunciato.
A destra, Maria Rosa Mancuso nomina autori non compresi in nessuno dei due schieramenti: Ottavio Cappellani, Rosa Matteucci, Marco Missiroli e Andrea Tarabbia, elogiati perché, come fossero tazze di tè, «hanno allietato i nostri pomeriggi». Luigi Mascheroni, perplesso tanto dei criteri proposti quanto del dibattito scaturito, individua altri nomi e ridisegna la mappa personalizzandone la toponomastica, ponendosi in competizione con Cordelli pur dimostrando di non averne né il brio né il gusto. Il riordino degli scaffali porta dal rovente clima critica letteraria ad uno più da centro commerciale. Impedibili: Falco, Vasta, Savic, Aldo Giovanni Giacomo, Wu Ming, Moccia, Troisi, Villaggio. Il Secondo Mestiere: Gramellini, De Cataldo, Gruber, Franceschini, Floris, Sangiorgi, Guccini, De Carlo. Provinciali: Biondolillo, Culicchia, Malvadi, Camilleri, Vitali, Lilin, Agnello Hornby, Nesi, Cracco, Repetti. Milfissime: Lucarelli, Baresani, Policastro, Morvillo, Cao, Santacroce, Panarello, Parodi, D’Amico, Raimo, Busi. Inutili: De Luca, Mazzucco, Carofiglio, Angela, Cordelli, Veltroni, Ovadia, Severgnini, Scalfari, Aspesi. Demodè: Arbasino, Citati, Faletti, Pacifico, Mauresing, Bignardi, Rohwacher, Cordero, Pennacchi, Eco, Saviano. Innocui: D’Avenia, Volo, Baricco, Mazzantini, Corona, D’Orrico, Fo, Piccolo.
Rimescolare le acque sarebbe necessario per fare gli interessi della letteratura, ma una polemica a circuito chiuso basata su banali idiosincrasie è del tutto inutile: per Christian Raimo il contraddittorio emerso non è né chiaro né esplicativo e non coinvolge scrittura o libri, nessuna questione autenticamente letteraria, ma evidenzia proprio il gioco dello schierarsi, apparentemente quasi tutto interno alla pagina culturale del Corriere. Se con i loro meriti, i romanzi di Falco possono soffrire di densità eccessiva e la critica di Vasta può essere iperbolica e opaca, stroncarli non risolve il discorso sull’avanguardia, compreso in un’arbitraria tassonomia che coinvolge cordate, tribù e circoscrizioni, spesso costrette ad autodifendersi loro malgrado.
Per Raimo (da Cordelli collocato tra i Dissidenti e presente anche nell’antologia di Cortellessa) occorre recuperare il lavoro di mediazione oggi carente e un tempo svolto dall’università, discutendo, con la dovuta ferocia, del merito dei testi e non della lanugine dell’ombelico. Difficile negare che sia ormai indispensabile assumere un serio lavoro di studio al di fuori delle istituzioni di rappresentanza, destituendo definitivamente tutti coloro che credono di divulgare banalizzando, ma va anche compreso che i confronti necessari ad uno scrittore si collocano su campi più significativi di quelli dettati da circostanze e appartenenze più o meno obbligate o presunte.
Consapevole che la critica non è una materia fatta di rigidità cadaveriche, Alessandro Beretta apprezza la scrittura di Falco e Vasta e, con tutte le sue parzialità, le ricognizioni di Cortellessa, ed è anche pronto a riconosce la dignità del «racconto da camera della letteratura» di Cordelli, decisamente più dignitoso di molte ingiustificate reazioni di stizza. Infatti, una proposta non ha valore di legge, un’istantanea può cambiare nel tempo e anzi permette di giocare con l’immaginario delle poetiche, e anzi favorisce di porsi domandi tipo dove sedere, oppure perché lì c’è quel tale, o anche quando ci saranno le prossime elezioni. Servirebbe inoltre una camera anche per editori, agenti, editor, un planetario per i poeti, nonché una bella sauna per gli esordienti. Purtroppo, costruire in una palude non è facile, bonificare costa, e certi consigli non servono nemmeno per mettere ordine tra i libri: tuttavia, è avvertita l’esigenza di una critica che non sia puro marketing oppure semplice azione di diversivo.
Gabriele Pedullà raccoglie tale esigenza e riconosce che un ordine sussiste dove viene assunta la responsabilità di scegliere quanto sia rappresentativo della letteratura italiana contemporanea, ma le metafore di «mappatura» e «palude», che riconducono all’instabilità di confini e a alla sgradevolezza, necessitano di un approfondimento. Destituendo la validità dei riferimenti geografici (Cortellessa) e biologici (Sortino), ne è individuato uno propriamente politico: Palude infatti rievoca il nome dei quattrocento parlamentari della Convenzione nazionale che durante la rivoluzione francese non erano schierati né a sinistra con la Montagna, né a destra con i Girondini, gregari sempre pronti a riposizionarsi appoggiando prima il Terrore e poi il Termidoro. Palude è quindi il nome che merita l’Italia emersa nel tramonto degli ideali degli anni settanta: se negli anni ottanta Cordelli accusava d’essere complici di un grande Termidoro letterario i propri coetanei (De Carlo, Del Giudice, Rasy, Tabucchi), oggi disprezza la “condizione liquida” dove si sopravvive cercando di spuntare improbabili carriere.
Pedullà (considerato Novista da Cordelli e antologizzato da Cortellessa) lucidamente individua un problema delle odierne legittimazioni della letteratura: dove tutto va bene, nulla ha più valore. La formula, che riecheggia le icastiche osservazioni di Schopenhauer (Sul mestiere di scrittore e sullo stile, 1851), oggi è radicalizzata laddove al posto di gruppi in competizione si è stabilita una «federazione di comunità» incerta e approssimativa, dove nessuno è in grado di sostenere posizioni che permettano conflitto e ognuno è pronto a negoziare con blandi ed effimeri riconoscimenti, al massimo litigando per risentimenti personali. Tale situazione emargina chi non è abbastanza conformista e vale davvero qualcosa, perpetrando silenziosamente l’omicidio della letteratura; sarebbe invece necessario che i letterati siano in grado di dividersi su grandi opzioni stilistiche e politiche. La classificazione proposta da Cordelli vorrebbe proprio costringere gli interessati a prendere posizione e a pronunciarsi: tuttavia, il suo principale risultato è l’aver provocato la compattezza del fronte dei «giovani rampanti» contro il «vecchio sessantottino» – probabilmente ancora ignari di condividere una stessa matrice “comunicativa”.
Andrea Di Consoli segnala che una cesura di posizioni è effettuata laddove le generiche macro-categorie di Cordelli segnano il suo divorzio dalla letteratura e critica novista, a cui aderì con autofiction in anticipo quali Il poeta postumo (1978). Il suo rifiuto della conciliazione offerta nella «meccanica armonia» del romanzo ordinario trovava sponda in autori quali Carlo Levi, Ennio Flaiano, Oreste del Buono: una sintesi tra «sguardo freddo e lirismo» che tentava di risolvere il conflitto, spesso puramente retorico, tra avanguardia e tradizione. Critico attento di tutte le avanguardie possibili del teatro italiano, Cordelli anche nella letteratura segue un’oscillazione spiazzante, consapevole di quanto possano essere dannosi il sentimento di superiorità di chi pensa d’essere depositario di una cabala stilistica spesso limitata a banale esibizionismo lessicale; il ragionamento fa capire che Cortellessa, già definito come malato di nevrosi settaristica, potrebbe essere anche affetto da «odio programmatico per la realtà».
Di Consoli (non incluso nell’antologia di Cortellessa e considerato Vitalista da Cordelli – ma si sente un po’ Conservatore e un po’ Dissidente) ridicolizza le teorie letterarie avanguardiste, che dai tempi del Gruppo 63 producono risultati irrisori, e afferma che una critica autentica deve saper fare storia e ritrovare criteri diversi dall’egemonia schiacciata sul presente, in definitiva limitati al culto del successo e delle sue ombre. Discutere nel merito di un’idea, senza dare per scontato che l’applauso sia dovuto.
Di quale applauso possiamo parlare però, laddove regna perlopiù frustrazione? Paolo Di Paolo (Moderato, ma non complimentoso) denuncia che le critiche a Cordelli non riguardano questioni di metodo e stile, ma tentano esclusivamente di fare gli interessi propri e quegli degli amici carissimi. Il problema effettivo è nei cambiamenti strutturali comportati dalla diffusione delle nuove tecnologie, che hanno introdotto nel contesto letterario molto di più di un nuovo soggetto, con effetti non del tutto ancora compresi. Il mercato librario è in contrazione, su Internet la piattaforma di self-publishing ilmiolibro.it registra oltre ventimila presenze: troppe, suggerendo che la macro-categoria sia proprio quella dei frustrati. Tutti sono «poco percepiti», lo stesso Cortellessa sembra influente ma non vanta collaborazioni realmente importanti, e la tribù serve proprio a risolvere il deficit di visibilità, a recensirsi a vicenda in modi che ostentano soltanto la diffusa impotenza: «Un autore pubblicato su ilmiolibro.it sponsorizza un suo compagno di strada pubblicato su ilmiolibro.it, Cortellessa mette nell’antologia i suoi amici, quell’altro posta la recensione appena pubblicata allo straordinario esordio del suo ex compagno di scuola.»
In questi piccoli, patetici condomini risulta impossibile trovare una corrente, una scena: Cordelli, «crudelmente curioso come pochi altri» ha il merito di leggere il più possibile, di ricavare una mappa; gli altri, che non leggono, e spesso involuti anche nello scrivere, «hanno già deciso da sempre chi è bravo e chi no, e fanno tanta, tanta tenerezza». Di Paolo approfondisce l’aspetto editoriale della questione: il lavoro letterario è travolto dal caos e dall’indifferenza, si è esposti a cambiamenti che non garantiscono nulla, né lettori, né compensi e tantomeno contratti; i lettori forti sono lo stesso numero degli anni sessanta, ma il mondo delle lettere ha mollato gli ormeggi, bada ad una sopravvivenza tanto patinata quanto indecorosa, la logica commerciale della competizione letteraria diventa spietata ed esclusiva. Dal momento che un romanzo non ha affatto una ragione d’essere scontata, bisognerebbe smetterla di accusare i lettori e di fare gli schizzinosi nei confronti delle loro esigenze: puntare quindi tanto su contenuti forti, quanto su dinamiche imprenditoriali e logiche di marchio; Sabrina Minardi sviluppa tale aspetto ponendo l’attenzione su “marchi” piuttosto riconoscibili, ma dimentica che il lavoro di ufficio stampa, oltre a prescindere dall’esistenza della letteratura, ne costituisce pure una sorta di negazione
Ricordando che l’editoria perde il 7% all’anno, durante il quale non legge neanche un libro il 57% della popolazione, il cui 70% è incapace di decifrare un testo complesso, Raffaella Silvestri afferma l’esigenza di trovare fondi per i programmi culturali e soprattutto per gli autori esordienti e le donne: come distribuire questi soldi e farli germogliare in cultura, rimane però un mistero, se non attraverso l’altrettanto misteriosa e un po’ democristiana misura di incrementare la rappresentanza dei Moderati, capaci di «assumere sulle proprie spalle il ruolo che la società culturale gli riconosce». Questa società culturale dovrebbe quindi essere estesa da ogni «intellettuale», livellando «democraticamente» il divario tra cultura alta e cultura bassa, mediando il bisogno del pubblico e l’ampia offerta di letteratura contemporanea.
Se la letteratura contemporanea non è propriamente quanto è pubblicato in questo momento e le distinzioni tra alto e basso sono saltate da un pezzo, un ampio dibattito informa che gli intellettuali non si sa più bene chi siano, mentre la classe media del paese, già in storico ritardo, è pure prematuramente sparita. Edward Said (Dire la verità, 1994), di cui Gallerani segnala la critica all’intellettuale miseramente preoccupato soltanto di non dare fastidio a nessuno, ricorda l’importanza di porsi ai margini, «lontani dai poteri accentratori»: tali argomenti appartengono a quel qualcosa da dire che ogni scrittore dovrebbe considerare, ma questo forse non riguarda la campionessa di Masterpiece, che crede di vivere in un mondo dove gli autori atterrano dai razzi e sono allattati dalle case editrici, piccole o grandi che siano.
Il realismo ritorna e ogni dubbio sembrerebbe però risolto da Alfonso Berardinelli. Cordelli vuole «fare dispetto a qualcuno attirando l’attenzione di molti», soffre di malumori e invidie alimentata dalla negazione della realtà, pretende di fare classificazioni rigorose e però va a casaccio. Se a dirlo è un vecchio amico, e un critico che comprende l’importanza della teoria letteraria, potremmo anche crederci: tuttavia, si ha l’impressione che Berardinelli voglia punire Cordelli, del quale è denunciata l’antipatia verso i Novisti (tra i quali Cortellessa, Giglioli, Pedullà), da cui si sente tradito, e verso i Conservatori (La Capria, Rasy, Onofri, La Porta, Berardinelli stesso), di cui non si fida per principio; di Novisti come Siti, colpevole di essere «uomo fondamentalmente di destra», invece si libera presto e in via del tutto ideologica, quindi inadeguata alla letteratura.
Un aspetto importante è nel riconoscere che le categorie a cui il Parlamento della Palude fa riferimento, oltre a essere approssimative, sono soprattutto datate: infatti, oggi «il nuovo è piuttosto vecchio, l’avanguardia sa di retroguardia, lo sperimentalismo è usato come garanzia di non sbagliare, la sinistra si nutre di nostalgie, il progresso produce regressione.» Il rilievo non trova però sviluppo e la questione sembra risolversi in uno scherzo della gelosia, riducendo così la letteratura ad un fatto umorale e privato.
Cordelli rilancia, pur prescindendo dalle reazioni al suo intervento in quanto non usa il computer, e in un’intervista ribadisce che quello letterario è un «mondo confuso», fatto di piccoli interessi egoistici e tribali: il problema vero è che «da tempo non esiste più l’universalità nella letteratura, che è diventata internazionale. Si tratta di un processo irreversibile dal quale non si tornerà indietro, conseguenza dell’iper-democrazia». Accennando ad un’importante distinzione tra universalità e globalizzazione, che trova sviluppi in Marc Augé, afferma che l’elaborazione stilistica, la quale dovrebbe contraddistinguere lo scrittore rispetto allo scrivente, è ormai secondaria: «non ci sono scrittori considerati all’unanimità grandi», anche perché si favorisce una «lingua internazionale, che si presta a essere tradotta facilmente».
Di fronte alle possibilità che un’epoca di contaminazioni non soltanto linguistiche sa offrire, la posizione rinunciataria di Cordelli appare propriamente aberrante e non può essere in nessun modo assunta come paradigmatica; conferma inoltre che, pure se qualcosa la indovina, lui non è un critico letterario: è quindi opportuno spostare altrove il fulcro della discussione, superando molte impantanate posizioni.
3. Prima della palude
Facciamo un po’ di storia dell’arte di raccontare storie, tralasciando considerazioni sulla poesia, la cui produzione prevalente è sembrata così velleitaria da non essere degna nemmeno di insulti; provvede però Giuseppe Genna affermando che quella degli ultimi due decenni faccia propriamente «schifo»: incapace di cogliere il mutamento antropologico, insufficiente nella considerazione storica e del tutto latitante in quella metafisica.
Il raccontare, se nella grecia antica poteva essere considerato affine alla dimostrazione argomentativa, progressivamente perde tale ruolo, e nella modernità approda alle forme del romanzo. Il primo a fornirne una descrizione è Hegel (Estetica, 1835-38 – postuma), che lo definisce quale «epopea borghese», espressione di mondo e categorie mentali dove entrano in contrasto «poesia del cuore» e «prosaicità del reale». Infatti, a differenza dei personaggi dell’epica antica, il Wilhelm Meinster (1795) di Goethe è solo il membro limitato d’una società, non la sua «figura totale»; tuttavia, la sua azione stabilisce una profonda unità narrativa. Lukács (Teoria del romanzo, 1916), estimatore di Manzoni, che da par suo già sapeva che le lettere fossero «una buffoneria, un mestiere guastato» (Fermo e Lucia, 1827), coglie proprio nell’opera dell’autore italiano la vicinanza al «dramma della vita» e l’importanza della lotta contro il tempo.
In un’Europa scossa da guerre e rivoluzioni la borghesia trionfa, portando anche allo sviluppo del romanzo. In Francia, il termine naturalista è attribuito dal sociologo Taine alla «comédie humaine» di Balzac, Zola elabora uno stile di scrittura analogo alle scienze naturali. Impersonalità e metodo sono perseguiti da Flaubert a prescindere da qualsiasi affettata «ispirazione» e preoccupazione sociale; il suo ultimo romanzo Bouvard e Pécuchet (1874-1880 – incompiuto) attraversa tutte le forme del sapere per mostrare, nelle spassose vicissitudini di due copisti che si ritirano in campagna, una ragione la cui ultima risorsa è di arrendersi «alla meschinità perenne del tutto». Questa segnalazione è di Maupassant, che dal 1880 e per dieci anni, in trecento novelle di splendida e crudele ironia, cesella la forma minima e più compiuta di una narrazione in perfetto equilibrio tra visione d’insieme e gusto del dettaglio, gocce di desolante verità dalla lunga influenza anche nel secolo a seguire. In un’Italia coinvolta in un lungo processo di nazionalizzazione e ancora priva di sviluppo industriale, il naturalismo assume le forme del verismo, trovando esponenti prima in Capuana e Verga, e poi in Pirandello e Svevo.
Il tempo incalza, drammaticamente, a una guerra mondiale ne segue un’altra, e la Germania che ha portato la filosofia alle sue vette crolla sotto il peso dell’effettualità più brutale, coinvolgendo anche l’Italia. La morte sanziona il narrato che alla vita attinge: Walter Benjamin (Il narratore, in Angelus Novus, 1955 – postumo), cosciente della crescente difficoltà tanto di incontrare chi è abile nel raccontare quanto di compiere e scambiare esperienze, sperimenta la contaminazione di tutti i generi in opere impossibili da completare. La coesione tra azione e storia inizia a dissolversi, con la perdita della centralità del soggetto conoscente anche il ruolo dell’io narrante inizia a smarrirsi, l’incontro con se stessi presupposto dal raccogliere fatti dispersi in storie da raccontare non è più così ovvio. In Italia, scapigliatura e decadentismo guardano a questi fermenti a distanza, lasciando forse la loro prova migliore nella prosa poetica e particolarmente tattile del Notturno (1916-1921) di Gabriele D’Annunzio.
Nell’espressionismo tedesco, è esemplare la frammentazione di piani e linguaggi rappresentata nel cantiere di una grande piazza da Alfred Döblin in Berlin Alexanderplatz (1929); il racconto della rottura diventa poi centrale in Günther Grass, e in Una lunga storia (1995) di fronte alle macerie del muro che ha definito la seconda metà del secolo si afferma che «il frammento è migliore dell’intero». In un proliferare di particolarismi, il capitalismo divorzia dalla borghesia e il mondo resta appeso ai giochi di una finanza sciupona; mentre si prepara questo nostro millennio in corso, Montale critica l’industria culturale e Calvino elogia una cultura industriosa; oggi, se la poesia narrata e universale e la prosa ritmata e duttile dei due grandi autori rappresentano sfide tuttora da raccogliere, i loro modelli di partecipazione culturale risultano ambedue datati. Nello smarrimento generale, a quelli che si credono svegli basta ripetere giaculatorie autoassolventi quali l’«io so» di Pasolini, ignorandone però implicazioni e portata, incrementando equivoci e illazioni.
L’esigenza di una prospettiva globale va mantenuta nonostante tutti i ritardi e i provincialismi di cui può soffrire l’Italia: peraltro, se oggi la globalizzazione è particolarmente pressante, l’italiano è una lingua colta che esiste da molto prima del paese politico e che esprime una letteratura da sempre aperta a vaste influenze. Nelle terre d’utopia di cui la letteratura si compone, è l’America ad essere vista quale teatro delle passioni collettive e a rappresentare, come intese Pavese (La letteratura americana e altri saggi, 1930-1950), un modo per scoprire l’Italia. E mentre il paese si diversifica al punto di faticare a ritrovarsi, le correnti culturali perdono di senso, il mercato editoriale si ritrova invaso da inutilità che di “romanzesco” hanno soprattutto le pretese del marketing, troppi si sentono obbligati a scrivere e atteggiarsi non facilitando quella “gultura” di cui tanto si parla.
Il sapere entra nell’era informatizzata, e fornisce attenzioni al fenomeno La condizione postmoderna (1979) di Lyotard, per il quale le esigenze di trasparenza e commerciabilità della comunicazione scaturite tra la fine del monopolio degli stati e il profilarsi delle imprese multinazionali favoriscono il proliferare tanto di verità locali dal valore pragmatico e irriducibili alle ideologie, quanto di forme di dissenso capaci di produrre nuovi saperi e in competizione con il potere. L’antologia di saggi Postmoderno e letteratura (1984) curata per l’Italia da Peter Caravetta e Paolo Spedicato è essenziale per comprendere le prospettive di un’idea di narrazione capace di includere la stessa storiografia e caratterizzata da piani e funzionalità, dove la costruzione di universi fittizi dipende da un principio logico immanente al testo.
Le esperienze di frammentazione, nomadismo, chiusura, trovano momento topico nel Pasto nudo (1959) di William S. Burroughs, smantellamento di testi attraverso complesse strutture associative. Ma se lo scrittore si limita, con le parole di quello che forse è anche l’autore più dotato della beat generation, a «guardarsi allo specchio» e a vendicare la propria insicurezza e dipendenza dal linguaggio, anche le esperienze di ricerca possono codificarsi e implodere in manierismo pedante e sterile autoriflessività: così, «l’usura delle forme» teorizzata da John Barth (Letteratura dell’esaurimento, 1967) diventa usura formale. Slittando dal postmoderno a qualcosa che gli è, se non dopo, a fianco, la metanarrazione di David F. Wallace (Verso occidente l’impero dirige il suo corso, 1989) lavora in tutti i modi possibili un racconto e la figura di Barth, ironizzando sul fatto che per qualcuno diventa narrazione persino questo: «I nomi verbizzavano via, avverbialmente aggetivali».
Con un razionalismo che sfiora spesso l’assurdo pur se alieno da ogni insensatezza, Leibniz aveva già compreso che la percezione è l’azione di strutturare i dati: ogni dato ha una storia e con tutte le altre storie diverse si inseriscono nel mondo, il quale è una storia scelta da Dio secondo libertà e necessità. Per quanto alla base non vi sia più alcuna armonia prestabilita ma piuttosto la destituzione del soggetto e della sua unitarietà, l’esigenza di coesione rappresentativa espressa dal filosofo consulente nel seicento viene in qualche modo raccolta negli anni ottanta dal narrativismo, corrente inaugurata dallo studioso di letteratura William J. T. Mitchell, che ha come influenza più diretta il decostruzionismo di Derrida e coinvolge in maniera multidisciplinare dall’antropologia alle neuroscienze. Alla base dell’esperienza umana c’è l’esigenza di ordinare gli eventi sparsi in una sequenza temporale coerente e carica di significato – in una storia che abbia un senso. La coscienza e il rapporto con la realtà sono di tipo narrativo (Jerome Bruner, psicologo cognitivista), l’esigenza di non far sprofondare la realtà nel delirio psicotico porta ad essere tutti perfetti romanzieri (Dan Dennet, filosofo).
Il narrativismo risponde alla fine della legittimazione ideologica del sapere e delle “grandi narrazioni” descritta dal postmodernismo promuovendo la narrazione a visione totalizzante capace di coordinare ogni frammento, ma viene sabotata dal fatto che i narratori più esperti e interessanti, come Proust e W. G. Sebald (Austerlitz, 2001), procedono non attraverso la memoria narrativa, ma in base a quella episodica, che si compone di flash isolati e non secondo la rigida organizzazione diacronica di una fiction. Peraltro, una memoria di episodi stratificati può essere maggiormente in grado di comprendere se stessa di qualche trama combinata per forza: dietro questa, come nota la filosofa Gloria Origgi, l’illusorietà del sé diventa ancora più schiacciante e la ricerca teleologica di senso definitivamente giustificatoria.
Si potrebbe contrapporre al narrativismo una considerazione “narrante” del criticismo kantiano, che attraverso la produzione di significati individuata da Cassirer (La filosofia delle forme simboliche, 1923-1929) permetta di pensare un pluralismo di prospettive internamente all’universale esigenza del narrare, seguendo un’oscillazione dal tutto alle parti che favorisca lo sviluppo, se non dell’identità personale, della capacità di giudizio e della nostra costante emancipazione, la cui teleologia è del tutto interna e dipende da specifiche ragioni da scoprire e ridiscutere di continuo. Tuttavia, questo è proprio quanto viene negato da una società che, chissà perché, si ritiene così emancipata da fare a meno del reale e di tutto il resto e dove un narrare inflazionistico tenta di tenere insieme personalità frammentate, conducendo così anche a inibire la capacità critica dell’autore, aspetto peculiare della letteratura moderna.
La comunicazione procede rivelando tutta la sua torbidità, la letteratura esonda dai confini ma offusca i propri ambiti, proliferano storielle sempre più insipide e dissenso e sapere diventano parole difficili tanto per conto loro quanto messe insieme. Infine, un rilevo critico si trasforma in motivo di denuncia penale (come nella querelle Carofiglio-Ostuni, nata da un appunto su Facebook e trascinata poi in questura). Nei decenni, pretese e ricatti si sono accavallati e confusi: proprio per questo, non è più possibile avallare qualsiasi cosa abbia forma di parole quale “scrittura” ma nemmeno si può voler far credere che la legittimazione di un testo letterario sia la “qualità”: Leopardi già sapeva che pochi sanno riconoscere la cura di un testo, e non a caso è pieno di famossisimi sciattoni per i quali ogni minimo approfondimento è sempre fuori luogo, conferendo preciso riscontro a quanto asseriva Il giovane Holden (1951) di J. D. Salinger: «uno stronzo è chi evita di fare un discorso intelligente.»
Le esperienze letterarie italiane emergenti negli inizi del secolo XXI sembrano ritrovare la capacità di sbrogliare una verità e appellare il reale attraversando le forme del verosimile e di un mondo irreale , ma anche quando trovano riscontri è per i fatti extralettarari legati alla comunicazione, quali la politica giudiziaria (Saviano) o la mondanità dei premi (Siti). I libri continuano a ritagliarsi culti molto selettivi, pochissimi affrontano la formazione necessaria ad avere effettive competenze letterarie, professori e comunicatori fanno a gara a favorirne il massacro. I cambiamenti di statuto comportano il restringersi del ruolo sociale dello scrittore, chi tarda ad accorgersene rende ancora più minuscola la propria importanza.
Le élite culturali ormai deposte pretendono di mantenere un’immeritata rendita di posizione, figure più o meno sponsorizzate sono perlopiù campioni di presenzialismo e raffazzonaggine: di per sé, il calo di vendita di cattivi autori affermati è un’autentica liberazione. Tuttavia, vendono ancora meno le innumerevoli opere degne: il problema vero è che mancano ambiente, dibattito e influenza, e laddove non si goda di particolari compiacenze e protezioni ci si ritrova spezzati tra inefficacia e incertezza. Nelle forme più patetiche la proliferazione tecnologica si accompagna a quella altrettanto incontrollabile degli scriventi drogati di autopromozione, grazie ai quali Internet, aldilà delle demagogie, si configura come la discarica dell’umanità: se l’obbligo di compilare il nulla coinvolge compulsivamente la popolazione mondiale, a molti mantenere un ordine del discorso suona blasfemo.
Conformismi e facili schemi possono trovare sponda in sofware che sembrerebbero permettere a chiunque di scrivere sceneggiature e romanzi: tuttavia, i programmi sono più realisticamente l’equivalente di una scrivania ben organizzata, e permettono di venire incontro all’esigenza di tenere in ordine appunti, schemi e schede senza doversi impicciare troppo con fogli e foglietti. Sempre al riguardo della meccanizzazione della scrittura, la casa editrice francese Short Édition segnala che anche l’intelligenza artificiale delle macchine è in grado di predire e preselezionare attraverso un algoritmo la consistenza letteraria di un testo, basandosi su criteri indicativi quali semantica, sintassi e campi lessicali; nota Le Figaro che uno stile, come nel caso di Céline, non si riduce affatto a tali elementi. Se le macchine sono così brave, possono anche suggerire a qualunque umanoide con pretese di scrittura che persino lui sarebbe è in grado di fare un minimo sforzo di elaborazione, quantomeno per comprendere cosa sia la semantica e tutto il resto.
Tutti vorrebbero aver un ruolo e sfondare a tutti i costi, ma la cosa buffa è che a ognuno manca qualche cosa. Gli esponenti d’ogni categoria accusano tutti qualche sorta di problema e, persi tra i monopoli e l’anomia, ostentano sicurezza in modi che rivelano l’intimo disagio. Gli affezionati all’etichetta d’autore si supportano in società di mutua ammirazione, sostanzialmente aliene tanto dalla possibilità di apprezzarsi con cognizione quanto dall’influenzarsi con criterio. I vari operatori del settore, editori, editor, agenti, promoter e compagnia cantando, sembrano carcerieri che pretendono rispetto verso condizioni delle quali sono i primi a soffrire. Coloro che ancora attribuiscono importanza al fatto d’essere lettori, si aggirano come orfani incapaci di chiedere aiuto. Intanto, circolano troppi libri vergognosi senza nessuno che se ne vergogni: anzi, pacche sulle spalle per tutti, basta che sei amico di qualcuno! Come stupirsi che nelle librerie piccole e grandi, nei social network, nei festival ufficiali, nei reading underground, insomma ovunque, impazzi il pantano?
Per lo scrittore scozzese Ewan Morrison i cambiamenti irreversibili che hanno segnato quanto definiva l’esperienza e il mestiere dello scrivere non profilano affatto una nuova era creativa, segnando anzi l’esaurirsi dell’autore singolo. Tuttavia, pur imponendosi blog, app e anche manufatti non-digitali, esisteranno sempre testi da scrivere, leggere e studiare (non soltanto da vedere) e una ricerca dell’essenziale continuerà ad essere necessaria: esisterà quindi anche qualcuno se ne farà carico, da solo e in compagnia (come è sempre stato).
Chiarisce Paola Dubini (Voltare pagina?, 2013) che la differenziazione dei formati moltiplica le opportunità: se «i libri sono oggetti che generano storie […] la presenza di supporti alternativi alla carta consente un ampliamento delle configurazioni possibili del testo.» Decade la pagina ma la scrittura si declina in nuovi modi, i confini dell’editoria si dilatano soddisfacendo diversi bisogni di elaborazione e fruizione, l’economia del libri è sottoposta ad un generale ripensamento ma non nega affatto il valore del libro.
L’inconsistenza non è un destino e le difficoltà non sono un fatto nuovo, e del resto l’assenza di «una società mediana, un abito, un giro di consuetudini non volgari» e di condizioni favorevoli alla cultura era stata segnalata già da Montale (Stile e tradizione, 1926). Trascorsa l’epoca dei grandi progetti editoriali e decadute anche le aspirazioni della piccola editoria, esauritasi fino all’oblio le diverse forme di realismo di Alberto Moravia (Il conformista, 1951) e Carlo Cassola (La ragazza di Bube, 1960), canonizzata anche la fuga dalla convenzionalità di cui sono stati maestri rispettivamente di invenzione e devianza Giorgio Manganelli (Antologia privata, 1989) e Gianni Celati (Costumi degli italiani 1-2, 2008), il costituirsi di una letteratura non potrà più basarsi su ristretti interessi circoscrizionali che prendono forma, come racconta Ermanno Cavazzoni (Gli scrittori inutili, 2010), in scuole di scrittura dove bene che vada s’insegna a vivere nella sofferenza e nella paura, in combriccole dove si discute su sintassi e refusi detestandosi e maledicendosi l’un l’altro, in riviste dove spadroneggiare grazie all’indispensabile supporto di derelitti analfabeti.
4. Fuori dalla palude
Per ritrovare un’idea dei compiti della scrittura e una teoria letteraria riferita ad opere capaci di svilupparla internamente, possiamo conferire la parola ad un Senatore, che, con le parole dell’ormai proverbiale Cordelli, «assiso nel suo distacco […] guarda con relativa attenzione». Giulio Ferroni, critico letterario e ordinario di Letteratura Italiana a La Sapienza di Roma, si chiede: «C’è un legame tra l’espansione illimitata della cultura e la sua evaporazione nell’illusione pubblicitaria, nell’insulsaggine spettacolare?» In Scritture a perdere (2010) l’interrogativo si struttura in una serrata analisi della produzione letteraria italiana odierna, formulando una visione prossima al filone di “critica della comunicazione” sostenuto principalmente dal filosofo Mario Perniola. Nelle sue argomentazioni, formulate negli anni zero e valide anche in quelli dieci, incontriamo molti dei nomi già visti, ai quali viene ora fornito maggiore contesto di comprensione.
Il tempo dell’eccesso attacca narrando i deliri di una giornata torinese, tra il Salone del Libro allestito in uno dei resti della vecchia città industriale e il palco mediatico di Amici insediato in una piazza del centro storico. L’immagine fornisce lo spunto per formulare la necessità di una «ecologia della comunicazione» e di un’etica della cultura, in modo da rispondere con responsabilità ad una situazione al contempo di eccesso e vanificazione che, se ha trovato nell’Italia berlusconiana un caso esemplare, rappresenta un fenomeno di portata mondiale, connesso in maniera inestricabile con l’assurdità di uno sviluppo economico ipertrofico e indefinito, esposto a continue crisi, che persevera in uno spreco sistematico delle risorse e privo di rapporti con bisogni reali.
Evaporazione di una cultura critica denuncia l’assenza di un’autentica opposizione a questa diffusa situazione di miseria culturale e umana. Ne sono prova la coesistenza grottesca di irrimediabili scempi ambientali e la difesa meschina di spazi particolari, l’indifferenza a quanto è pubblico e la concentrazione esclusiva sui propri interessi, l’intreccio di indiscrezione e violazione con la quale ogni banalità, a cominciare dalla propria, può essere esibita e spettacolarizzata.
Esibizioni di dilettanti incapaci, televisioni del dolore, talk show, reality, costituiscono precisi modelli culturali in cui l’unico criterio è il gioco di potere fine a se stesso; il massacro coinvolge anche questioni di rilevante interesse civile (il rappresentativo caso di Eluana Englaro, sul quale hanno gareggiato in squallore le più alte figure della politica e delle fede), o spinge addirittura al feticismo dei cadaveri di scrittori e artisti (l’esempio più eclatante, l’accanimento quasi fantascientifico sui resti del Caravaggio).
Nel prevalere delle ragioni del mercato, l’unico criterio di validità degli illusi è quello del successo facile e ad ogni costo. Questo esibizionismo facilone e volgare contagia non soltanto i presenzialisti e inconsistenti esponenti della cultura ufficiale televisiva, ma anche la vita istituzionale e quella scolastica, travolte da una spietata logica lobbista. Infatti, anche in ambito universitario l’impegno principale sembra volto alla difesa del proprio territorio e alla riproduzione delle cattedre, senza preoccuparsi di saturare in modo criminale gli spazi di ricerca indipendente, imponendo così contaminazioni ridicole, decostruzioni alla moda, virtualità trionfanti, senza indagare in nessun modo la realtà pur se chiusi nel peggior accademismo. Internet, che avrebbe la capacità di facilitare aperture inedite del libero sapere, non si sottrae dal diventare strumento di manipolazione e disgregazione, e alle possibilità di documentarsi capillarmente si preferisce sparare ai pesci nel barile.
Il dissesto è talmente profondo che un’effettiva resistenza intellettuale non riesce a formularsi, l’interrogarsi autentico è poco diffuso, poco popolare, poco ascoltato: una delle ragioni, che proprio il caso della Palude sembra aver dimostrato ampiamente, è laddove chi partecipa al dibattito pubblico è perlopiù mosso dalla bieca ricerca del consenso, la quale si alterna a provocazioni compiaciute e sterili; un’altra ragione è nei comportamenti effettivamente ostentati dagli intellettuali italiani, anche rappresentativi e di sinistra. Aggravano la situazione i poco accorti «esperti», gravemente malati d’audience, i quali alimentano l’equivoca pretesa che tale movimento di spettacolarizzazione a tutti i costi sia «liberatorio» nei confronti delle «culture alte» e della «ragione occidentale», acquisendo e banalizzando in tal modo anche contenuti un tempo tipici dell’underground e delle culture alternative – a loro volta perlopiù ridotte a caricatura di se stesse.
La critica militante è emarginata e quanto è chiamato “critica” si riduce a semplice propaganda editoriale; i giornali segnalano esclusivamente i libri da supermercato e si ricordano di recensire i libri degli scrittori di mestiere soltanto i loro amici. Di fronte a tale scenario, il capitolo Scrittori di successo si assume interamente e senza fare sconti a nessuno il compito di critico, già ampiamente dimostrato stroncando lo spesso vacuo Baricco, accingendosi a demistificare i fenomeni di bancarella e gli imbrogli del marketing, i «romanzi fluviali» che travolgono nel loro scorrere scorie linguistiche e comportamentali lasciandosi dietro proprio l’Italia che pretendono di raccontare.
Sono così riportati alla loro misura autori perlopiù famosi in quanto incensati, e viceversa. Margaret Mazzantini, con il suo proliferare di metafore forzate nelle quali ostenta un impotente buonismo e un precostituito «destino cinematografico». L’ «ex giovane di successo» Paolo Giordano, che discetta in modo chiuso di un mondo chiuso, nascosto dietro formule e intenti da scuola di scrittura dall’esclusivo valore pubblicitario e niente affatto programmatico. Tiziano Scarpa, troppo appassionato di escrementi ma indifferente alla storia, con argomenti poco centrati e narrazioni scarsamente credibili. Niccolò Ammanniti che, sopravvissuto al pulp, combina a profusione tasselli inconsistenti in un vuoto senza scampo. Le pretese d’antagonismo di Italian Epic, costola di Wu Ming, che riescono nella miracolosa impresa di associare monumentalità e sciatteria. I libri mediatici come quelli di Walter Veltroni, noiosi, scritti male e più che inutili, dannosi. In questi esempi, la scrittura svanisce, le ragioni si svuotano, lo stile si neutralizza. L’essenziale è lontano, ma solo l’essenziale può far sopravvivere, seppure in modo problematico, la letteratura.
Prosegue questa accanita opera di demolizione Frammenti del bestiario italiano, approfondendo le questioni sottese al noir, sorta di «arcadia truce» che almanacca o inventa fatti smisurati che suggeriscono l’ineluttabile adattamento al torpore civile e alla criminalità dilagante. Infatti, negli esempi più diffusi di questo genere proliferante e modaiolo, che procede con stile approssimativo ed enfasi localistiche, nessun intervento razionale sembrerebbe possibile, propagando un’artificiosa amplificazione dei fatti e la semplificatoria assenza di critica sull’esistente, nascosta da un’ipercritica totalizzante e infantile.
Infatti, la compiaciuta esibizione di nefandezze spesso trascura il sostrato comportamentale e antropologico su cui prospera ogni crimine, compreso il sempre più diffuso razzismo: il disgregarsi civile e le piccole irresponsabilità quotidiane che portano ad esiti disastrosi, la stupida indifferenza alle più elementari norme di sicurezza, l’ordinario spregio del minimo rispetto ambientale, l’occupare lo spazio senza porre attenzioni alla sua salvaguardia e condivisione. Un catalogo d’atrocità quotidiane, capace di rispondere a criteri antropologici e civili fondati, potrebbe portare oltre il banale compiacimento trash, in quanto effettivamente in grado di rispondere alla “«spinta interna alla scrittura». Il caso è quindi aperto, gli esiti sono imprevedibili: sarà forse qualche giallista convinto della propria missione moralizzatrice, tipo Carlo Lucarelli, a risolverlo?
Qualche strada praticabile: dal racconto all’”autofiction” cerca di trovare corrispondenze ad un’idea di «scrittura responsabile». Constatando l’esaurimento del romanzo, «inadatto a corrodere criticamente il presente» e costretto dalla sua stessa forma a dare immagini fittizie e mistificatrici, il racconto sembra maggiormente in grado di raccontare frammentarietà e pluralità dell’esperienza, risalendo alla forma primaria del narrare attraverso un’inesauribile molteplicità di prospettive. Il racconto rappresenta una risposta critica allo zapping imperante, scava nella tensione linguistica ed espressiva di una «globalizzazione puntiforme», si fa carico della residua possibilità di stile e ricerca linguistica. Il racconto può riportare deformazioni del quotidiano, ostilità di un mondo ottuso, piccole esistenze corrose, combinazioni di alto e basso, marginalità capace di risolvere interi mondi, come fanno comprendere autori quali Pier Vittorio Tondelli, Antonio Tabucchi, Sebastiano Vassalli, Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni, Antonio Debenedetti, Giovanni Martini, Francesco Pecoraro, Silvana Grasso, Antonio Pascale, Valeria Parrella, Gabriele Pedullà, Vitaliano Trevisan.
La possibilità del romanzo si conserva dove nella «polifonia del narrare» concorrono il trattato, l’autobiografia, altre intersezioni e interferenze, mantenendo aperte le possibilità di stile in aspetti quali la varietà dell’intreccio, la dislocazione interna, la pluralità di prospettive, l’assunzione di modalità di tipo saggistico. Il romanzo può vivere al di fuori di una struttura narrativa continuata, affidandosi alla problematica combinazione di livelli differenti, seguendo una strada già aperta da Carlo Emilio Gadda e Vincenzo Consolo. Il reale è colto attraverso un lavoro di «escavazione storica» che rende giustizia, più ai criteri del romanzo storico, ad una realtà intempestiva e priva di conciliazione, lacerata, frenetica, inconcludente.
Andrea Carraio (Il gioco della verità, 2009) mostra come l’epoca della comunicazione conduca ogni rapporto a risolversi in deviazione ostile; il già nominato Giorgio Falco (L’ubicazione del bene, 2009) lo ritroviamo alle prese con la lacerazione collettiva del presente formulata nella fisicità di un luogo assente a se stesso. Sulla ricerca di uno scarto critico capace d’interrogarsi sulla sfasata eterogeneità d’esperienze e linguaggi incedono, facendo comprendere quanto possono essere aperte le relazioni letterarie, anche altri dei nomi già incontrati: Cordelli, Affinati, Scurati, Di Stefano, Paris, Lagioia, Permunian,Mari, Moresco, Montesano, Piperno, Alajamo, Pariano.
La questione dell’io narrante, che si accompagna anche prima e dopo del postmodernismo alle vicissitudini filosofiche di un soggetto non più despota ma recettore, sembra risolversi nell’orizzonte dell’autofiction: l’io che parla non è autobiografico ma nemmeno fittizio, è dato da un’oscillazione capace di assumere forme e toni diversi, elaborando nomi ed esperienze coordinatamente a quanto c’è da evidenziare. Esempi tra loro diversi e irriducibili al romanzo tradizionale sono offerti da Storia naturale dei giganti (2007) di Ermanno Cavazzoni, nel cui almanaccare fantasia narrativa e realtà grottesca si scambiano di posto; La via (2008) di Fabrizia Ramondino, ascolto della vita dei luoghi colto nelle immagini di non-comunicazione; Il contagio (2008) di Walter Siti, indagine apocalittica sul mondo delle borgate romane.
Due casi atipici e reciprocamente incommensurabili sono rappresentati da Roberto Saviano, che con Gomorra (2006) indica un orizzonte di possibilità in uno scavo dell’esperienza capace di volgere l’impotenza in responsabilità, e La vita bassa (2008) di Alberto Arbasino, allegra disperazione che si inabissa in tutti i linguaggi possibili per poi farli svanire. Tra moltiplicazione dei messaggi ed evaporazione dello stile, invadenza del mercato e imporsi dei modelli mediatici, si apre quindi la strada una sorta di «pseudoromanzo» sospeso tra saggio, documento, cronaca, autofiction, digressioni, aforismi; forse, per chi ne sia in grado, può essere praticabile anche una poesia capace di consumarsi «nel suo autoriflettersi e nell’indeterminazione delle poetiche e dei linguaggi».
Infine, Responsabilità e destino pone di fronte alla paradossalità di una letteratura che prolifera e si annulla, confinata ormai in una condizione da sempre «postuma», affollata dalla «scrittura a perdere» di figuranti ben collocati privi tanto di perizia critica quanto di capacità propositive. Alla peculiarità italiana fa riscontro la complessità mondiale, determinando un quadro piuttosto critico; tuttavia, se relegata ai margini, la letteratura è ancora più necessaria, a patto che recuperi la sua funzione cognitiva «in un orizzonte di responsabilità e di interrogazione del destino della parola e del mondo». Non si può prescindere dalla demistificazione dei modelli e delle retoriche sociali prevalenti, già osservata da René Girard, che permetteva l’assoluta radicalità di autori quali Flaubert, del quale Calvino rimarca la critica impietosa di ogni pretesa d’investire valore nelle proiezioni del sentimento.
La sopravvalutazione narcisistica dell’esperienza individuale è così da demistificare quanto l’identificazione personale con un processo storico: pretese di tal tipo hanno accompagnato le peggiori illusioni del secolo passato e i suoi più grandi disastri. Piuttosto, occorre assumere in pieno la «coscienza interna della spinta alla narrazione», consapevoli «dell’inevitabile deformazione» comportata dal «chiamare in causa la realtà esterna»: tra ottocento e novecento, tale tensione narrativa ha permesso anche alle opere più ortodosse rispetto alla cultura ufficiale di uscire dai limiti imposti, favorendo così la coscienza dello scarto critico tra realtà e invenzione e permettendo l’assunzione della «responsabilità nei confronti della parola».
Facendo perno su tale nozione, Ferroni conclude che oggi è praticabile soltanto una «letteratura della responsabilità» in grado di interrogarsi sul destino del pianeta e di chi lo popola: una letteratura capace di contribuire ad una «cultura respirabile» che possa fornire senso alle vite di chi potrà seguire e sappia favorire i legami con quanto ci ha preceduto. Dal momento che la condizione dell’attuale generazione delle persone che leggono e scrivono è già «postuma» rispetto al mondo perduto in cui è cresciuta, è inutile fissarsi nello spazio della «fine»: inevitabilmente, altri verranno ulteriormente «dopo», e pertanto occcore proteggere la possibilità dell’esperienza, per quanto questa sembri impossibile.
Lo scrittore, se vorrà essere tale, dovrà sottrarsi alle ossessioni dei target precostituiti che gli impongono, con meccanismi analoghi a quelli di politica e pubblicità, la visibilità e/o la provocazione, costringendolo in definitiva a sottoscrivere il mondo così com’è; un’altra esigenza è nel ricollegarsi alla tradizione di «negazione» tipica della modernità, confrontandosi apertamente con la confusione e l’eccesso della comunicazione, svuotandone intenzionalmente le illusioni. «Ricerca dell’essenziale, impegno nell’ascolto del mondo, cura per il suo destino, disposizione a dislocare l’invenzione e a toccare il cuore del linguaggio»: ecco i compiti che spettano agli scrittori. Ovunque possano essere, fuori dalla palude.
Fuori dalla palude, l’appello del presente si può corrispondere oltre l’autoreferenzialità che ha permesso la teatralizzazione di ogni stupidaggine, l’autopromozione del vuoto e altri paradossi effettivamente paludosi. Se non è più possibile la narrazione compiuta delle forme tradizionali, è perché la stessa modernità è rimasta incompiuta, ed è decaduto anche il postmodernismo e l’abuso di categorie quali fine della storia e morte del soggetto. Quanto ancora possiamo chiamare come creazione attende sempre si essere proseguita, poco importa se per stupirsene o contestarla. Il discrimine sul quale la scrittura può incidere si stabilisce così nell’interazione tra reale e virtuale e nell’oscillare tra documento ed esperienza. Un campo aperto di narrazioni possibili, indefinite nel campo ma esatte nello stile, attende di essere esplorato.
•
Fotografia: Claudio Comandini, “Palude di città” – Bologna, ottobre 2012.