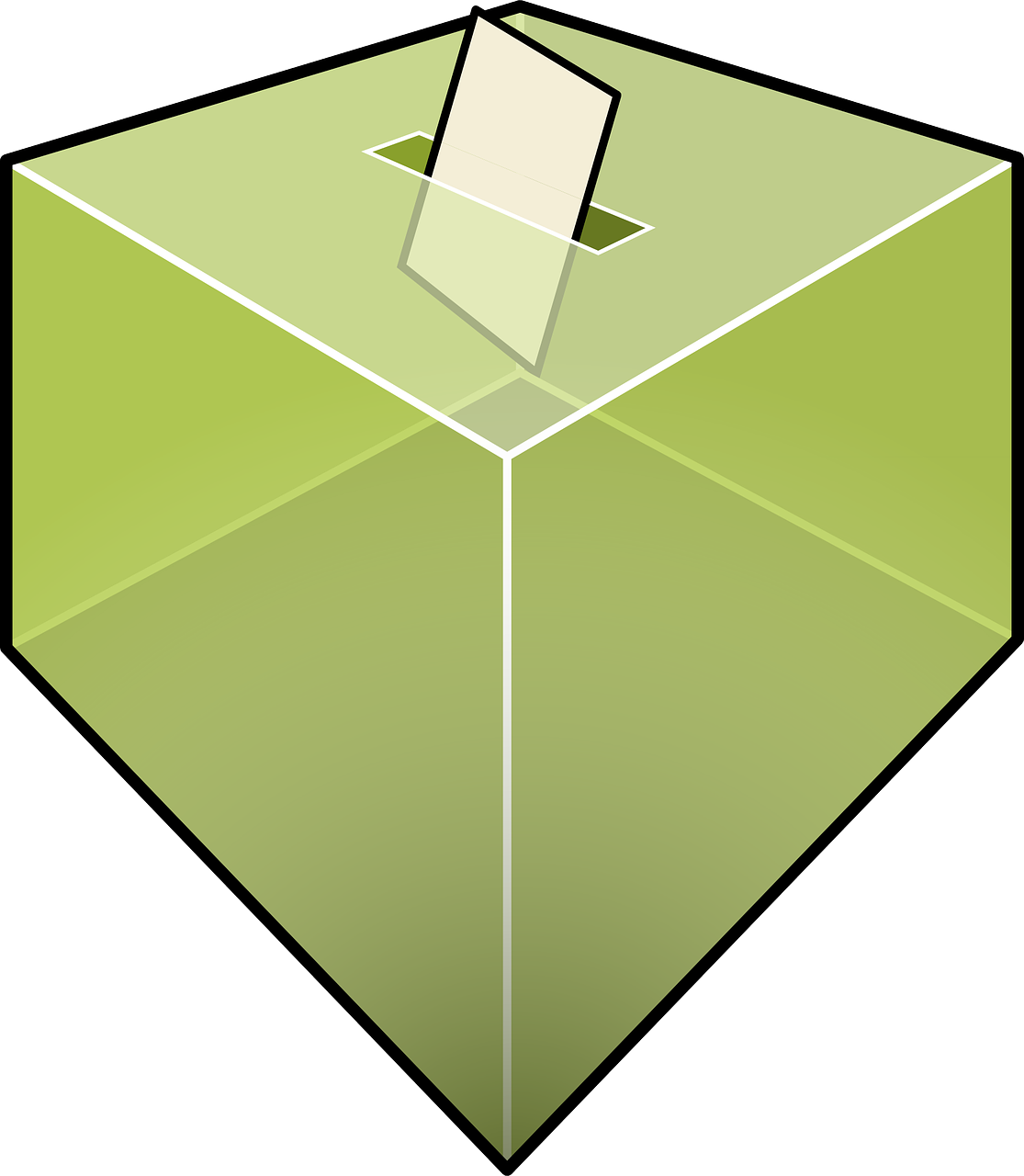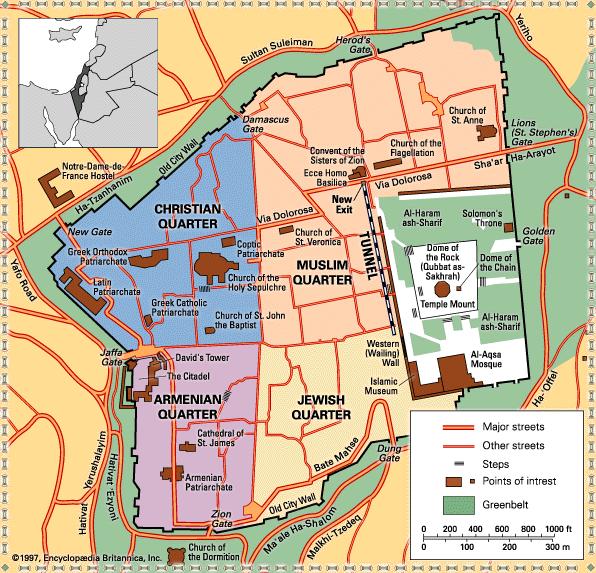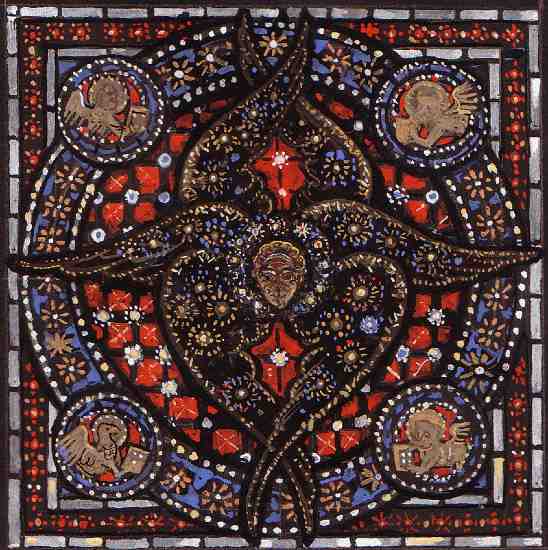Il lavoro di antropologo e filosofo di Marc Augé (Poitiers, 1935), ampio e diversificato, presenta al suo interno una profonda coerenza di pensiero e indagine, ed è proprio l’intreccio tra le diverse tematiche a permettere di esplicare le costanti della sua ricerca. Inizialmente, ha dedicato le sue attenzioni allo studio delle società tribali della Costa D’Avorio e del Togo, cercando di rintracciarne la logica implicita nella loro autorappresentazione (ideo-logic). Successivamente, si è concentrato sull’elaborazione di un’antropologia delle società contemporanee e della “surmodernité”, rispetto alle quali ha elaborato la teoria dei “non-luoghi”, espressione che indica lo spazio tipico delle stazioni ferroviarie, delle stanze d’albergo, dei grandi magazzini. Presentiamo un suo testo sull’egemonia del presente, e a seguire un breve colloquio con l’autore su cinque questioni essenziali: oblio e memoria, universale e individuale, educazione e scommessa, autocolonizzazione e metrò immaginario.
Il problema è che oggi regna sul pianeta un’ideologia del presente e dell’evidenza che paralizza lo sforzo di pensare il presente come storia, che rende obsoleti tanto le lezioni del passato quanto il desiderio di immaginare l’avvenire. Da uno o due decenni, il presente è divenuto egemonico. Il presente, agli occhi del comune mortale, non è più frutto della lenta maturazione del passato, non lascia più trasparire i lineamenti di possibili futuri, ma si impone come un fatto compiuto, opprimente, il cui sorgere improvviso elude il passato e satura l’immaginazione dell’avvenire.
Ciò che io chiamo l’ideologia del presente si esprime in diversi modi e noi possiamo individuarne l’esistenza a partire da almeno tre fenomeni contemporanei e concomitanti che costituiscono, a mio avviso, un nuovo campo di investigazione per l’antropologia.
Il primo di questi fenomeni rimanda a Lyotard e alla «fine dei grandi racconti», alla perdita delle illusioni che gli uomini hanno nutrito sul progresso dell’umanità, segnatamente del XX° secolo. Il momento postmoderno sarebbe quello in cui i miti moderno, i miti del futuro, i miti universalistici che avevano costituito le cosmogonie particolaristiche, scompaiono a loro volta. Una delle ragioni di questo fallimento, consisterebbe in ciò che Lyotard ha chiamato différend, la differenza di percezione tra quelli che inventano teoricamente un’ideologia universalistica liberatrice e quanti ne subiscono storicamente gli effetti. La Rivoluzione francese fu un atto di liberazione universale o semplicemente l’espressione dell’espansionismo francese che doveva trovare il suo vero eroe nella persona di Napoleone? Sicuramente ambedue, ed è da questo punto che iniziano le difficoltà.
Il tema della fine dei grandi racconti ha preceduto quello che Fukuyama ha sviluppato, della fine della storia. I due temi sono lungi dal confondersi. Lyotard, invocando la fine dei due grandi tipi di miti, ci invitava a riflettere sui nuovi modi di relazionarsi con lo spazio e il tempo che definivano la condizione “post-moderna”. Con la fine della storia si tratta invece di produrre un nuovo “grande racconto”. La fine della storia, evidentemente, non è la definitiva interruzuione delle vicende storiche, ma la fine di un dibattito intellettuale: tutti, dice Fukuyama, sarebbero oggi d’accordo nel ritenere che la formula che associa libero mercato e democrazia rappresentativa sia insuperabile.
Derrida, nel suo libro Spectres de Marx (Galileé, 1993) nota a tal proposito che le formulazioni di Fukuyama non sono chiare e che un dubbio sussiste attorno al senso che bisogna dare alla nozione di «fine della storia»: si tratta di uno stato di fatto inconfutabile oppure di un’ipotesi speculativa? Fukuyama presenta la «buona novella» (Derrida ne sottolinea il linguaggio evangelico) dell’avvento della democrazia liberale sia come evento empirico, sia come un ideale regolatore: «L’evento, è talvolta la realizzazione, talaltra l’annuncio della realizzazione». Ma questa stessa esitazione (o incoerenza) è tipica di un’atmosfera intellettuale nel quale niente appare più difficile da immaginare del futuro.
Si avrà un’idea di questa difficoltà interrogandosi sullo status dell’evento al giorno d’oggi. In seno alle società studiate tradizionalmente dall’etnologia, l’evento, nei limiti del possibile, è negato; è rinviato alla serie di determinazioni intese come simultaneamente sociali e antropologiche che si ripercuotono sulla struttura. Allorquando tale ripercussione, questa “eziologia sociale” non è più possibile, giacché l’evento è troppo grande e sproporzionato in rapporto agli strumenti abituali di misura e d’interpretazione, ad esempio nel caso dell’invasione coloniale, si mima l’evento, lo si gioca, lo si mette in scena (sul modello dei “riti d’inversione” effettuati nei momenti di epidemie e in occasione della morte del capo), nella speranza che questa specie di sfida simbolica basti a scongiurarlo.
Nel caso della colonizzazione, questa speranza è stata sempre delusa, e il “profetismo” africano, ad esempio, non ha cessato di ripetersi, fino ad un passato molto recente. Ma è riuscito a livello locale e per lungo tempo a scongiurare la violenza, in modo che è stato sempre difficile, per gli africani come per gli etnologi, decidere se i profeti fossero dei collaboratori o agenti della resistenza giacché, ovviamente, erano la entrambe le cose.
Nelle società attualmente più sviluppate, si assiste ad un montare della paura dell’evento (si pensi alla categoria del rischi, al ruolo delle assicurazioni, alla giuridicizzazione della pratica medica, all’idea di insicurezza o al timore dei cambiamenti climatici). Questo aumento delle paure provoca classicamente una ricerca delle cause e dei responsabili che, seppure in un ambiente sociologico diverso da quello delle società politeiste, ne ricorda tuttavia alcuni aspetti. Al contrario, quando l’evento è di una portata imprevista e di primo acchitto imprevedibile, come fu per l’attentato dell’11 settembre, la strategia cambia subito. La ricerca dei colpevoli immediati, morti, e dei responsabili più lontani, irraggiungibili in un futuro prevedibile, dà subito spazio ad un’iniziativa temporale nuova: si fa dell’evento non un punto di arrivo che occorre spiegare, ma un punto di partenza che chiarirà ogni cosa. È lì che si trova il significato e il ruolo della seconda guerra dell’Iraq, e più in generale, della guerra dichiarata al terrorismo.
La storia non è in effetti più la stessa dopo l’11 settembre. Ma questo nuovo inizio non invalida né deve invalidare, a motivo di ciò, agli occhi dei suoi ideatori, il tema della fine della storia, proprio in quanto il nuovo conflitto non assume significato se non in seno al mondo globalizzato, di cui è un pervertimento momentaneo e locale. In tal senso, non sussiste necessariamente contraddizione tra il tema della fine della storia e quello dello «scontro di civiltà» (nel senso descritto da Huntington – nota del curatore). Lo “scontro” non contraddice la fine della storia: è uno dei sintomi del suo manifestarsi.
Il secondo fenomeno è il predominio del linguaggio spaziale sul linguaggio temporale. Esso è strettamente legato al fenomeno più ampio della mondializzazione e al paradosso analizzato precedentemente, ma qui conviene ricordare la rivoluzione che determina nella nostra percezione dello spazio, ovvero, più precisamente, il capovolgimento dei rapporti tra interno e esterno. La coppia globale/locale ha rimpiazzato l’opposizione particolare/universale che, associata ad una concezione dialettica della storia, si inseriva nel quadro del periodo. L’assimilazione dell’opposizione globale/locale a quella di interno ed esterno acquista senso in rapporto al tema della fine della storia intesa come avvento delle democrazie liberali, ossia, in fin dei conti, in rapporto all’opposizione fra sistema e storia.
L’interno, per il Pentagono, secondo Virilio, è l’interno del sistema economico e tecnologico le cui reti formano la globalizzazione; l’interno è il globale e il reciproco. L’esterno, al contrario, è il locale, nella misura in cui non una semplice riduplicazione del globale, ma interferisce con il sistema, e quindi suscettibile di un eventuale diritto di ingerenza. Si comprende che, da questa prospettiva, la storia come perturbazione di un sistema che ha delle velleità di presentarsi come l’utopia realizzata, non possa avere che un’origine locale. È il linguaggio spaziale che esprime e in un certo senso protegge l’organizzazione attuale del mondo.
Il terzo fenomeno da prendere in considerazione è il regno delle immagini, e specialmente delle immagini televisive. Da una parte, ci rinchiudono nello spazio. I satelliti riflettono le immagini da un punto del pianeta all’altro, gli avvenimenti dell’attualità sono ritrasmessi, interpretati e rappresentati quasi simultaneamente ovunque sulla Terra. Noi ci abituiamo a esserne informati a orari regolari. In senso più ampio, il nostro ambiente tecnologico gioca un po’ più il ruolo delle cosmologie tradizionali che regolavano lo spazio (compreso il corpo umano) e il tempo (comprese la nascita e la morte) per attuare una sistemazione simbolica del mondo. Oggi siamo circondati da oggetti materiali estremamente sofisticati che invadono quotidianamente la nostra esistenza e sembrano conferirle un senso. Sono giorno dopo giorno più vicini a noi; ci assegnano una residenza, si piazzano sul nostro corpo, ci permettono di comunicare col mondo intero senza che ci si sposti, ci abituano al nido tecnologico che ci pone al riparo del passato e dal futuro come se esistesse soltanto il presente.
Dietro il gioco delle immagini e dei messaggi capaci di dare l’impressione che malgrado le violenze dell’attualità, non succeda nulla, tuttavia si stanno compiendo notevoli progressi. La conquista della galassia è iniziata e sappiamo bene che, tra qualche decennio, non guarderemo più il cielo con i medesimi occhi. L’esplorazione dello spazio non è l’unica ad offrirci delle prospettive vertiginose. La scienza progredisce anche nell’esplorazione della vita. Il confine tra materia e vita sarà presto riconosciuto e marcato. La genetica permette di interrogarsi sull’apparentamento di alcune specie lontane nonché sulla realtà e i limiti dell’individuazione. La coscienza si interroga sulle circostanze della sua apparizione.
Ma la scienza, all’inverso delle cosmologie rassicuranti che postulano una totalità dispensatrice di significato, avanza nell’ignoto di cui modifica progressivamente le frontiere. Si confronta con l’ignoto ed è a motivo di ciò forse che la sua immagine è ambivalente: da una parte, si sa che è all’origine di tutte le tecnologie che ci circondano, dall’altra ci fa sentire l’immensità di tutto quanto ancora ignoriamo. Non è rassicurante. Inoltre, malgrado le apparenze diffuse dalla globalizzazione, l’ineguaglianza dei saperi è ancora più grande di quella delle ricchezze.
•
Il futuro del presente: Claudio Comandini intervista Marc Augé
1. Lei denuncia i caratteri di “egemonia” e “oppressione” dell’attuale ideologia del presente: facciamo un passo indietro e due avanti, in modo da comprendere tale problematica nell’articolazione complessiva del suo pensiero. Possiamo ricollegare questa teoria del “non tempo” a quella del “non luogo”, definito come spazio “né identitario, né relazionale, né storico” in Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité (1992). Se questa temporalità annulla il passato e sospende l’avvenire, che ruolo vi intrattengono l’oblio e il “saper dimenticare” teorizzati ne Les formes de l’oubli (2001)?
– In tale temporalità l’oblio e la memoria sono inseparabili. In un certo senso l’oblio scolpisce i contorni della memoria. Il rischio oggi è quello di perderli entrambi. Da una parte, non c’è oblio, tutto è archiviato; dall’altra, non c’è memoria, perché viviamo in una sorta di presente perpetuo.
2. Nel suo lavoro antropologico, etnologico e filosofico, si è prima interessato allo studio delle società tribali della Costa D’Avorio e del Togo, per poi dedicarsi all’elaborazione di una antropologia delle società contemporanee. Da tale prospettiva, ora individua i fenomeni prevalenti delle società contemporanee nella fine dei miti e della storia, nella prevalenza del linguaggio spaziale, nel dominio delle immagini. Se la coppia concettuale e operativa predominante sembrano essere “globale” e “locale”, quale ruolo hanno universale e particolare?
– L’universale non sta dalla parte del globale, e il particolare non è il locale. Forse il locale e il globale sono in un rapporto di duplicazione? Il particolare e l’universale sono in un rapporto di complementarietà incompiuta, di rapporto dialettico. Sono entrambi dalla parte dell’individuo. Ogni individuo è unico, ma le domande che tutti gli individui si pongono sono universali.
3. In questa dittatura del presente, le ineguaglianze delle ricchezze e quella dei saperi sono funzionali agli equilibri dominanti: tuttavia, una “umanità unificata” necessita di un’ “utopia dell’educazione per tutti”. Ma come ottenerla? È appropriato configurarla con i caratteri di “immanenza della morte, necessità dell’azione, arbitrarietà del senso”, insomma come quell’ “atto eroico” caratterizzato nel Génie du paganisme (1982)?
– Credo in effetti che un’utopia dell’educazione dovrebbe passare attraverso un totale ribaltamento della prospettiva e una morale eroica: insomma, una “scommessa”.
4. Perseverando in tale scommessa e mantenendoci nella rottura dell’ordinaria dissimetria cognitiva eurocentrica, applichiamo metodi e contenuti dell’antropologia ai contesti della “surmodernità”. Possiamo parlare di realtà post-coloniale nei paesi europei? Secondo lei l’Italia a quale sfera del mondo appartiene? Gestisce la globalizzazione o la subisce?
– Attualmente tutti i paesi, anche i più sviluppati, sono in una situazione di colonizzazione da parte di un immaginario che per la maggior parte gli sfugge. Nelle ex-colonie potremmo parlare di autocolonizzazione. L’Italia e i paesi europei più ricchi sono in una situazione di questo tipo.
5. Proseguiamo il viaggio intrapreso su Un ethnologue dans le métro (1986): in un metrò immaginario che unisce la Costa d’Avorio alle metropoli europee, quali sono le stazioni che segnano ancora la sua quotidianità?
– La mia linea di metro farebbe un giro per l’America Latina, vagherebbe in Europa (specialmente in Italia) e arriverebbe a Parigi, ma il viaggio potrebbe essere fatto anche in senso inverso.
•
Estratto da: “Qual finalites pour demain?”, «Pandere», luglio/dicembre 2006, Edizioni Noubs, ISSN 1828-8499.
Intervista realizzata da Claudio Comandini in Internet nel dicembre 2009
Fotografia: Claudio Comandini, “Città irreale” (Pescara, 2009)