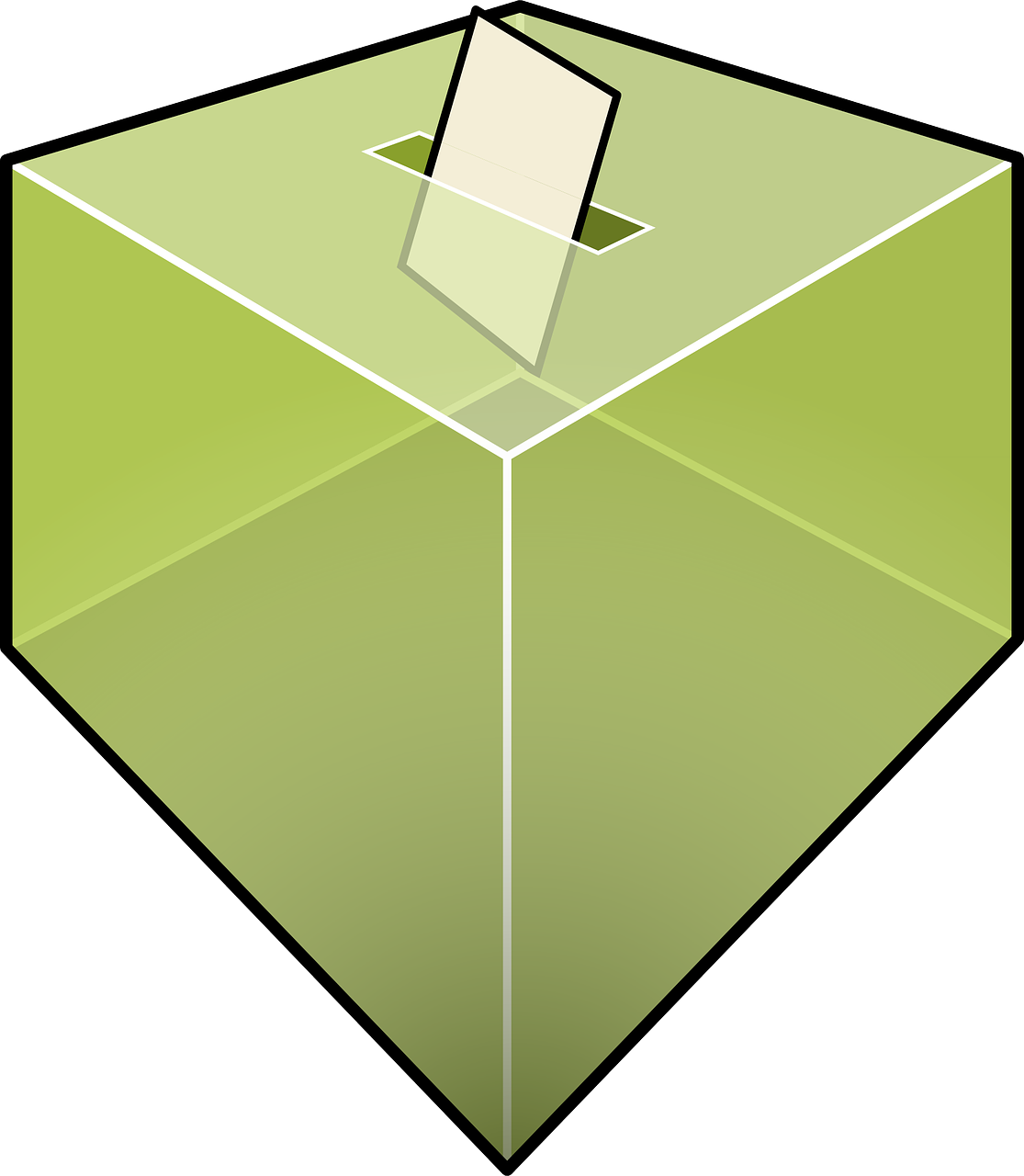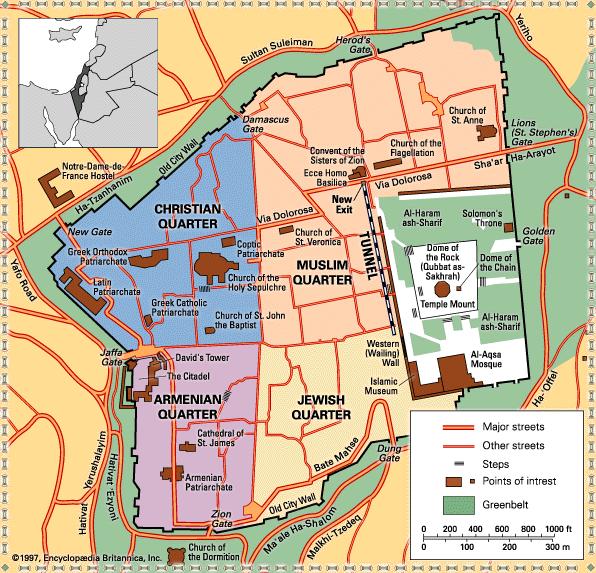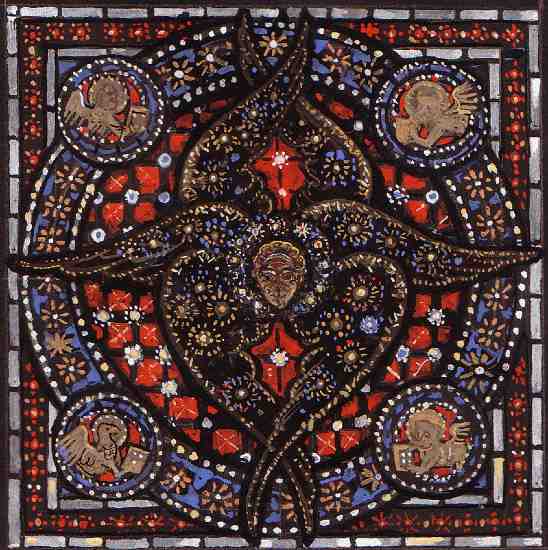Un tempo, esistevano l’arte popolare e l’arte colta; poi, venne il sogno di un’arte di tutti e per tutti; oggi, questo sogno è diventato un incubo. L’ossessione verso una qualche ‘urgenza espressiva’, dove quanto c’è da esprimere rimane confinato in una prospettiva del tutto egoica e personalistica, che trova forte aggancio negli usi aberrati di Internet e nelle pretese autorealizzative di marca new-age, sembra dimenticare del tutto che l’arte, indipendentemente da correnti e stili, è soprattutto scoperta di alterità, e che ogni segno rimanda sempre a più in là. Ma questo, ricorda con divertito sarcasmo JJ Charlesworth (su twitter:@jjcharlesworth), critico e redattore freelance associato presso ArtReviewmagazine, non sembra interessare gli artisti e il pubblico di circuiti tra loro apparentemente molto diversi, tra i quali ogni distinzione è però ormai vanificata dalla comune passione autoreferenziale per i selfie. Charlesworth si riferisce soprattutto all’annata 2014, ma il suo scritto mantiene pieno valore per una critica del presente: infatti, le tendenze messe in rilievo non sono cessate. E mentre vanno ogni giorno incontro alla loro inevitabile autodistruzione, non sembrano preoccupare troppo i loro adepti: a ragione, perché in definitiva nessuno se ne preoccupa.
Per chi voglia individuare il più significativo problema/tema/fenomeno del mondo artistico, il 2014 ha messo in gioco diversi contendenti. Il record dei fallimenti per i risultati d’asta? Buttateci un occhio. Artisti che si sono trovati piuttosto incasinati per parole in libertà controverse controverse? Bella storia. Una politica dell’attivismo presa in consegna dalla memosfera visiva? Mica me ne lamento. I tentativi sempre più disperati delle gallerie blue-chip di mantenere credibilità per le iperpubblicizzate giovani stelle della pittura? Ci si può fare una bella risata.
Tuttavia, a volte sono gli sviluppi più marginali a infastidire. E per quanto mi riguarda, una delle tendenze più significative e meno attraenti è stata l’incremento della rumorosa quanto vuota celebrazione dell’artista-quale-ego. O forse, ma non ne sono sicuro, si dovrebbe dire dell’ego-quale-artista. Naturalmente, il mondo dell’arte è sempre stato affollato di ego piuttosto massicci: così, si potrebbe giustamente controbattere, quale sarebbe mai la novità? Eppure, il 2014 è sembrava essere l’anno nel quale l’ossessione per l’espressione più narcisistica dell’individuo ha cominciato a prendere il centro della scena. Puntando così alla fusione, apparentemente inarrestabile, dell’arte con una nuova forma di cultura della celebrità, nella quale l’autoespressione individuale è diventata ossessiva al di sopra di ogni altra considerazione.
Non sto parlando della sfilza dell’enorme altalena di, ehm, spettacoli egoici, compiuti perlopiù da artisti di sesso maschile a fine carriera. Per quanto, anche quelli sono continuati ad andare forte: possiamo annoverare l’intronizzazione di Jeff Koons con il titolo de «Il più importante, influente, popolare e controverso artista del dopoguerra» (secondo la folle e iperventilata pubblicità del Whitney Museum di New York), i toni interminabili e pomposi della retrospettiva a basso grado gravitazionale di Anselm Kiefer al RA di Londra, e le erezioni in acciaio massiccio del dio minimalista Richard Serra nel deserto del Qatar. Quando si tratta di carriere consacrate, i grandi musei sono felici di corrispondere, nel disperato tentativo di tirare dentro grandi folle che ormai vivacizza questo periodo.
Eppure, se vogliamo parlare dell’aspetto veramente contemporaneo dell’arte ego-maniaca mondiale, quello che è realmente venuto alla ribalta è stata la figura dell’artista quale canale per una presunta esperienza profonda – tanto personale, quanto terapeutica. Il fenomeno è stato forse esemplificato al meglio dalla crescita inarrestabile di Marina Abramović, ormai soprannominata la «Regina della performance art». Con il suo “512 Hours” Show al Serpentine di Londra, seguito dal “generatore” al Sean Kelly di New York, la Abramović ha scalato nuove vette di assurdità partecipativa. Infatti, non capita tutti i giorni di vedere file di persone che circondano un palazzo per una mostra d’arte senza lamentarsi. Ma tale è la riverenza concessa alla versione di Abramović di arte promossa ad una sorta di programma di auto-aiuto new age, che non soltanto si fa la coda, ma diventa addirittura un privilegio proprio lo stare in coda in piedi per ore, e non fare nulla di più, agli ordini del guru Abramović, con il Serpentine trasformato in una sorta di ashram minimalista per hipster dai pantaloni a vita bassa.
Forse, sto offendendo coloro per i quali la meditazione, la consapevolezza, e trovare la propria quiete interiore, rappresentano un enorme problema. Oh bene: peccato. Ad ogni modo, non vi ho mai invitato alle mie feste. Il punto è che, formulato nel linguaggio dell’auto-realizzazione-meditante che insiste su parole d’ordine quali «dimenticare il passato» e «vivere nel momento», in realtà il recente lavoro della Abramović cristallizza e riflette quella che risulta essere la più vasta tendenza della cultura contemporanea: l’ideale narcisistico dell’auto-realizzazione, vivere il momento, trovarsi e (una volta che ti sei trovato) essere se stessi, e lì restare. In breve: corrispondere all’espressione culturale della Generazione Y, detta anche Generation Me, come l’accademico statunitense Jean Twenge l’ha stilizzata nel libro omonimo del 2006.
La cultura della cosiddetta Generazione Y privilegia l’espressione di sé su qualsiasi altra cosa. Molte celebrità (certamente, la maggior parte delle celebrità americane) sono così arrivate ad esprimersi attraverso il medium dell’arte, o almeno attraverso i media del mondo dell’arte. Ancora nel 2014, James Franco ha “rielaborato” le prime opere di Cindy Sherman, con se stesso nel ruolo di protagonista. Shia LaBoeuf ha proseguito le sue performance d’arte in stile buffonata nella propria galleria di spettacoli “#IAMSORRY” (completandole con la bizzarra denuncia di esser stato violentato da una visitatrice).
E chi può dimenticare la reinvenzione del mondo dell’arte compiuta dalla stuzzicante popstar Miley Cyrus, la cui decisione di fare sculture è stata suggerita dai doni a lei lanciati dai fan ai suoi concerti? Come afferma Cyrus con precisione e sincerità piuttosto caratteristiche: «Ho ricevuto un sacco di spazzatura e merda veramente del cazzo, e così, invece di lasciare che restasse spazzatura e merda, l’ho trasformata in qualcosa che mi ha reso felice.» Cyrus dichiarato: «Mi sento come se la mia arte fosse diventata una specie di metafora – un esempio della mia vita». Al che, si potrebbe rispondere: «Certo, ma chi cazzo se ne frega?» Il problema è che, se è facile licenziare le varie esili messe-in-mostra della creativa-auto-realizzazione del celeb-artista, tutto questo in realtà sta semplicemente cavalcando l’onda della più ampia cultura del movimento di “me”, che galoppa nella vita di tutti i giorni attraverso un’inarrestabile marea di selfie e tweet.
Vi sembra troppo brusco legare l’austero pseudo-spiritualismo-trascendentalista della Abramović al carnevale idiota dell’arte delle celebrità? Non proprio. Possono sembrare agli antipodi, ma sono realizzati in base alla medesima venerazione dell’auto-realizzazione personale attraverso l’auto-espressione, per la quale a contare è il processo, non il prodotto. A tutti ormai basta “essere se stessi” per affermare di essere “arte”. E questo è anche il motivo per cui le mostre d’arte sono diventate “esperienze”. L’unica mostra che sembra aver mosso la partecipazione degli spettatori, e nella quale ho fatto tappa estiva ad Art Basel, era quella di Klaus Biesenbach e Hans Ulrich Obrist al museo-di-cazzate-e-divertimenti-mostruosi-e-corridoio-di-incubi 14 Rooms (che comprendeva, ovviamente, un pezzo di Marina Abramovic.) Sentirsi in un’esperienza, essere nell’adesso: questa è la nuova estetica della Gen Y.
Ecco perché, anche se tutti gli artisti maschio-alfa potessero fare un grande spettacolo di se stessi (tipo Jeff Koons nudo in palestra vestito di soli guanti di pelle. Aiuto!), risulterebbero comunque in ritardo, bloccati nel passato. Perché appartengono ad una generazione ancora convinta che l’arte debba concernere qualcosa di diverso da me-qui-in-questo-momento. Che ancora pensa, ad esempio, che l’arte dovrebbe riguardare, per dire, il consumismo, oppure la storia della Germania, o anche soltanto come appare un’imponente distesa di pezzi di Cor-Ten in acciaio se la ficchi in un qualche deserto. In altre parole: che l’arte debba riguardare cose sulle quali si deve riflettere, e discutere, e argomentare con gli altri, per trovarsi persino in disaccordo: insomma, che l’arte tratti qualcosa che non è esclusivamente incentrata su se stessi. Ma, per il momento, tra Miley e Marina, si è cominciato a rivelare questo futuro per l’arte: artista e pubblico che si tengono per mano tra specchi infiniti, con una mano libera per poter spremere un selfie.
•
JJ Charlesworth, “The Ego-Centric Art World is Killing Art”, «Artnetnews» 30.12.2014.
Traduzione: Claudio Comandini
Fotografia: “Miley Cyrus performing Love Money Party on her Bangerz Tour Tacoma” – Washington, 2.16.14.