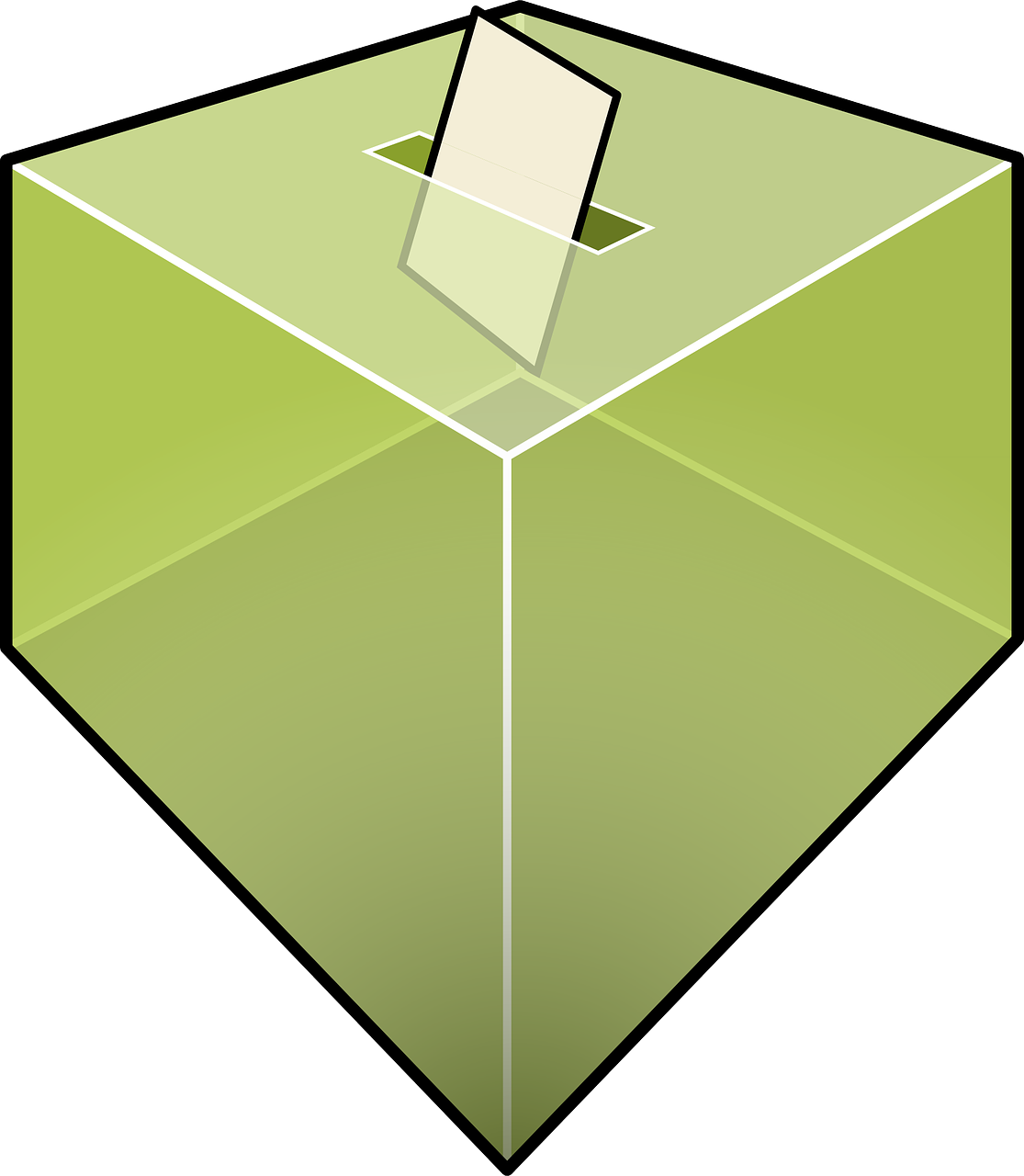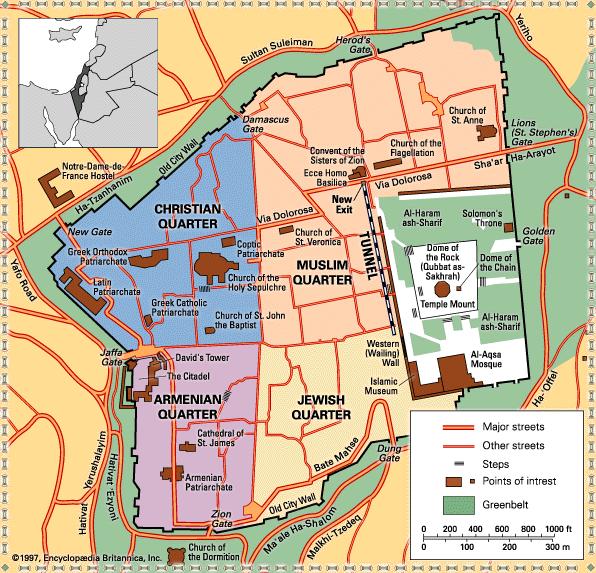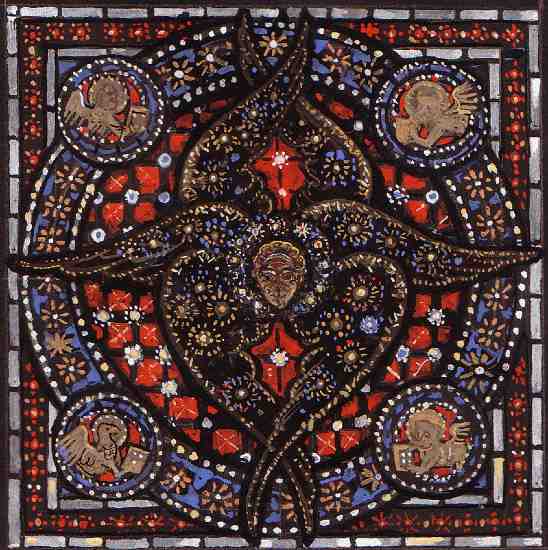Cos’è l’orrore in una società che sembra fatta di mostri in lotta tra loro, in uno scontro continuo tra il male e il peggio? Come narrare storie fatte di promesse mancate e i dialoghi senza voce? La scrittrice Lidia Riviello (“L’infinito del verbo andare”, 2002; “Sonnologie”, 2016), smontandone la tradizionale lettura catartica, inquadra l’horror nella sua essenziale capacità di far proliferare le immagini.
L’horror americano degli anni settanta e ottanta trae la sua origine dalla propria fine. Nel circuito poco meno che molecolare delle sue immagini, la scena è altamente astratta, quasi sospesa fra vita e morte. In realtà, non c’è parallelismo, come invece si potrebbe pensare, tra lo stato euforico e quello immalinconente: piuttosto, uno fagocita l’altro in una circolarità continua e generatrice di rinvii all’eternità del quotidiano.
Ecco così il rifiuto del canone, a volte anche di quello cinematografico, il rifiuto della ‘buona storia’ e degli archetipi che di solito la reggono. Sullo schermo horror, quelli familiari, affettivi, eroici, ludici, còlti, vengono smantellati e deviati: tuttavia, non sono cancellati, e sulla membrana pellicolare restano impresse tutte le immagini, moltiplicate dalla presenza di autori diversi. Infatti, autore di tali specie di horror non è soltanto il regista, né solo lo sceneggiatore: lo sono soprattutto i fotografi e i truccatori, e gli artisti attori, che più sono mediocri nella recitazione, più rendono drammatica ed esemplare l’epica stordita dell’horror.
Altri autori sono poi chiamati con varie suggestioni. Spesso nei film horror di tale specie si fa diretta citazione di un classico della letteratura, agendo attraverso interruzioni con discorso diretto (allo spettatore): si nominano ed evocano Poe, i simbolisti, testi sacri e di antropologia culturale di diverse origini. C’è quindi una componente dialogica, fondamentale nell’horror più di quanto si creda: un dialogo, appunto, raccapricciante, nel senso di invadente ed estraneo. E sempre qualcosa di esterno rompe poi l’apparente fluidità degli interni, case, luoghi, legami.
Dentro ogni horror di questa specie abita una promessa mancata: una puerizia travolta, ingannata, derisa, espulsa. La puerizia torna nell’accidia del tempo intento a vendicarsi con ordini e modi ripetuti in atti seriali, e così recuperare le temps perdu, e quindi vivere. Sotto forma di molosso, ogni distruttore è la coda della vittima. Ogni vittima rimuove colpe passate; se non è colpevole, convive con una depressione sottesa, che alimenta confusione, banalità, luogo comune. Il molosso vendicatore diventa l’atto comico dell’insulsa tragediucola della comunità: college, villaggi, uffici, case.
Nell’horror, il singolo si stacca dalla coralità e dal gruppo e resta solo, analizzato in dettagli, tic, caratteristiche; si rivela ‘realmente vivo’ soltanto nell’atto finale o poco prima: e mai si sa quando davvero è finita. Di un finire barocco, esibizionista, morto sul vivo. Nel porno, a cui l’horror viene accostato come ‘genere di cassetta’, eros e feuilletton vengono superati attraverso la configurazione e moltiplicazione di identità che si confermano e si delegittimano di continuo, in modi particolarmente congeniali al genere.
Se tuttavia nella pornografia il corpo singolo si fonde nel corpo corale, nell’‘horrorografia’ al contrario si assiste allo stacco da quello corale del corpo singolo, costretto a seguire una strada tutta personale. Il porno digrada e strappa l’eros. L’horror contempla e media con più origini ed è molto più complesso: discende dal giallo, dal thriller, dalla narrativa, dal noir, e poi devia, prendendo una strada diversa, indisciplinata e spesso nichilista.
Eppure, ci sono le cose. Wes Craven dice che le cose dell’horror sono importanti, tanto se accadono nella mente, quanto fuori da questa: e aggiunge che queste cose vanno «fatte vedere». Come farle vedere rappresenta il problema: il perché farle vedere la miccia. Volto e maschera sono entrambi vulnerabili, si sovrappongono e scompaiono dietro il perché delle cose.
Non a caso, l’horror americano espelle il figlio indesiderato, diverso: per salvarlo, però. Diventa da vittima a carnefice, super-eroe senza elementi che lo connotino, spesso tra uomo e altro: animale, robot, pupazzo, sessualmente assente o dilatato. Con l’età ferma al trauma d’origine oppure invecchiato per metterlo senza successo al livello della sua vittima, vestito sempre con lo stesso abito anche questo datato al momento dello shock.
A questo dialogo la voce non serve: l’horror non ha voce. Il suono fa testo e struttura il tempo. Suono gutturale, in falsetto, mugugnato. Il mugugno è il correlato sonoro concreto del vuoto che ne rappresenta la spazializzazione effettiva. La composizione seriale è poi affidata a colonne sonore ebeti, stupide, cantilene, cori, suoni elettronici, ninne nanne in primis. E la mente si dilata.
L’horror dilata la mente al massimo delle possibilità superando il gusto, il limite, il problema del genere, dell’ideologia: esattamente come per le fiabe classiche, la morfologia dell’horror è alienata rispetto all’azione e reazione del soggetto che subisce un evento decisivo. Sono i divieti, gli allontanamenti, gli inganni, le investigazioni a dettare una legge. L’horror però spesso ribalta questa legge perché agisce attraverso il ricatto del proprio ‘essere un genere seriale’ spesso svalutato, sottoclassato, strumentalizzato, ritenuto un divertissment per ossessionati, manipolato come metodo paraterapeutico per smitizzare paure e angosce. Ed è questo l’‘error ideologico’ al quale la teoria di ‘horror dialogico’ qui proposta ha cercato di porre rimedio.
Eppure, l’anticonformismo dell’horror viene rivelato anche dalla sua astensione obbligata dal panorama delle discussioni ‘di significato’, nel cinema come nella letteratura, nella filosofia come nell’arte, così nel vasto sottofondo sopramondo della rete. Non si classifica l’horror se non nella sua prima interpretazione: poi, viene ignorato, declassato. Ed è proprio questo a consentire al genere di ‘degenerare’ e durare al di là del prototipo, mentre la dilatazione delle e nelle immagini horror permette la conoscenza e la ricerca di altri modi di guardare lo schermo e le sue immagini.
•
Immagine: Mia Farrow in “Rosemary’s Baby” (1968), film diretto da Roman Polanski ed estratto dall’omonimo romanzo di Ira Levin (1967).